Gli Anni '10
1910-19
Cronologia
1910
- In Inghilterra sale al trono Giorgio V, che regnerà fino al 1936.
- In Portogallo, dove il regime costituzionale era una pura facciata, si instaura, in seguito ad un’insurrezione, una repubblica progressista, che non riuscì né a dare stabilità al paese né a modificarne le vecchie strutture sociali.
- Sommosse contadine in Cina: “rivolta del riso” a Changsha e moti rivoluzionari nello Shantung.
- Il Giappone annette ufficialmente la Corea, instaurandovi un regime militare.
- Esce La suceción presidencial di Francisco Madero, che si candida alla presidenza del Messico. Ma nel giugno Diaz lo fa arrestare, riappropriandosi della carica. Madero è poi scarcerato ed elabora il programma di San Luis Potosì.
- Esce il manifesto della pittura futurista firmato da Balla, Carrà, Boccioni e Russolo.
- Esce il saggio di Kandinskij Sullo spirituale dell’arte.
- Mostra degli iniziatori del movimento cubista al Salon des Indépendants a Parigi.
- Henri Matisse dipinge La danse.
- Esce Mafarka il futurista, romanzo di Filippo Tommaso Marinetti.
- Esce il secondo Manifesto della letteratura futurista.
- I dirigibili Zeppelin realizzano il primo servizio aereo di trasporto passeggeri collegando alcune città della Germania.
- Marie Curie ottiene dalla pechblenda il radio allo stato metallico.
- Fa la sua comparsa nel paesaggio urbano d’America e d’Europa la lampada al neon.
- Nasce a Long Island il primo “model suburb” di New York, il “Forest Hills Gardens”, che sarà presto seguito da altri quartieri-giardino nelle maggiori città americane.
- In Italia gli impiegati statali (burocrati) sono il 10% della popolazione (quasi tre milioni).
- Nove milioni di emigranti, provenienti da tutta Europa, ma soprattutto da Irlanda, Germania, Italia e dal mondo ebraico, arrivano negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni.
- Violento e prolungato sciopero dei minatori in Inghilterra.
- In Francia, sciopero dei ferrovieri. Il governo di Aristide Briand ordina l’arresto degli organizzatori e la militarizzazione del personale.
- Le donne parigine sostituiscono il busto con il reggiseno.
- A Londra, in Oxford Street, si inaugurano i grandi magazzini Selfridges e a Parigi i Primtemps.
1911
- L’Italia, animata da una campagna nazionalista favorevole all’intervento in Libia, dichiara guerra alla Turchia per il possesso della nazione nordafricana che invade. Per la prima volta un aeroplano, pilotato dal capitano italiano Carlo Maria Piazza, viene usato in guerra.
- La Francia occupa Fez in Marocco e l’imperatore tedesco Guglielmo II invia nella baia di Agadir la nave militare Panther, provocando la seconda crisi marocchina. La Germania ottiene come risarcimento parte dei territori del Congo francese.
- Apis fonda la “Mano Nera”, l’associazione clandestina serba che mira alla formazione di una nazione slava.
- Il movimento rivoluzionario antimanciù, sostenuto dal Kuomintang, si estende a tutta la Cina meridionale; insurrezioni a Nanchino, Shanghai e Canton. Le provincie centro-meridionali si dichiarano indipendenti da Pechino. Sun Yat-sen rientra dall’esilio e sbarca a Shanghai.
- Maggio: in Messico Diaz si dimette. De la Barra viene nominato presidente provvisorio. Nuove elezioni presidenziali a novembre, Madero viene eletto capo dello Stato. In dicembre scoppia la rivolta contadina guidata da Emiliano Zapata.
- In Germania Kandinskij fonda il movimento Der Blaue Reiter (“Il cavaliere azzurro”) con l’intento di sostenere, attraverso grandi mostre internazionali, tutte le tendenze dell’arte.
- Comincia il periodo del cubismo sintetico di Pablo Picasso.
- Carlo Carrà, pittore futurista, dipinge I funerali dell’anarchico Galli.
- Giorgio De Chirico a Parigi dipinge la serie delle Piazze e delle Torri.
- Il pittore russo Marc Chagall si trasferisce a Parigi.
- Walter Gropius e Adolf Meyer progettano la Fabbrica Fagus a Alfeld-an-der-Leine, un altro passo verso l’architettura del Movimento Moderno.
- In occasione della guerra di Libia, Gabriele D’Annunzio compone Le canzoni delle gesta d’oltremare.
- La Nestor Film Corporation fonda il primo studio cinematografico di Hollywood.
- Esce il saggio di estetica cinematografica Manifest de sept arts di R. Canudo.
- Esce a Vienna il Trattato d’armonia (Harmonielehre) di Schönberg.
- Escono i Principi di organizzazione scientifica del lavoro dell’americano Frederick Winslow Taylor.
- Vengono costruite le prime filovie urbane.
- A. Einstein enuncia il principio di equivalenza delle forze inerziali e gravitazionali, primo ampliamento della teoria della relatività ristretta.
- E. Rutheford elabora il modello dell’atomo costituito da un nucleo intorno a cui ruotano gli elettroni.
- In Inghilterra viene costruito il primo aereo bimotore.
- In America viene costruito il primo idrovolante.
- Nascono i partiti laburisti in Australia e Nuova Zelanda.
- 8 novembre: a Londra una delegazione di donne, guidata dalla Emmeline Pankhurst, viene brutalmente caricata dalla polizia a cavallo mentre si reca dal primo ministro. Le suffragette rispondono con una serie di atti di violenza cui le autorità reagiscono chiudendo le sedi del movimento e arrestando migliaia di donne militanti.
- Coco Chanel inventa i cappelli a cloche.
1912
- Con la Convenzione di Fez viene istituito ufficialmente il protettorato francese sul Marocco; la Germania guadagna in cambio una parte del Congo francese.
- 23 febbraio: In Italia la Camera decreta l’annessione della Libia. Congresso socialista di Reggio Emilia: svolta rivoluzionaria. Viene espulso Bissolati. Mussolini è direttore dell’ “Avanti!“
- E’ introdotto il suffragio universale maschile.
- Marzo: sotto la spinta della Russia viene creata la prima Lega balcanica a cui aderiscono Serbia, Bulgaria, Grecia e Montenegro.
- Marzo: in Messico la rivolta al nord di Pascual Orozco è sedata dall’esercito federale. Fallisce a Veracruz un tentativo controrivoluzionario di Felix Diaz, nipote dell’ex presidente (ottobre).
- Ottobre: pace di Losanna tra Turchia e Italia. L’Impero ottomano riconosce la sovranità italiana in Libia.
- Ottobre: il Montenegro dichiara guerra all’Impero Ottomano e dà il via alla prima guerra balcanica.
- In Inghilterra concessione dell’Home Rule (autogoverno) all’Irlanda, a esclusione del nord del paese, il cui centro è Belfast.
- Viene proclamata a Nanchino la Repubblica cinese; Sun Yat-sen diventa presidente provvisorio. La dinastia Manciù rinuncia al trono, il generale nazionalista Yuan Shih-K’ai diventa presidente della Repubblica al posto di Sun Yat-sen.
- Duchamp dipinge Nu descendant un escalier, un quadro di rottura come lo era stato cinque anni prima Les demoiselles d’Avignon.
- Il pittore francese Robert Delaunay crea all’interno del movimento cubista la corrente detta dell’Orfismo.
- A Parigi nasce lo studio cinematografico di Leon Gaumont con teatri di posa, laboratori di sviluppo e stampa e officine meccaniche.
- Cecil De Mille gira il suo primo film, The Squaw Man, inaugurando i nuovi studi di Hollywood.
- Prima, a Berlino, di Pierrot lunaire di Schönberg, fischiata dal pubblico. L’opera, manifesto della nuova musica atonale, introduce una scrittura strumentale e moduli di espressione vocale chiamati “recitativi cantati”, per l’epoca assolutamente rivoluzionari.
- Il blues appare per la prima volta con il suo vero nome e su carta stampata con la pubblicazione della canzone Memphis Blues scritta da William Christopher Handy.
- Muore all’età di 63 anni Johan Strindberg, poeta e drammaturgo svedese
- Esce Le forme elementari della vita religiosa di Émile Durkheim, sociologo francese.
- Esce Totem e tabù di S. Freud.
- Esce La libido, simboli e trasformazioni di C. G. Jung, opera che segna la rottura con Freud.
- Esce la Teoria dello sviluppo economico dell’economista cecoslovacco Joseph Alois Schumpeter.
- In Svizzera si costruisce la prima locomotiva con motore diesel.
- Escono Le sostanze radioattive e le loro radiazioni di E. Rutherford.
- VI congresso dei POSDR a Praga, culla del partito bolscevico.
- Molti emigranti provenienti dall’Europa partecipano alle agitazioni sociali che travagliano gli Stati Uniti di questi anni.
1913
- Febbraio: in Messico comincia la controrivoluzione. Huerta si allea con Diaz e entra a Città del Messico. Madero rassegna le dimissioni e viene poco dopo assassinato. Huerta diventa presidente. Il rivoluzionario Villa insorge contro Huerta.
- Maggio: a Londra, con la mediazione inglese e tedesca, si firma la pace per i Balcani che sancisce la sconfitta turca.
- Giugno: seconda guerra balcanica. La Bulgaria attacca la Serbia. A fianco di quest’ultima si schierano Romania, Grecia, Montenegro e Turchia.
- Agosto: pace di Bucarest, che pone fine alla seconda guerra balcanica: la Bulgaria perde la Macedonia e la Dubrogia.
- In Francia Raymond Poincaré diventa presidente della Repubblica. Clemenceau approva la politica revanscista dell’essere “pronti alla guerra”. E’ introdotta la leva triennale.
- In Italia, patto Gentiloni: accordo elettorale in funzione antisocialista tra cattolici e liberali moderati, promosso da Giolitti.
- Elezioni in Cina: larga maggioranza al Kuomintang (438 deputati), ma il nuovo presidente attua una controrivoluzione: esautora, scioglie il parlamento e mette in proscrizione il Kuomintang. Sun Yat-sen è costretto all’esilio.
- Negli Stati Uniti, presidenza di Woodrow Wilson, in carica fino al 1921. La sua elezione segna il ritorno dei democratici alla Casa Bianca. Riorganizzazione del sistema bancario e abbassamento delle tariffe protezionistiche.
- Si scioglie il gruppo Die Brücke.
- Il pittore russo Kazimir Malevic formula la poetica del Suprematismo.
- Giacomo Balla, pittore futurista, dipinge Velocità d’automobile più luce più colori.
- Umberto Boccioni espone a Milano la sua scultura futurista Forme uniche nella continuità dello spazio.
- Esce La strada di Swann di Marcel Proust, primo romanzo del ciclo Alla ricerca del tempo perduto.
- Esce il romanzo breve di Thomas Mann La morte a Venezia.
- Inizia la sua attività a New Orleans l’orchestra di jazz Original Dixieland Jazz Band.
- Escono le Idee per un fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica di E. Husserl.
- Le acciaierie Krupp, il più grande impero industriale d’Europa, impiegano 68.500 operai.
- Si conclude la pubblicazione dei Principia mathematica di B. Russell e A. N. Hitehead.
- Il fisico danese Niels Bohr sviluppa la teoria della struttura atomica su base quantistica.
- Le donne ottengono il diritto di voto negli Stati Uniti.
- A Epsom, durante il derby, muore Emily Davidson buttandosi sotto le zampe di un cavallo alla presenza del re Giorgio V che, commosso, concede l’amnistia alle suffragette detenute.
1914
- Aprile: in Messico truppe statunitensi occupano Veracruz (incidente di Ypiranga) nel tentativo di frenare la rivoluzione. Le armate rivoluzionarie costringono Huerta a dimettersi a luglio; Carranza assume l’autorità presidenziale.
- 28 giugno: a Sarajevo viene assassinato l’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando.
- 23 luglio: l’Austria-Ungheria invia al governo serbo un ultimatum di 48 ore. La Russia si schiera a difesa della Serbia in caso di attacco da parte dell’Austria-Ungheria. L’Impero asburgico ritiene insufficiente la risposta serba all’ultimatum e dà inizio alla mobilitazione.
- 28 luglio: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. La Russia inizia la mobilitazione generale.
- In Italia, dimissioni di Giolitti. Formazione del governo Salandra. Mussolini, espulso dal PSI perché acceso interventista. Fonda il giornale “Popolo d’Italia”.
- 1 agosto: la Germania dichiara guerra alla Russia e il 3 agosto alla Francia e inizia l’invasione del Belgio. Ancora, il 3 agosto l’Italia proclama la propria neutralità.
- 4 agosto: la Gran Bretagna, in seguito all’invasione del Belgio, dichiara guerra alla Germania.
- 5 agosto: il Montenegro dichiara guerra all’Austria-Ungheria.
- 6 agosto: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Russia. La Serbia dichiara guerra alla Germania.
- 8 agosto: il Montenegro dichiara guerra alla Germania.
- 12 agosto: Francia e Inghilterra dichiarano guerra all’Austria-Ungheria.
- 23 agosto: il Giappone dichiara guerra alla Germania e il 25 agosto all’Austria-Ungheria.
- 28 agosto: l’Austria-Ungheria dichiara guerra al Belgio.
- 4 settembre: i Tedeschi sono a pochi chilometri da Parigi.
- 6-13 settembre: battaglia della Marna: i Tedeschi sono fermati e costretti a ritirarsi.
- 29 ottobre: la Turchia attacca la Russia.
- 2-3 novembre: Russia, Serbia, Francia e Gran Bretagna dichiarano guerra alla Turchia.
- Escono le Impressioni e improvvisazioni di Kandinskij.
- Manifesto dell’architettura futurista a opera dell’architetto comasco Antonio Sant’Elia.
- Filippo Tommaso Marinetti scrive il poema futurista Zang, Tumb Tumb. Adrianopoli, ottobre 1912.
- A Hollywood Mack Sennet induce Charlie Chaplin a fare del cinema: esce il cortometraggio Making a Living.
- Esce il film colossal Cabiria di Giovanni Pastrone con B. Pagano nella parte di Maciste.
- Esce Introduzione al narcisismo di S. Freud, in cui questi apporta delle modifiche alla teoria degli istinti.
- Lo psicologo nordamericano John Broadus Watson dà una prima esposizione della dottrina del comportamento, il behaviourism, di cui verrà considerato caposcuola, pubblicando Il comportamento, introduzione alla psicologia comparata.
- Muore il filosofo americano Charles Peirce, fondatore del pragmatismo.
- Si inaugura il canale di Panama costruito e gestito dagli Stati Uniti. La nuova, importantissima arteria collega l’oceano Atlantico con l’oceano Pacifico. Il Canale è lungo 81 km. e largo da un minimo di 90 m. a un massimo di 350 m.
- Lenin da Berna imposta l’atteggiamento da seguire nei confronti della guerra.
- A Parigi è assassinato Jean Jaurès, deputato socialista, leader della SFIO, membro dell’Internazionale socialista.
- In Francia grande vittoria elettorale dei socialisti con un programma “contro la follia degli armamenti”.
- Esce su “Il Grido del Popolo” l’articolo di Gramsci, Neutralità attiva ed operante.
- Finisce la grande ondata migratoria che ha condotto in America e soprattutto negli Stati Uniti circa un milione di ebrei europei.
- Muore il pontefice Pio X; gli succede Giacomo Della Chiesa col nome di Benedetto XV.
- Dall’America Latina arriva in Europa il tango, popolare ballo argentino.
- Coco Chanel accorcia audacemente le gonne.
1915
- Gli Stati Uniti riconoscono Carranza come presidente del Messico.
- 17 febbraio: prima e fallimentare sperimentazione del carro armato da parte degli Inglesi. Un nubifragio rende impossibile ogni manovra. Il carro armato Mark I è chiamato in gergo tank (serbatoio) per disorientare lo spionaggio tedesco. Si tratta di un mezzo a forma di rombo con una velocità massima di 6 Km/h; pesa 25 tonnellate, è alto 2,5 metri, lungo 9,65 e largo 3,75. L’equipaggio è composto da 8 soldati con 6 mitragliatrici.
- 22 aprile: primo atto della guerra chimica moderna: i Tedeschi fanno uso di gas asfissianti contro i Francesi su un tratto di fronte nella regione di Ypres in Belgio e provocano 5.000 morti.
- Secondo attacco chimico dei tedeschi presso Ypres contro un contingente canadese.
- 26 aprile: patto di Londra tra l’Intesa e l’Italia.
- Il transatlantico Lusitania cola a picco, colpito da un sommergibile tedesco. Oltre 1.200 morti tra i quali molti cittadini americani.
- 24 maggio: l’Italia entra in guerra.
- La Bulgaria entra in guerra a fianco degli Imperi Centrali.
- Amedeo Modigliani dipinge Nudo disteso.
- Il pittore francese Marcel Duchamp espone i suoi primi ready-made.
- Escono i racconti Gente di Dublino di James Joyce.
- Esce l’Antologia di Spoon River del poeta americano Edgar Lee Masters.
- Esce Nascita di una nazione del regista americano David Wark Griffith.
- Il regista americano Cecil B. De Mille gira I prevaricatori.
- In Inghilterra viene costruito il primo aereo lanciasiluri.
- Il tedesco H. Junkers realizza il primo aeroplano interamente meccanico.
- Henry Ford avvia la produzione dei primi trattori agricoli.
- Conferenza dei socialisti democratici a Zimmerwald (Berna) e fondazione della Commissione socialista internazionale.
1916
- Gennaio: gli Zeppelin tedeschi effettuano un bombardamento su Parigi e su alcune città inglesi.
- 21 febbraio: inizio dell’attacco tedesco a Verdun.
- In Irlanda rivolta di Pasqua. I capi della United Irish League sono arrestati.
- 15 maggio: offensiva austriaca sugli altipiani, Strafexpedition.
- 31 maggio/1 giugno: battaglia navale al largo della penisola dello Jutland.
- 1 luglio: inizio della (prima) Battaglia della Somme in cui dagli inglesi viene usato per la prima volta il carro armato. Nel corso della guerra gli alleati costruiranno 7000 carri armati.
- La Romania dichiara guerra all’Austria-Ungheria.
- 27 agosto: l’Italia dichiara guerra alla Germania.
- 29 agosto: Von Hindenburg subentra a von Falkenhayn come capo di Stato Maggiore dell’esercito tedesco.
- 7 novembre: Wilson rieletto presidente degli Stati Uniti.
- Giorgio De Chirico dipinge Le muse inquietanti.
- Nascita del Dada, movimento artistico d’avanguardia.
- Esce il racconto lungo La metamorfosi dello scrittore ceco di lingua tedesca Franz Kafka.
- James Joyce scrive il romanzo Ritratto dell’artista da giovane.
- Esce Intolerance di D. W. Griffith.
- Esce il Trattato di sociologia generale di V. Pareto.
- Escono Le basi della teoria generale della relatività di A. Einstein.
- Edward Boeing fonda a Seattle, negli Stati Uniti, la prima fabbrica di aerei, la società Boeing.
- In Germania la sinistra del partito socialdemocratico dà vita alla Lega di Spartaco che si batte contro la guerra.
- Lucien Wolff, responsabile di un’organizzazione sionista, sottopone al governo britannica le richieste del popolo ebraico di poter “godere di libertà politica e religiosa” in Palestina qualora, alla fine della guerra, essa fosse inclusa nella sfera d’influenza di Inghilterra o Francia.
- Il ministro degli esteri inglese Edward Grey trasmette la richiesta degli ebrei agli ambasciatori di Francia e di Russia. Il governo russo fa subito sapere che desidera una sola garanzia: la piena libertà per gli ortodossi in Palestina.
1917
- In Olanda, dove regna la regina Guglielmina (1890-1948), viene introdotto il suffragio universale maschile.
- 1 febbraio: la Germania dichiara la guerra sottomarina a oltranza.
- 3 febbraio: rottura delle relazioni diplomatiche tra Germania e USA.
- 8 marzo (23 febbraio secondo il calendario russo): in Russia, a Pietroburgo, scoppia la rivoluzione russa di febbraio. Lo zar Nicola II abdica e viene arrestato con la famiglia. Kerenskij, capo dei socialisti riformisti, forma un governo provvisorio (15 marzo), che scatena una campagna contro i bolscevichi.
- Aprile: Lenin torna in Russia dall’esilio, in un vagone piombato, con il permesso tedesco.
- 6 aprile: dichiarazione di guerra degli USA alla Germania.
- 1° agosto: papa Benedetto XV si appella ai governi perché mettano fine all’“l’inutile strage”.
- 24 ottobre: gli Italiani sono sconfitti a Caporetto.
- 27-31 ottobre: la **ritirata italiana raggiunge il fiume Tagliamento (Battaglia di Ragogna**); in seguito si arresta sulla linea Grappa-Montello-Piave. Il generale Diaz sostituisce Cadorna come capo di Stato Maggiore dell’esercito.
- 7 novembre (ottobre per il calendario russo): scoppia la Rivoluzione di ottobre. I soviet si impadroniscono del potere, che viene affidato al Consiglio dei commissari del popolo, presieduto da Lenin e di cui fanno parte Trotzkij e Stalin.
- 7 dicembre: gli USA dichiarano guerra all’Austria-Ungheria.
- 15 dicembre: armistizio di Brest-Litovsk tra Russia e Germania.
- Piet Mondrian, pittore olandese, dipinge la Composizione in blu, uno dei primi quadri astrattisti.
- Nasce a Mosca il gruppo artistico d’avanguardia del Costruttivismo.
- Theo Van Doesburg, architetto e pittore, e Piet Mondrian fondano a Leida la rivista “De Stijl”, organo dell’omonimo movimento artistico detto anche neoplasticismo.
- Esce Introduzione alla psicoanalisi di S. Freud.
- Finisce la costruzione della ferrovia Transiberiana lunga 9.426 km.
- In Francia viene ripubblicata, con alcune modifiche e integrazioni, la Cité industrielle, che riscuote maggiore successo della prima edizione.
- Il ministro degli esteri inglese, Balfour, si dichiara a favore dell’istituzione di uno Stato nazionale ebraico (National home) in Palestina.
1918
- La Svezia, dove il suffragio universale maschile era già in vigore da anni, estende i diritti elettorali anche alle donne.
- 3 gennaio: il presidente degli USA Wilson illustra i suoi “14 punti” per la pace mondiale.
- 3 marzo 1918: pace di Brest-Litovsk tra Russia e Germania.
- 21 agosto - 3 settembre: Seconda battaglia sulla Somme, avanzata inarrestabile della linea Alleata.
- 15-23 giugno: seconda battaglia del Piave (battaglia del solstizio), gli Austriaci sono respinti.
- 29 settembre: armistizio tra la Bulgaria e l’Intesa.
- 20 ottobre: Wilson esige il riconoscimento dell’autonomia dei popoli dell’area danubiana.
- 24-30 ottobre: battaglia di Vittorio Veneto sul fronte italiano.
- 29 ottobre: nasce lo Stato degli Sloveni, Croati e Serbi.
- 30-31 ottobre: la Turchia firma l’armistizio.
- 3 novembre: reparti italiani entrano a Trento e Trieste. L’armistizio tra l’Italia e l’Austria-Ungheria a Villa Giusti segna il crollo definitivo dell’impero asburgico.
- 6 novembre: proclamazione della Seconda Repubblica Polacca.
- 9 novembre:** Guglielmo II abdica**. Nasce a Berlino la Repubblica Tedesca di Weimar. Il governo tedesco propone l’armistizio a Wilson.
- 11 novembre: armistizio di Compiégne tra la Germania e l’Intesa.
- 12 novembre: proclamazione della Repubblica Austriaca.
- 16 novembre: proclamazione della Repubblica Ungherese.
- Rottura delle relazioni diplomatiche fra USA e Russia sovietica.
- Muore il pittore austriaco Gustav Klimt, massimo rappresentante della Secessione viennese.
- Esce Il mistero buffo di Vladimir Majakovskij, massimo esponente del futurismo russo.
- Max Weber, sociologo tedesco, ottiene la cattedra di sociologia a Vienna.
- In Germania scoppiano ammutinamenti nell’esercito e nella flotta, seguiti da una rivolta popolare a Kiel, che si propaga in tutto l’impero. A Monaco e a Berlino si costituiscono i consigli degli operai e dei soldati, sull’esempio dei soviet.
- Diritto di voto alle donne in Inghilterra.
- Fondazione della prima Università ebraica in terra palestinese.
- Prime elezioni a suffragio universale in Inghilterra e in Danimarca.
- Grave inflazione in Germania, Austria e Ungheria.
- In Inghilterra, il People Act accorda il diritto di voto alle donne sopra i trent’anni.
1919
- Il Giappone ottiene i territori cinesi sottratti ai tedeschi.
- Michael Collins fonda l‘**Esercito Repubblicano Irlandese (IRA**).
- 18 gennaio: si apre a Versailles la Conferenza di Pace: sono presenti solo le potenze vincitrici.
- Le condizioni del trattato sono rimesse alla delegazione tedesca, che tenta di ottenere condizioni meno dure.
- 28 giugno: accettazione del trattato da parte tedesca.
- 10 settembre: firma del trattato di pace con l’Austria a St. Germaine en Laye.
- 27 novembre: firma del trattato di pace con la Bulgaria a Neuilly. La Bulgaria cede parte della Macedonia alla Jugoslavia e la Tracia occidentale alla Grecia, e viene così privata dell’accesso al mare Egeo.
- Benito Mussolini fonda a Milano i “Fasci italiani di combattimento”, primo nucleo del movimento fascista.
- Prima impresa squadrista dei fascisti: viene incendiata la sede del quotidiano socialista “Avanti!”. A partire da questa data le violenze delle squadre fasciste aumentano di intensità e di numero.
- La delegazione italiana, guidata da Vittorio Emanuele Orlando e da Sidney Sonnino, abbandona la Conferenza di pace di Versailles in seguito ai disaccordi sulla “questione di Fiume”.
- Il poeta e agitatore politico nazionalista Gabriele D’Annunzio alla guida di un gruppo di volontari occupa la città di Fiume e ne assume il potere politico (è la cosiddetta “reggenza del Carnaro”).
- Nasce dall’unione di alcune organizzazioni di estrema destra il Partito operaio tedesco.
- Adolf Hitler aderisce al Partito operaio tedesco.
- Nasce il Movimento nazionale turco sotto la guida del generale Mustafa Kemal.
- In Cina scoppiano le agitazioni nazionaliste con il “movimento 4 maggio” a seguito delle notizie giunte da Versailles sulla cessione al Giappone dello Shantung.
- La delegazione cinese a Versailles rifiuta di firmare i trattati di pace.
- Il pittore tedesco Max Ernst pubblica la serie dei collages fatagaga (esempi di non senso assoluto).
- La nascita del Bauhaus, “corporazione di artigiani e artisti per la fusione in una sola forma di pittura, scultura e architettura”, segna la fine dell’Art nouveau.
- Marcel Proust scrive All’ombra delle fanciulle in fiore.
- Esce il racconto Nella colonia penale di Franz Kafka.
- Il regista tedesco Robert Wiene realizza il film espressionista Il gabinetto del dottor Caligari.
- Con l’entrata in guerra degli americani fa la sua prima apparizione in Europa la musica jazz, conquistando molti giovani musicisti.
- Muore di cancro all’età di 56 anni Claude Debussy.
- Esce Le conseguenze economiche della pace dell’economista inglese J. M. Keynes.
- Esce Introduzione alla filosofia matematica di B. Russell.
- Ernest Rutherford realizza la prima trasmutazione indotta: ottiene azoto bombardando ossigeno con raggi alfa.
- Il dirigibile inglese R34 compie la doppia traversata dell’Atlantico.
- Esce I dieci giorni che sconvolsero il mondo del giornalista americano John Reed sulla rivoluzione bolscevica.
- Il pittore francese Fernand Léger, seguace del movimento cubista, dipinge Uomini nella città.
- Nella Russia dei Soviet, Lenin firma il decreto per la nazionalizzazione dell’industria cinematografica zarista.
- La Gran Bretagna progetta la prima portaerei Hermes.
- A Mosca viene fondata la Terza Internazionale da Lenin e dai bolscevichi russi, che adotta un programma di rivoluzione mondiale.
- Il presidente americano Woodrow Wilson introduce una legge restrittiva sull’immigrazione, accordando il permesso d’ingresso solo a coloro che sanno leggere e scrivere.
- Le donne ottengono il voto in Germania, Austria, Cecoslovacchia, Olanda e Svezia.
- Nel primo giro d’Italia del dopoguerra si impone tra tutti il “campionissimo” italiano Costante Girardengo.
- In Italia tumulti contro il caro vita nelle città e occupazione delle terre nel Mezzogiorno.
- Affermazione del Partito popolare e del Partito socialista nelle primi elezioni italiane con suffragio universale maschile e sistema proporzionale.
- Movimenti contadini nell’Europa orientale.
- Negli Stati Uniti primo sciopero generale cittadino a Seattle; milioni di scioperanti nelle miniere di carbone e nell’industria metallurgica.
- Sciopero di Winnipeg in Canada.
- Generale aumento dei prezzi e dei salari. Concessione o conquista della giornata lavorativa di 8 ore in Europa, America e Giappone.
Nel Mondo
L’imperialismo

La famosa vignetta del New York Journal (1902): l'ordine del generale J. H. Smith di sparare a chiunque avesse almeno dieci anni d'età suscitò una profonda scossa nell'opinione pubblica durante la guerra fra Filippine e Stati Uniti
Alla base del fenomeno noto come “imperialismo” si pone quella progressiva espansione politica, economico-finanziaria e militare delle principali nazioni europee, degli Stati Uniti e del Giappone che si attua su scala planetaria a partire dalla metà dell’Ottocento. L’impressionante sviluppo degli apparati produttivi, verificatosi in questi paesi in particolare durante la “seconda rivoluzione industriale” a cavallo tra i due secoli, dà vita ad un’inedita fusione di varie tendenze: le mire espansionistiche dei grandi gruppi economici; l’aggressività dei governi in politica estera; il radicamento di correnti culturali apertamente prevaricatrici e razziste che, in nome di un rigido determinismo evoluzionistico, preconizzano la necessaria sottomissione di paesi e popoli più deboli militarmente ed economicamente a quelli invece più dotati ed emergenti. Rispetto al passato il nuovo modello imperialista ripercuote i propri effetti anche sulla politica interna delle varie potenze: la configurazione industriale trasforma in profondità le strutture sociali, determinando nuovi e drammatici fenomeni di urbanizzazione, di depauperamento e di oppressione classista; tutto ciò muta il panorama politico interno con la nascita ad esempio dei partiti socialisti che fanno della prospettiva rivoluzionaria il cardine della propria strategia politica.
Alla vigilia della prima guerra mondiale il continente asiatico e africano risultano completamente saturati dall’espansionismo delle potenze europee e dal Giappone, mentre l’America Latina si avvia a diventare il “cortile di casa” della potenza economica e politica statunitense. Una saturazione che sfocerà tragicamente nel primo conflitto mondiale.
Un mondo eurocentrico

Manifesto di propaganda della guerra franco-magasce
Nel 1878 alla Conferenza di Berlino venne sancito il principio di “concerto europeo”: si intendeva denominare con questi termini un’ideologia di collaborazione e unitarietà basata sostanzialmente sul riconosciuto ruolo egemonico della Germania e, più in generale, su un nuovo criterio di formazione degli stati nazionali. L’equilibrio che derivò dall’accettazione di questi principi diede vita al periodo di pace più duraturo nell’arco della storia europea. Tale clima collaborativo fu tuttavia messo in crisi in occasione delle aggressioni del Giappone ai danni della Cina, quando le varie nazioni si scoprirono in realtà disunite e potenzialmente conflittuali nelle scelte di politica estera. Inoltre il progressivo aumento dell’influenza statunitense nell’America del Sud e nel Pacifico causò per l’Europa la perdita del suo ruolo egemonico a livello internazionale. L’Africa era così rimasta l’unico continente su cui le nazioni europee potevano esercitare in modo esclusivo i propri tentativi di espansione, e proprio nell’ambito delle strategie politiche adottate nel continente africano nacquero i primi dissapori tra i paesi europei. Con le dimissioni forzate di Bismarck nel 1890 la Germania perse il ruolo di grande potenza che gli altri paesi le avevano riconosciuto, avviando un processo nel quale ciascun paese tenterà di conquistare un ruolo egemonico sugli altri. Sarà proprio questa spirale imperialista che condurrà alla Grande Guerra.
Patria organica e aggressività militare

Il campo di concentramento di Caserta, i figli degli ufficiali turchi prigionieri (1911)
Nei primi anni del XX secolo i movimenti nazionalisti sorti nei vari paesi europei assunsero caratteri sempre più radicali, indirizzandosi verso soluzioni autoritarie, reazionarie, classiste e auspicando la difesa dell’ordine costituito. Mentre la Gran Bretagna, grazie alla sua tradizione liberale, riuscì a limitare lo sviluppo di tali correnti ai soli programmi di Joseph Chamberlain, legati essenzialmente all’industria degli armamenti, in Francia nacque un movimento revanchista antitedesco che, sostenuto dagli ambienti clericali e militari, assunse caratteri monarchici ed apertamente antisemiti, dando vita a numerose organizzazioni nazionaliste. Panslavismo e pangermanesimo caratterizzarono le vicende politiche di Russia e Germania, dove prese corpo un nazionalismo di matrice tradizionale, che si fondava nel primo caso sulla volontà di riunire tutti i popoli slavi sotto un’unica entità politica (affermando inoltre il primato della chiesa ortodossa), mentre nel secondo sulle tradizioni imperiali della Germania. In Italia il nazionalismo ebbe caratteri più marginali e fu legato ad esponenti della borghesia intellettuale: sarà Corradini a fondare l’Associazione Nazionalista Italiana, le cui pressioni risultarono decisive in favore dell’impresa libica nel 1911 e dell’ingresso del paese nel conflitto mondiale.
Scoppia il primo conflitto mondiale

La foto della cattura di Gavrilo Princip (seconda da destra), in fuga dopo l'attentato al principe ereditario di Austria-Ungheria Francesco Ferdinando
Quando il 28 giugno 1914 lo studente nazionalista serbo Gavrilo Princip ferì a morte l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, destinato a succedere all’oramai anziano Francesco Giuseppe sul trono di Vienna, profonde e radicate tensioni internazionali attraversavano il globo da più di un decennio. Si tratta di un processo che condurrà Inghilterra e Germania, Francia e Austria, Russia e Turchia a combattere tra di loro, chi per la conquista e chi per la conservazione di quello “spazio vitale” economico, politico e militare che segnerà drammaticamente l’intera storia del Novecento. La corsa all’accaparramento di nuovi mercati e di copiose materie prime fu causa, all’inizio degli anni Dieci, dell’esplosione di numerosi focolai di tensione in Asia, in Marocco e in particolare nell’area balcanica, dove fin dalla metà dell’Ottocento gli attriti tra tendenze nazionaliste e corona asburgica si erano manifestati drammaticamente. Un complesso sistema di alleanze divideva nel 1914 il continente europeo e le rispettive aree di influenza in due parti: da un lato la Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), dall’altro la Triplice Alleanza (Austria e Germania, affiancate dall’Italia), ritenuta superiore militarmente soprattutto in virtù del prepotente sviluppo economico e tecnologico raggiunto dall’impero germanico. Quando il 28 luglio l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, caddero una dopo l’altra tutte le tessere del domino: la Russia corse in aiuto alla Serbia, la Germania dichiarò guerra alla Russia e di conseguenza alla Francia e all’Inghilterra, passando all’offensiva in Belgio; l’Inghilterra intervenne a fianco della Francia, l’Austria contro la Russia e il Giappone si schierò con l’Intesa in funzione antigermanica in Oriente. Tutto ciò nel breve volgere di circa venti giorni. In ottobre l’impero ottomano entrava in guerra a fianco di Austria e Germania. L’Italia sarebbe intervenuta, rovesciando la propria posizione a favore dell’Intesa, il 24 maggio 1915.
Le alleanze e l’idea di guerra breve

Carica di soldati tedeschi (1914)
I primi mesi di guerra dimostrarono drammaticamente, soprattutto sul fronte occidentale, che la natura del conflitto presente era profondamente mutata rispetto al passato. La Germania, in particolare, aveva basato la propria strategia sul concetto di Blitzkrieg (guerra-lampo), concretatosi nel piano Schlieffen, che avrebbe dovuto condurre, a seguito di una fulminea avanzata attraverso il Belgio, alla conquista ed occupazione dell’“odiata nemica”, la Francia. Tuttavia le truppe germaniche vennero bloccate sulla Marna, a 35 chilometri da Parigi, grazie alla frenetica mobilitazione francese e all’intervento dell’Inghilterra. Dall’altra parte, sul fronte est (che la strategia tedesca contava di aprire dopo un rapido successo ad ovest) l’esercito russo irrompeva nella Prussia orientale e nella Galizia austriaca tra l’agosto e il settembre 1914: Austria e Germania, costrette ad un repentino adattamento tattico, riuscirono a fermare le truppe zariste a Tannenberg e ai laghi Masuri, uscendo tuttavia sconfitti a Leopoli.

Un gruppo di soldati serbi sulla linea del fronte
La situazione divenne ancor più complessa quando la Turchia entrò a far parte del conflitto a fianco delle potenze centrali, bloccando così la comunicazione fra Russia e gli altri alleati dell’Intesa. Oltretutto gli imperi, nel tentativo di tagliare i rifornimenti alla Russia, si attestarono in difesa dei Dardanelli. Nell’aprile del 1915, di fronte allo sbarco di contingenti inglesi e australiani, i turchi dettero inizio ad una strenua difesa della penisola di Gallipoli. La battaglia, protrattasi quasi nove mesi e risoltasi in un enorme massacro, si concluse col ritiro delle truppe dell’Intesa. Dopo un anno e mezzo di guerra l’area balcanica, anche grazie all’intervento della Bulgaria a fianco degli austro-tedeschi, risultava largamente controllata dagli imperi centrali. Tuttavia, in rapporto ai piani strategici iniziali, il bilancio per il Reich e per la corona asburgica non era affatto positivo: ad ovest le operazioni si erano bloccate nel fango delle trincee, mentre ad est sia l’estensione territoriale che la conseguente inadeguatezza dei mezzi impiegati determinarono un’analoga situazione di stallo. Il fallimento della guerra-lampo sanciva così l’inizio, su entrambi i fronti, di una tragica ed inaudita guerra di logoramento.
L’Italia in guerra

Vignetta satirica sulla neutralità italiana: Vittorio Emanuele (al centro) assiste al tiro alla fune fra Imperi centrali e le nazioni dell'Intesa
La posizione italiana allo scoppio del conflitto risentiva del carattere difensivo dell’accordo che la legava all’Austria e alla Germania fin dal 1889: in effetti la scelta della neutralità era incentrata sulla consapevolezza da parte di politici liberali quali Giolitti e Salandra sia dell’illiceità di un intervento a fianco degli imperi centrali che, più pragmaticamente, della possibilità di poter concretizzare attraverso vie diplomatiche le aspirazioni italiane su Trento, Trieste, Istria, Dalmazia, e forse sull’Albania. Tuttavia nei dieci mesi che precedettero l’ingresso in guerra, il composito fronte interventista (nazionalisti, conservatori, democratici, irredentisti, socialisti rivoluzionari) pur minoritario nelle istituzioni e nel paese, riuscì a volgere la situazione in proprio favore, attraverso uno spregiudicato utilizzo di metodi di comunicazione politica basati su elementi irrazionali ed emotivi che ne preannunciano la nascente dimensione di massa. Nel maggio 1915, anche a causa del decisivo orientamento interventista del re, l’Italia entrò in guerra a fianco dell’Intesa: le rivendicazioni territoriali, fatta eccezione per Fiume, venivano garantite dal Patto di Londra, firmato segretamente dal ministro degli Esteri Sidney Sonnino. Le truppe italiane, attestate su un fronte di 600 km dal Trentino all’altopiano del Carso, riuscirono, comandate dal generale Cadorna, a guadagnare posizioni, prima di subire, nel corso del 1916, la pesante Strafexpedition (spedizione punitiva) dell’ex-alleato austriaco. Anche su questo fronte le operazioni ristagnarono in un sanguinoso e snervante equilibrio, nel quale enormi perdite umane furono il prezzo per la conquista di pochi chilometri di terreno.
Una guerra senza precedenti

Paradossale immagine in cui si accosta la innovativa tecnologia del carro armato all'uso del piccione quale mezzo di comunicazione con le retrovie, Albert, agosto 1918.
Il primo conflitto mondiale per le sue caratteristiche costituì un evento del tutto inedito se messo in confronto con le precedenti esperienze belliche.
Gli sono stati attribuiti gli aggettivi ‘mondiale’ e ‘grande’ e infatti ‘Grande guerra’ è la definizione sufficiente per individuarla.
Fu grande per il numero di soldati e di nazioni impegnate, per il numero di morti, per la quantità e il tipo di mezzi impiegati.
Prima di allora nessun conflitto aveva visto un tale spiegamento di forze né aveva assunto caratteri simili: i morti furono numerosissimi fin dai primi mesi di combattimento e alla fine del conflitto se ne contarono, approssimativamente, 9 milioni, e i feriti erano stati circa 21 milioni. Il paese che riportò più perdite fu la Germania, che ebbe quasi due milioni di morti; Russia, Francia, Austria-Ungheria e Inghilterra ebbero da 1 milione e 700 a 1 milione di morti. Minori, ma sempre ingenti, i soldati caduti per Italia, Serbia, Turchia, Romania, e Stati Uniti.
La guerra di trincea

Una trincea britannica sul fronte macedone
La prima guerra mondiale mise i comandi militari di fronte all’evidenza di una nuova situazione bellica, della quale mancarono spesso di prendere coscienza. Dopo il rapido fallimento della guerra lampo, i fronti, soprattutto quello occidentale, si assestarono su linee di centinaia di chilometri di trincee, reticolati di filo spinato e fortificazioni.
La strategia delle “grandi spallate”, che in Italia ebbe nel generale Cadorna il suo principale fautore, comportò perdite enormi in entrambi i campi. Dopo lunghissime e logoranti attese in mezzo al fango, i soldati venivano lanciati in giganteschi assalti sanguinosi e spesso suicidi, sotto il fuoco delle mitragliatrici, col risultato di poche centinaia di metri conquistati.

Soldati russi in trincea
Il nuovo scenario rappresentato dalla trincea costituì in tutti i sensi il “luogo” simbolo della prima guerra mondiale: se da un lato il logoramento psicologico causò numerosissimi casi di insubordinazione duramente repressi dagli stati maggiori, dall’altro il forzato livellamento delle differenti estrazioni sociali e culturali dei soldati produsse quell’identità di “camerata” che costituì nel dopoguerra uno dei principali richiami collettivi fatti propri da movimenti politici della destra eversiva come lo squadrismo fascista in Italia e i Freikorps in Germania.
Le grandi offensive

Truppe russe in marcia sul fronte orientale
La prima guerra mondiale, per eccellenza conflitto di trincea, di logoramento e di repentini quanto spesso improduttivi e sanguinosissimi attacchi frontali, introdusse innanzitutto profondi mutamenti nell’estensione temporale delle battaglie. Infatti se fino ad allora erano coincise al massimo con l’arco di qualche giornata, nel conflitto mondiale le battaglie si protraevano estenuanti per mesi e mesi senza che un esercito riuscisse a piegare definitivamente il nemico, tutto ciò al prezzo di quotidiani e devastanti massacri. Il carattere decisivo assunto di volta in volta da tali battaglie nella propaganda civile e militare rivestiva un ruolo prettamente ideologico e strategico, nel tentativo cioè di motivare in maniera plausibile una condotta altrimenti insostenibile per masse di soldati costrette ad una snervante situazione di stallo seguita da immani ed inspiegabili carneficine.
Tra l’inizio del 1916 e la metà del 1917 tre grandi battaglie di terra ebbero, pur in maniere differenti, un peso rilevante sulle sorti del conflitto: le battaglie di Verdun e La Somme tra gli eserciti francese e tedesco e quella di Caporetto sul fronte italiano. L’unica battaglia navale che si ripercosse sull’andamento della guerra fu quella dello Jütland, mentre il fronte orientale non conobbe scontri dalle dimensioni così immani come quelli appena citati.
Verdun

Devastazioni alla base di Quota 304, nella battaglia di Verdun che durò 11 mesi
Il 25 febbraio 1916 l’esercito tedesco, guidato dal generale Erich von Falkenhayn, mosse all’attacco della fortezza di Verdun, principale caposaldo della linea di difesa francese. A quella data i fronti erano bloccati da circa un anno e la Germania, pur consapevole della propria minore disponibilità di uomini e di risorse rispetto agli avversari, decise di tentare una guerra di logoramento che sbaragliasse prima l’esercito francese, per piegare poi quello inglese. La battaglia fu preannunciata dal bombardamento di artiglieria più imponente dall’inizio della guerra; dopo quattro giorni, nonostante che due linee fortificate difendessero la città, i francesi furono costretti ad arretrare abbandonando il forte di Douamont, bastione centrale di Verdun, nelle mani del nemico. Il controllo dell’esercito francese passò da allora nelle mani del generale Pétain, che riuscì a risollevare il morale delle truppe e ad assicurarsi nuovi rifornimenti e ulteriori contingenti. La battaglia, nella zona di Mont Homme, si protrasse ininterrottamente fino al dicembre 1916, quando l’offensiva tedesca venne bloccata giungendo alla riconquista di Douamont: 6000 soldati tedeschi vennero fatti prigionieri. Ciononostante, nessuno dei due eserciti uscì vittorioso dalla battaglia, eretta così a simbolo della insensata crudeltà della prima guerra mondiale: in circa un anno di scontri caddero 700.000 uomini, senza che vi fosse alcun vincitore.
La Somme

Truppe britanniche balzano fuori dalla loro trincea, ore 07:30 del 1º luglio 1916; ha inizio la battaglia della Somme
Mentre era in corso la battaglia di Verdun gli eserciti degli Alleati (Francia e Inghilterra) furono mandati all’attacco nella zona della Somme, dov’erano più munite le fortificazioni tedesche. In quest’occasione gli inglesi utilizzarono per la prima volta il carro armato e, ripetendo la strategia usata dai tedeschi a Verdun, fecero precedere l’assalto da raffiche di quasi due milioni di proiettili. La Germania rispose con un contro bombardamento provocando nel primo giorno di assalto 65.000 morti nelle fila dell’esercito inglese.

Un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale con indosso il nuovo elmo Stahlhelm
Anche La Somme fu una battaglia in cui gli eserciti riuscirono a conquistare reciprocamente e alternativamente solo poche miglia di terreno nemico: quando all’inizio del 1917 i tedeschi si ritirarono lungo la linea di resistenza Hindenburg, le perdite ammontavano a 400.000 uomini per l’esercito inglese, 200.000 per quello francese e quasi 600.000 per quello tedesco. La Somme rappresentò una vittoria per Francia e Gran Bretagna, ma fu comunque una battaglia di logoramento nella quale caddero centinaia di migliaia di uomini, e in cui la superiorità militare si dimostrò insufficiente a garantire una vittoria risolutiva.
1917, l’anno cruciale

I diplomatici degli Imperi centrali e della Russia al momento della firma. A sinistra, i rappresentanti degli Imperi centrali: Hakki Pascha (Impero Ottomano), von Merey (Austria-Ungheria), Leopoldo di Baviera ed il generale Hoffmann (Germania), Oberst Gawtschew (Bulgaria). Alla destra del tavolo, la delegazione sovietica: Lev Kamenev, Joffe, Bizenko, l'ammiraglio Altfater
Nel 1917 la Russia bolscevica firmò l’armistizio uscendo dalla guerra e gli Stati Uniti intervennero a fianco dell’Intesa.
Prima di questi fatti, che si riveleranno decisivi per la conclusione del conflitto, tra il 1916 e il 1917 sul fronte orientale gli eserciti erano ormai esausti e stremati tanto da essere incapaci di compiere mosse offensive risolutrici. Divennero frequenti gli episodi di insubordinazione che palesavano sempre più la debolezza degli antichi imperi. Nel mese di dicembre, sul fronte egiziano, l’esercito inglese riusciva a spingersi oltre Gaza, a conquistare Gerusalemme e ad avanzare verso Damasco. Il luogotenente del generale Edmund Allenby, Thomas Edward Lawrence, detto Lawrence d’Arabia, fu capace di suscitare una serie di rivolte degli Arabi contro i Turchi. Le sue gesta rimangono immortalate nel suo diario-romanzo I sette pilastri della saggezza.
In questa cornice si inserisce il crollo dell’impero russo nel quale le sconfitte subite e le rivoluzioni di febbraio e di ottobre fecero cadere lo zar e instaurare il governo bolscevico. Le trattative di pace condussero, nel 1918, alla pace di Brest-Litovsk con la quale la Russia perse Finlandia, Polonia, stati baltici e Ucraina. La Romania capitolò nel maggio successivo.
Per l’Italia il 1917 fu l’emblema della sua fragilità interna, evidenziata da scioperi e rivolte contro il caroviveri e la guerra, dalla Nota contro il conflitto scritta da papa Benedetto XV, e dalla disfatta di Caporetto che rappresentò la “miopia strategica”. Da quel momento si riorganizzò la propaganda, si accolsero gli aiuti degli alleati e sul Piave e a Monte Grappa gli eserciti dimostrarono capacità di resistenza. A Vittorio Veneto, tornando all’offensiva, gli austriaci furono invece sconfitti definitivamente.
La superiorità delle forze alleate con l’Intesa si rivelò decisiva per le sorti della guerra poiché fu possibile chiudere gli imperi centrali in un blocco economico e commerciale, costringendoli alla resa.
Caporetto

Tubi lancia-gas tedeschi. Queste armi verranno utilizzate per sfondare le linee italiane tra Plezzo e l'Isonzo
La “spedizione punitiva” austriaca contro l’ex-alleato italiano, sferrata nel maggio 1916, vide l’esercito italiano capace di fermare l’avanzata nemica e di riconquistare l’altopiano della Bainsizza e del Monte Santo. Ma, a partire dal 1917, man mano che diminuiva la pressione sul fronte orientale a seguito dell’indebolirsi dell’esercito russo, gli austriaci poterono spostare maggiori contingenti sul fronte italiano, “sfondando” a Caporetto nell’ottobre del 1917.

Una delle prime trincee scavate nell'argine destro del Piave nell'ottobre - novembre 1917
La battaglia rappresentò inizialmente una semplice breccia nella linea difensiva italiana, ma a causa dell’incapacità dei vertici militari, si trasformò in una gigantesca disfatta. L’esercito si diede alla fuga e gli austriaci penetrarono per oltre 150 km nel territorio italiano occupando intere province venete. I morti furono 400.000, cui si devono aggiungere prigionieri e feriti: i vertici militari, veri responsabili della disfatta, l’attribuirono invece alla codardia dei soldati. Alla crisi militare seguì una crisi politica, che portò alla formazione di un governo di unità nazionale, guidato da V. E. Orlando e appoggiato dai socialisti neutralisti. Inoltre il generale Cadorna venne destituito e il comando passò al generale Armando Diaz, il quale, coi giovanissimi “Ragazzi del ‘99” riuscì a fermare l’avanzata austro-tedesca nella pianura padana.

Prigionieri italiani a Cividale
Jütland
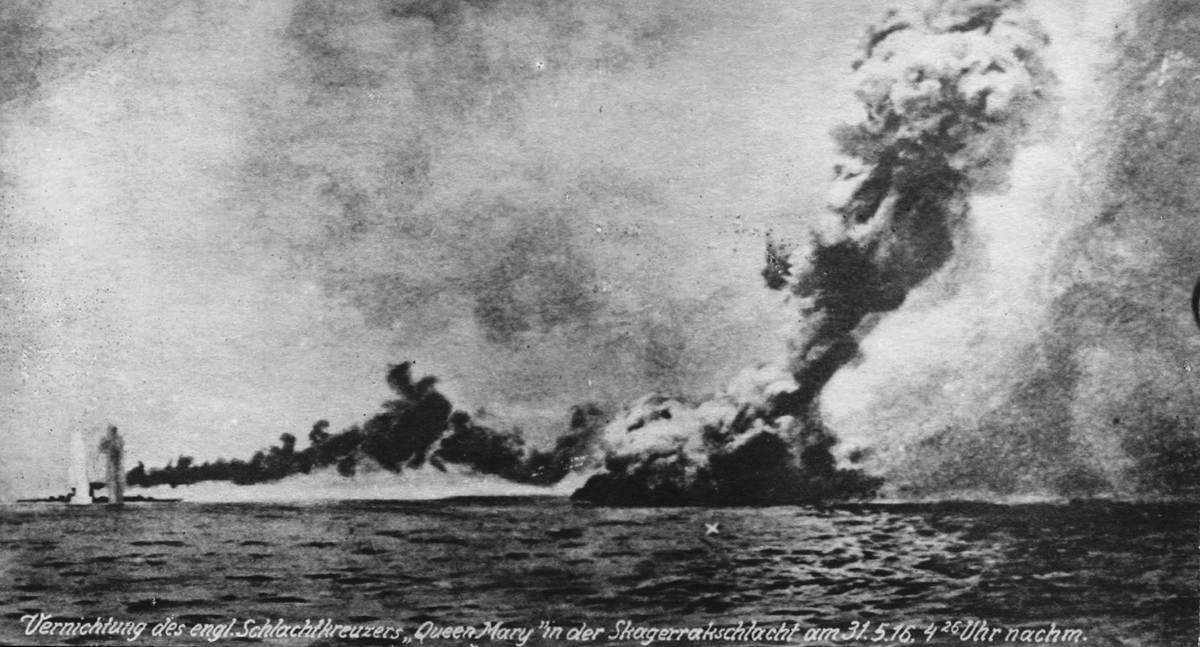
La HMS Queen Mary, colpita dagli incrociatori da battaglia tedeschi, esplode durante la battaglia dello Jutland
Tra il 1914 e il 1915 il conflitto vide la contrapposizione quasi esclusiva della flotta tedesca e di quella inglese. Nel Mare del Nord la Germania attaccava con i sommergibili le navi mercantili inglesi per rompere il blocco navale inflittole dalla stessa Gran Bretagna. Nella battaglia delle Falkland, del 1915, quattro incrociatori tedeschi furono affondati dalla flotta britannica. Di fatto la Germania stava tentando di temporeggiare per evitare uno scontro equivalente a quest’ultimo nel Mare del Nord, ben conoscendo la superiorità navale inglese. Al largo della penisola dello Jütland, il 31 maggio 1916, ebbe però luogo lo scontro decisivo, provocato dal fallimento di una trappola che la marina tedesca aveva teso alle navi britanniche. Due navi inglesi, la Indefatigable e la Queen Mary, vennero affondate ma la flotta tedesca dovette ritirarsi quando sopraggiunse il grosso della flotta britannica. L’episodio dello Jütland confermò la superiorità navale inglese e l’impossibilità per la Germania di forzare il blocco navale-commerciale: la Germania rispose inasprendo la guerra sottomarina.
La Chiesa esorta alla pace ma la guerra continua

Benedetto XV nel suo studio
Nel 1917 il papa Benedetto XV inviò una Nota di pace ai governanti dei paesi impegnati nella guerra; la stessa venne pubblicata anche su Civiltà cattolica del settembre 1917.
La guerra era cominciata proprio nell’anno del suo pontificato e nel suo testo, che si rivolge “Ai Capi dei popoli belligeranti” Benedetto XV afferma di avere voluto mantenere fin dall’inizio la “perfetta imparzialità” ma allo stesso tempo di avere voluto fare, fin dall’inizio, tutto quello che era possibile per mettere fine, al più presto, a questa calamità “inducendo i popoli e i loro capi a più miti consigli, alle serene deliberazioni della pace, di una ‘pace giusta e duratura’”.
In tre anni il papato aveva compiuto ogni sforzo in questa direzione ma i ripetuti appelli non furono ascoltati. Al terzo anno di guerra il papato rinnovò l’appello a porre termine alla guerra e anziché lasciare che fosse un appello al buon senso definì i punti intorno ai quali i belligeranti avrebbero potuto trovare accordo. “[…] E primieramente, il punto fondamentale deve essere che sottentri alla forza materiale delle armi la forza morale del diritto. Quindi un giusto accordo di tutti nella diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti, secondo norme e garanzie da stabilire, nella misura necessaria e sufficiente al mantenimento dell’ordine pubblico nei singoli Stati; e, in sostituzione delle armi l’istituto dell’arbitrato con la sua alta funzione pacificatrice, secondo le norme da concertare e la sanzione da convenire contro lo Stato che ricusasse o di sottoporre le questioni internazionali all’arbitro o di accettarne la decisione.
Stabilito così l’impero del diritto si tolga ogni ostacolo alle vie di comunicazione dei popoli con la vera libertà e comunanza dei mari; il che, mentre eliminerebbe molteplici cause di conflitto, aprirebbe a tutti nuove fonti di prosperità e di progresso.
Quanto ai danni e spese di guerra, non scorgiamo altro scampo che nella norma generale di una intera e reciproca condonazione, giustificata del resto dai benefìci immensi del disarmo; tanto più che non si comprenderebbe la continuazione di tanta carneficina unicamente per ragioni di ordine economico.
Che se in qualche caso vi si oppongano ragioni particolari, queste si ponderino con giustizia ed equità.
Ma questi accordi pacifici, con gli immensi vantaggi che ne derivano, non sono possibili senza la reciproca restituzione dei territori attualmente occupati. Quindi da parte della Germania evacuazione totale sia del Belgio, con la garanzia della sua piena indipendenza politica, militare ed economica di fronte a qualsiasi Potenza, sia del territorio francese: dalla parte avversaria pari restituzione delle colonie tedesche.
Per ciò che riguarda le questioni territoriali, come quelle ad esempio che si agitano fra l’Italia e l’Austria, fra la Germania e la Francia, giova sperare che, di fronte ai vantaggi immensi di una pace duratura con disarmo, le Parti contendenti vorranno esaminarle con spirito conciliante, tenendo conto, nella misura del giusto e del possibile, come abbiamo detto altre volte, delle aspirazioni dei popoli, e coordinando, ove occorra, i propri interessi a quelli comuni del gran consorzio umano.
Lo stesso spirito di equità e di giustizia dovrà dirigere l’esame di tutte le altre questioni territoriali e politiche, nominatamente quelle relative all’assetto dell’Armenia, degli Stati Balcanici e dei paesi formanti parte dell’antico Regno di Polonia, al quale in particolare le sue nobili tradizioni storiche e le sofferenze sopportate specialmente durante l’attuale guerra debbono giustamente conciliare le simpatie delle nazioni.
Sono queste le precipue basi, sulle quali crediamo debba posare il futuro assetto dei popoli. Esse sono tali da rendere impossibile il ripetersi di simili conflitti, e preparano la soluzione della questione economica, così importante per l’avvenire e pel benessere materiale di tutti gli Stati belligeranti”.
Conclude rinnovando la speranza di pace e richiamando i governanti alle loro responsabilità di fronte a Dio.
Gli USA dalla neutralità all’intervento
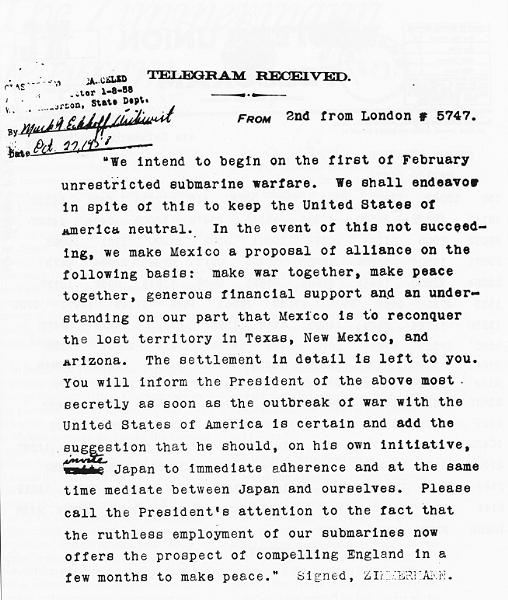
Il telegramma Zimmermann, completamente decifrato e tradotto: n esso si istruiva l'ambasciatore tedesco ad approcciare il governo messicano con la proposta di formare un'alleanza contro gli Stati Uniti. Il suo contenuto accelerò l'ingresso in guerra degli USA
La neutralità degli USA venne proclamata all’inizio del conflitto e mantenuta fino al 1917.
Wilson, allora presidente, aveva affermato di volere mantenere rapporti commerciali con tutti i paesi belligeranti ma privilegiò in realtà i paesi dell’Intesa ai quali furono venduti armamenti per 2,2 miliardi di dollari e furono prestati 7,7 miliardi. Furono proprio queste ingenti cifre a spingere gli USA all’intervento poiché il crollo della Gran Bretagna e della Francia avrebbe inevitabilmente reso impossibile la restituzione da parte di questi ultimi delle cifre avute in prestito o a credito.
Le motivazioni che spinsero gli Stati Uniti ad opporsi alla Germania furono anche di ordine economico poiché entrambi i paesi avevano interessi nelle aree dell’America centrale e latina.
Gli USA entrarono in guerra nell’aprile 1917 quando, su richiesta del presidente, il Consiglio dichiarò guerra alla Germania attribuendole la responsabilità di non avere rispettato il diritto americano alla neutralità ed esprimendo la propria volontà di “rendere il mondo un luogo sicuro per la democrazia”. La fine dello zarismo in Russia aveva, infatti, semplificato la posizione statunitense poiché non rischiava di trovarsi a fianco un alleato ideologicamente scomodo e poteva invece presentare il conflitto come scontro tra i regimi autoritari e quelli democratici. Il numero di uomini schierati sul fronte occidentale con l’ingresso degli USA passò da 300.000 a 600.000 cambiando le sorti del confitto a favore dell’Intesa.
L’integrazione commerciale in funzione bellica

Ascari indigeni e artiglieri tedeschi delle Schutztruppe in Africa orientale
La necessità di materie prime dei paesi belligeranti incise notevolmente sulle relazioni economiche tra i paesi occidentali, le proprie colonie e, più in generale, le ex colonie già indipendenti.
I blocchi navali e la guerra commerciale che tenne impegnati i paesi belligeranti nel tentativo di ostacolarsi reciprocamente nell’approvvigionamento di materie prime fece sì che l’America latina diventasse la principale esportatrice di prodotti verso l’occidente.
Essi riuscirono così ad aumentare notevolmente i propri introiti commerciando con gli USA e con l’Europa ma per far ciò dovettero far largo uso della monocoltura sui propri territori.
Lo sfruttamento non si limitò alle risorse materiali; infatti nelle zone dell’Oceano Indiano e del Pacifico le potenze europee reclutarono addirittura reparti indigeni da mandare a combattere sui fronti.
La fine delle ostilità

Sbarco delle truppe italiane a Trieste il 3 novembre 1918
Grazie all’intervento degli USA le forze dell’Intesa, nonostante la rotta di Caporetto e il crollo del fronte orientale, alla metà del 1918 erano superiori dal punto di vista numerico e delle risorse economiche.
Le forze austro-tedesche cominciarono a ritirarsi dal fronte occidentale, mentre a Berlino e a Vienna si stavano sviluppando i primi fermenti rivoluzionari, sia politici che sociali, che avrebbero caratterizzato il primo dopoguerra. La Bulgaria firmò per prima l’armistizio, seguita dall’Impero ottomano. Gli austroungarici, sconfitti a Vittorio Veneto dall’esercito italiano, firmarono l’armistizio il 3 novembre e poco dopo l’imperatore abdicò al trono d’Austria dove fu proclamata la Repubblica: dalla disgregazione dell’antico impero nacquero l’Ungheria e la Cecoslovacchia. Ancora al 1918 risale la formazione dello stato Jugoslavo. In Germania l’ammutinamento della flotta del Reich causò l’abdicazione di Guglielmo II che si rifugiò in Olanda.
La guerra ebbe fine con la vittoria dei 27 paesi alleati contro gli imperi centrali oramai in dissoluzione.
Il bilancio della guerra

Il cimitero militare di Douaumont, qui ripreso dalla cima dell'ossario; il sito ospita i caduti francesi e tedeschi della battaglia di Verdun.
La Grande Guerra lasciò sui campi di battaglia una quantità sconfinata e inaudita di vittime: prima di allora nessun conflitto aveva visto un tale spiegamento di forze né aveva assunto caratteri simili: i morti furono numerosissimi fin dai primi mesi di combattimento e alla fine del conflitto se ne contarono, approssimativamente, 10 milioni di caduti militari e 7 milioni le vittime civili; i feriti e i mutilati erano stati circa 21 milioni. Il paese che riportò il maggior numero di perdite fu la Germania, con quasi due milioni di morti, seguita dalla Russia con almeno 1,8 milioni di caduti; Francia, Austria-Ungheria e Inghilterra ebbero da 1 milione a 1 milione e 700mila morti. Minori, ma sempre ingenti, i soldati caduti per Italia (650 mila), Serbia, Turchia (770 mila), Romania (250 mial), e Stati Uniti (116 mila).

Corpi di soldati russi uccisi in Polonia abbandonati sopra un reticolato di filo spinato
La perdita così ingente di uomini e di risorse economiche, i debiti, la fine di quelle illusioni che erano state create dalla propaganda bellicista durante il conflitto, indebolirono l’Europa che perse il ruolo di potenza mondiale a vantaggio degli Stati Uniti. Infatti il dopoguerra fu caratterizzato da crisi istituzionali e crisi economiche che colpirono indistintamente sia i paesi vinti che quelli vincitori.
L’indebolimento europeo provocò la nascita dei primi movimenti indipendentisti nelle colonie e le prime forme di autogoverno.
Le trattative di pace a Versailles
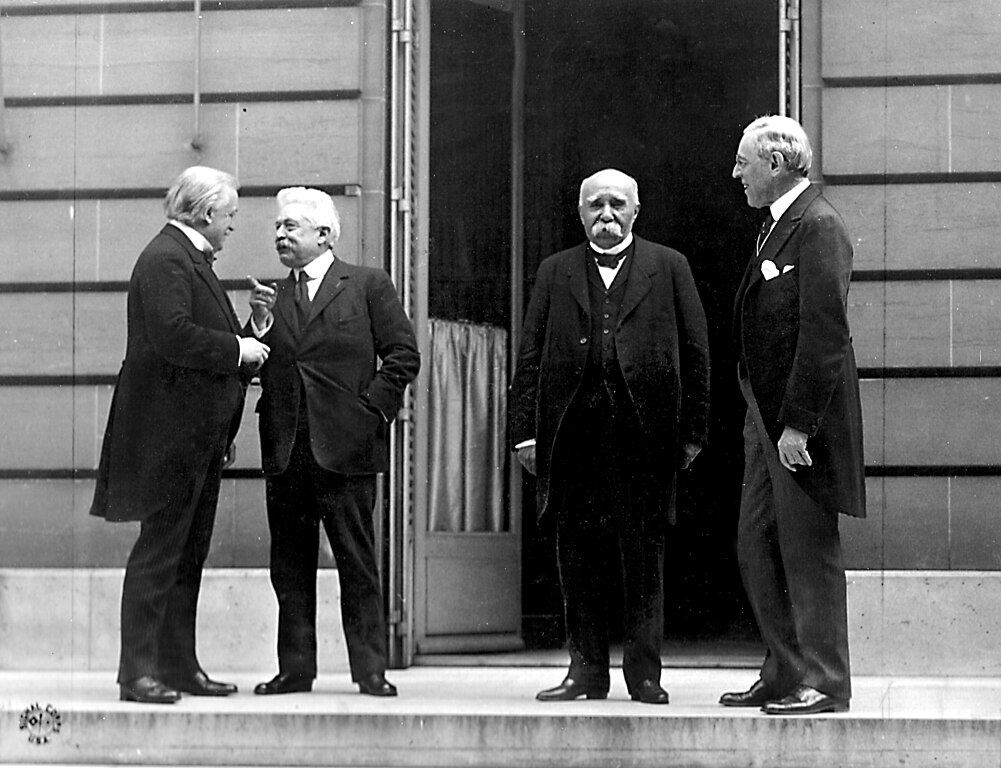
I quattro grandi alla Conferenza di pace di Parigi (da sinistra a destra: Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson)
Nel gennaio 1919 i delegati delle 27 nazioni vincitrici si riunirono nella Sala degli Specchi del castello di Versailles riuniti per la conferenza di pace alla quale non erano presenti invece i rappresentanti dei paesi sconfitti.
Clemenceau fu nominato alla presidenza e le trattative furono svolte dal Consiglio supremo dei “dieci” e poi dei “quattro grandi” (Wilson, Lloyd George, Clemenceau, Orlando).
Nell’agosto del 1920 si conclusero i lavori e si stipularono cinque trattati di pace uno per ciascun paese sconfitto. Ogni trattato prese il nome della località in cui venne firmato: Versailles (Germania), Saint-Germain (Austria), Trianon (Ungheria), Neuilly (Bulgaria), Sèvres (Turchia). Il trattato più importante fu quello firmato a Versailles composto da 440 articoli suddivisi in 15 parti. Si decise la nascita della Società delle Nazioni (SdN), fondata su precise convenzioni che avrebbero garantito l’indipendenza politica ai piccoli come ai grandi stati.
La Germania, costretta a dichiararsi unica responsabile della guerra, subì pesanti mutilazioni, tanto che il suo territorio venne ridotto del 13%: l’Alsazia e la Lorena furono restituite alla Francia, lo Schleswig settentrionale alla Danimarca, i distretti di Eupen e di Malmédy al Belgio, e i nuovi stati di Polonia e Cecoslovacchia ricevettero intere regioni. Le zone di Danzica, del Memel e della Saar furono sottoposte al controllo della SdN.
L’esercito tedesco fu limitato a 100.000 unità senza la possibilità di usare le forze aeree e l’artiglieria pesante. Inoltre la Germania dovette impegnarsi al risarcimento dei danni causati dal conflitto, clausola questa che mise in ginocchio la sua economia per anni. La Francia per assicurarsi il risarcimento occupò il bacino della Ruhr.
Il “wilsonismo” e la nascita della Società delle Nazioni

Il Presidente Wilson davanti al Congresso, mentre annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con la Germania. 3 febbraio 1917
I 14 punti di Wilson costituivano il programma che il presidente americano aveva stilato per mantenere una pace duratura tra i paesi europei.
Nei 14 punti si definivano questioni di assetto territoriale e coloniale basandosi sul principio dell’autodeterminazione dei popoli; si denunziava la diplomazia segreta, si accettava l’impegno della libertà di navigazione, la riduzione degli armamenti e la rimozione delle barriere commerciali. Inoltre il quattordicesimo punto stabiliva la nascita della SdN che potesse intervenire a dirimere le controversie e a garantire l’indipendenza territoriale degli stati membri. I 14 punti furono enunciati in un discorso al Congresso l’8 gennaio 1918 mentre la guerra era ancora in corso, e intendevano mostrare la nobiltà della causa per la quale gli Alleati stavano combattendo. Questo programma si scontrò poi con la volontà dei governi dell’Intesa di imporre una pace punitiva alla Germania e fu così che i 14 punti furono accolti solo parzialmente nel trattato di Versailles.

La sessione di apertura della Lega delle Nazioni a Ginevra, 1920
La SdN fu fondata a Parigi il 24 aprile 1919 ispirandosi ai 14 punti di Wilson e aveva come scopo la sicurezza collettiva, l’arbitrato internazionale, il disarmo che doveva essere ottenuto con la ‘forza morale’ (poiché la SdN non aveva forze militari proprie) e attraverso pressioni economiche e finanziarie. Era composta da un’Assemblea generale e un Consiglio: la prima formata dai rappresentanti di tutti gli stati membri e il secondo da cinque delegati permanenti (USA, Inghilterra, Francia, Italia, Giappone) e da altri eletti a cadenza triennale; il Consiglio eleggeva un Segretariato permanente. La sede di tutti gli organismi della SdN era Ginevra, eccettuata la corte di giustizia che fu collocata all’Aja.
Nonostante il presidente americano Wilson fosse stato il primo sostenitore della costituzione della Società, il Senato americano non ratificò l’adesione paralizzandone subito l’attività.
I limiti stavano di fatto anche nell’assenza di una forza militare, nel ristretto potere decisionale del Consiglio, nell’assenza dei paesi sconfitti.
La SdN fu sì in grado di intervenire nella soluzione delle dispute tra URSS e Polonia nel 1921 e tra Italia e Grecia nel 1923 ma non poté impedire i conflitti che nacquero durante gli anni Trenta e finì per divenire un organo del tutto inutile.
Fenomeni rivoluzionari

Litografia dell'artista C. da Silva che illustra gli eventi della rivoluzione portoghese del 3 ottobre 1910, con la proclamazione della prima repubblica portoghese
Durante gli anni Dieci numerosi furono i fenomeni rivoluzionari che esplosero sia in Europa che nel Nuovo Continente: la diversa genesi, i percorsi e gli esiti eterogenei non devono comunque adombrare una medesima radice comune ai fenomeni messicani, russi, tedeschi e ungheresi, vale a dire la rivendicazione di un maggior peso sociale ed economico, unita alla pretesa di protagonismo politico, avanzate da parte dei lavoratori e dei loro movimenti e partiti.

Manifesto di propaganda bolscevica polacca
In Europa in particolare l’influsso della Rivoluzione bolscevica agì da propellente esplosivo in quei contesti, come quello ungherese e tedesco dove la sconfitta in guerra aveva generato uno spazio vuoto politico ed istituzionale che quei partiti e movimenti cercarono per la prima volta di “ricostruire” secondo il proprio modello. Differenti furono comunque i contesti, le situazioni e le problematiche, così come cruciale fu in Europa il peso assunto nelle vicende interne ai vari paesi dalle conseguenze della Grande Guerra.
Gennaio 1919: nasce la repubblica di Weimar

La proclamazione di Philipp Scheidemann, membro del Partito social-democratico (oggi SPD), della formazione della Repubblica di Weimar dal palazzo del Reichstag
La smilitarizzazione e il pagamento delle riparazioni che dopo la prima guerra mondiale misero in ginocchio la Germania, dettero luogo a un periodo di forti tensioni sociali. Da un lato i nazionalisti si rifacevano al grande passato imperiale, dall’altro si costituiva un movimento formato dai gruppi più radicali del movimento operaio che si unirono nei Consigli degli operai e dei soldati. Il governo era allora costituito da una maggioranza della SPD. I Consigli dettero luogo a Berlino, il 5-6 gennaio 1919, a un’insurrezione nata dall’estromissione di un esponente della sinistra, allora capo della polizia della capitale. La rivolta era guidata dalla Lega di Spartaco (nucleo originario del Partito comunista tedesco), e assunse immediatamente caratteri di scontro armato.
L’insurrezione viene sedata nel sangue dal Commissario alla difesa Gustav Noske. Questi, incaricato dal governo socialdemocratico della repressione, fece uso dei reduci di orientamento conservatore e nazionalista riuniti in squadre volontarie dette Freikorps. Il movimento spartachista venne liquidato: Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che ne erano i leader, furono arrestati e poi uccisi dai “corpi franchi”.
Nello stesso mese le elezioni sanciscono la nascita di un governo formato da un’alleanza tra SPD, il centro cattolico e i democratico-liberali: Friedrich Ebert viene eletto presidente della Repubblica e viene varata (agosto 1919) la costituzione repubblicana.
Nasce così, prendendo il nome dalla città in cui si riunì l’assemblea costituente, la Repubblica di Weimar fondata su una carta costituzionale molto avanzata e con netto carattere democratico. In questa si sanciva il suffragio universale maschile e femminile, l’elezione diretta del presidente della Repubblica e la subordinazione del governo al parlamento. Tutto ciò racchiuso in una cornice federale.
La rivoluzione messicana:da Madero a Carranza

Francisco Madero arringa la folla dal retro del vagone di un treno
Francisco Madero, ricco borghese del nord del Messico, nel 1908 fondò un partito che si basava, come egli aveva scritto nel suo libro La sucecìon presidencial del 1910, sull’esigenza di un suffragio effettivo e non di una rielezione del presidente in carica da trentatré anni, Porfirio Diaz.
Quest’ultimo per scongiurare ogni tentativo di destituzione fece arrestare Madero e mise al bando i partiti dell’opposizione preparandosi ad essere eletto per la nona volta.
Fu dal Texas, dove si era rifugiato, che Madero elaborò il programma di San Luis Potosì. Si trattava di un programma di rivoluzione armata il cui obiettivo era la restituzione agli indios di quelle terre che erano state sottratte loro dai grandi proprietari terrieri.
Emiliano Zapata, rivoluzionario che sosteneva le rivendicazioni contadine, sostenne, anche se con un’impostazione strategica e sociale differente, l’idea di Madero e in tempi brevi portò la rivoluzione a Città del Messico mentre Madero stentava ad avviarla.

Il generale Pancho Villa col suo stato maggiore
Nel maggio del 1911 il presidente Diaz dette le dimissioni e nelle elezioni immediatamente successive venne eletto Madero. Egli formulò però un programma agricolo moderato che deluse i contadini e che spinse Zapata a organizzare una rivolta contadina contro Madero. Approfittando dei contrasti all’interno del fronte rivoluzionario, le forze conservatrici si fecero avanti e sedando tutte le ribellioni, tranne quella di Zapata, appoggiati dagli USA dettero avvio alla controrivoluzione. Madero fu assassinato e il potere presidenziale fu preso da un suo stretto collaboratore, Huerta. Poco più di un anno dopo gli eserciti rivoluzionari costrinsero Huerta alle dimissioni occupando la città di Veracruz. I rivoluzionari erano allora divisi in tre gruppi con a capo rispettivamente Zapata, Villa e Carranza; sarà quest’ultimo a divenire presidente alla caduta di Huerta mettendo in piedi un governo riconosciuto dagli USA. Villa e Zapata continuarono la lotta rivoluzionaria e finirono entrambi uccisi per mano di ufficiali di Carranza.
La rivoluzione ungherese

Bela Kun arringa una folla: sarà capo della fragile Repubblica Sovietica Ungherese dal marzo 1919 ad aprile dello stesso anno
Dopo la definitiva caduta dell’Impero austro-ungarico seguita alla sconfitta subita nel conflitto mondiale, per l’Ungheria ebbe inizio un intenso periodo di rivolgimenti politici e sociali. Infatti il 17 novembre 1918 era stata proclamata la repubblica, presieduta da Kàrolyi; la cattiva riuscita delle trattative per l’armistizio gli attirò tuttavia una vasta ondata di scontento popolare. Molte fabbriche vennero occupate, nacquero, come già era accaduto in Russia e si stava verificando in Italia e Germania, consigli di operai e soldati: il governo di coalizione tra socialdemocratici e le “forze borghesi” cadde per l’incapacità di far fronte alle richieste dei lavoratori e alle minacce di aggressione militare di cechi e romeni. Nacque così, nel marzo 1919, l’unico governo europeo, oltre a quello bolscevico, a guida comunista: lo presiedeva Béla Kun, che condusse una violenta repressione sugli esponenti delle forze politiche aristocratiche e borghesi. Ma nel conflitto con cechi e romeni, intervennero le forze alleate, preoccupate per gli sviluppi in senso sovietico e, di fronte all’ultimatum francese, il governo cadde e Béla Kun fuggì in Austria. Si scatenò anche in Ungheria il “terrore bianco”, che condusse, nelle elezioni del 1920, alla vittoria dei conservatori: fu abolita la repubblica, reintrodotta la monarchia ed eletto reggente l’ammiraglio Miklòs Horthy, esponente della destra militare.
Russia 1917: la rivoluzione “borghese”

Truppe bolsceviche marciano in Piazza Rossa, 1917
In Russia le ripercussioni dello sforzo bellico presero la forma di un’acuta crisi economica e sociale. Il sistema produttivo si rivelò in larga misura inadeguato a sostenere l’impegno di una guerra dalle dimensioni di massa e caratterizzata da un elevato contenuto tecnologico degli armamenti impiegati: l’insufficienza di armi ed equipaggiamenti fu infatti una delle cause delle ingenti perdite umane. Furono le classi popolari a sostenere il peso dell’inflazione e del crescente debito pubblico. Di fronte alla prospettiva di una radicalizzazione del latente conflitto sociale, una coalizione di matrice riformista di aristocratici e borghesi richiese l’istituzione di una monarchia a carattere costituzionale, che tuttavia venne preceduta dagli eventi. Il 23 febbraio 1917 Pietrogrado, sull’onda di scioperi chiaramente antizaristi, vide la nascita di un Soviet nel quale sedevano rappresentanti dei soldati (che si erano rifiutati di intervenire contro gli scioperanti) e dei lavoratori. A fronte dell’abdicazione dello zar, la coalizione borghese non disponeva tuttavia di un solido radicamento popolare e la sua debolezza sarebbe ben presto venuta a galla. Le forze socialiste intanto temporeggiavano, e vari governi provvisori si succedettero senza esercitare alcuna sostanziale egemonia politica. La rottura tra socialisti e borghesi portò al governo il socialrivoluzionario Kerenskji. La reiterata titubanza nell’affrontare i gravi problemi del paese spingeva comunque i Soviet di Mosca e Pietrogrado verso i bolscevichi.
L’insurrezione bolscevica

Assemblea bolscevica a Pietrogrado
Rispetto all’incerta strategia dei governi provvisori, il programma che Lenin aveva proposto nelle sue Tesi d’aprile sembrava, pur nella sua radicalità venire incontro ai bisogni popolari: l’opposizione alla “guerra imperialista” veniva incontro ai soldati oramai esausti, mentre i progetti di riforma agraria osteggiati dal “governo borghese” suscitavano il consenso delle masse contadine. Sembrava maturo il tempo per la presa del potere da parte dei Soviet. In effetti negli organi di Pietrogrado e Mosca le elezioni di settembre segnarono una schiacciante vittoria bolscevica, mentre anche menscevichi e socialrivoluzionari erano vieppiù critici verso il governo. Dopo che la linea insurrezionale, sostenuta da Lenin e da Trotzkij, prevalse nel Comitato Centrale bolscevico, seguita dalla nascita di un comitato militare rivoluzionario, il 24 e 25 ottobre la capitale venne conquistata, causando la fuga di Kerenskij. Durante il Congresso panrusso dei Soviet del 25 la maggioranza dei socialrivoluzionari e dei menscevichi abbandonò tuttavia la seduta, protestando contro il colpo di mano, che comunque sfociò nell’elezione, il giorno successivo, del Consiglio dei Commissari del Popolo, primo governo rivoluzionario, con al vertice Lenin. Le elezioni per l’Assemblea costituente risultarono favorevoli ai socialrivoluzionari, mentre i bolscevichi rimanevano ancorati soprattutto al voto operaio. L’Assemblea, postasi così in contrasto con il governo, venne sciolta di forza: era la sanzione della definitiva rottura tra i bolscevichi e le altre forze socialiste.
La presa del Palazzo d’Inverno

La camera della Gran duchessa Tatiana (figlia dello zar), dopo la conquista del Palazzo d'Inverno da parte di rivoluzionari
Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1917 le truppe rivoluzionarie bolsceviche occuparono i punti cruciali della città, e si schierarono dinanzi al Palazzo d’Inverno, sede del governo. Il presidente Kerenskij, che aveva ordinato all’incrociatore Aurora, ancorato sulla Neva, di dirigersi in alto mare, si trovò dinanzi ad un ammutinamento in favore degli insorti. Kerenskij, capita l’entità del pericolo, si dette alla fuga. Solo 1000 uomini, tra allievi ufficiali e cosacchi restarono a presidiare il Palazzo: si trovavano di fronte 40.000 uomini. Quando alle nove di sera del 26 cadde nel vuoto l’ultimatum per la resa lanciato dai bolscevichi ai ministri, il Palazzo venne cannoneggiato dalla fortezza Pietro e Paolo.

L'incrociatore russo Aurora che alle 9:40 del 25 ottobre 1917, con un colpo a salve, segnò l'inizio dell'assalto al Palazzo d'Inverno; oggi nave museo, è anche una delle poche navi sopravvissute alla disastrosa battaglia di Tsushima nella guerra russo-giapponese del 1905
Anche se due soli colpi andarono a segno, un gruppo di insorti bolscevichi riuscì ad impadronirsi della sede governativa e a disarmare i resistenti, penetrando da un’ala del palazzo rimasta al buio. Dopo che alle 10 di sera si era aperto il Congresso panrusso dei Soviet, alle due della notte vennero fatti prigionieri i ministri del governo caduto. I difensori del Palazzo, dietro giuramento di fedeltà al nuovo governo dei Soviet, vennero liberati e alle 2.30 della notte Kamenev, presidente del Congresso, annunciò finalmente la caduta del Palazzo e del governo. Tre ore dopo il potere passò ufficialmente ai Soviet.
La guerra civile

Lo ex-zar Nicola II con il figlio Aleksej in prigionia a Tobol'sk
Il governo bolscevico nasceva fragile e circondato da molteplici avversari: per questo motivo Lenin individuò nella pace separata con i tedeschi il primo passo da compiere al fine di ottenere stabilità. Tuttavia fin dal dicembre 1917 si era formato un esercito controrivoluzionario, guidato da generali monarchici e appoggiato da truppe cecoslovacche in Siberia e dagli alleati occidentali: era l’inizio della guerra civile. L’intera Siberia venne riconquistata, mentre in oriente sbarcavano altri contingenti antibolscevichi, che assunsero il controllo del nord del paese. Di fronte allo scatenarsi del “terrore bianco”, i comunisti fucilarono lo zar e la sua famiglia, onde evitare ogni possibile restaurazione monarchica, e costituirono l’Armata Rossa comandata da Trotzkij e composta in maggioranza da operai e contadini, dando inizio alla repressione degli oppositori interni. Nel 1919 tuttavia i conflitti operai all’interno dei paesi occidentali costrinsero questi ultimi a ritirare le loro truppe dal suolo russo, mentre nel 1920 fu la Polonia a muovere guerra ai bolscevichi, che reagirono penetrando in territorio polacco fin quasi a Varsavia. L’armistizio segnava da un lato la fine del progetto di “esportazione” della rivoluzione, dall’altro la definitiva sconfitta dell’esercito “bianco”.
I primi passi del comunismo

Bolshevik (1920), di Boris Kustodiev
Dal 1918 al 1920 la Russia bolscevica attraversò un periodo durissimo, che mise duramente alla prova il sistema economico sovietico: lo stato di guerra, con la conseguente devastazione di molti territori, provocò enormi problemi di approvvigionamento, le città si svuotarono tragicamente, e la carestia del 20-21 causò la morte di 5 milioni di persone. Il governo varò in questo periodo una serie di provvedimenti che presero il nome di “comunismo di guerra”: requisizione forzata da parte dello stato dei prodotti alimentari nelle campagne e loro ferreo razionamento, accentuazione del controllo governativo sugli operai, ai quali fu vietato il cambio di occupazione, esautorazione dei comitati operai e gestione delle fabbriche affidata ai singoli direttori. La dittatura del partito bolscevico che controllava l’intero apparato statale e burocratico surrogava democrazia operaia e eliminazione delle gerarchie, così come voleva invece il modello di democrazia dei Soviet. Sia nelle campagne che nelle città come Mosca e Pietroburgo scoppiarono rivolte, come quella della base di Kronstadt, dove i marinai chiesero il ripristino della situazione precedente, che vennero però represse dalle forze militari, dietro ordine di Lenin e sotto il comando di Trotzkij.
Costume e Società
Guerre a società: la mobilitazione industriale

Operaie lavorano campioni di legno nella New Gun Factory a Londra
La produzione da una parte, e la distribuzione delle risorse dall’altra, furono i due aspetti centrali della politica dei paesi impegnati in guerra.
Gli stati elaborarono politiche economiche che prevedevano in primo luogo l’intervento diretto sulle industrie di importanza strategica per la produzione bellica. Il liberismo economico fu abbandonato per passare al controllo diretto da parte dello stato sulle industrie che vennero militarizzate: in queste lavoravano uomini che per l’essenzialità delle mansioni svolte venivano sollevati dalla chiamata alle armi ma anche donne e giovani che, in gran parte, sostituirono la manodopera maschile. La produzione di strumenti bellici, fossero essi mitragliatrici, proiettili o cannoni, subì un notevole incremento e allo stesso tempo fu sperimentata la produzione di nuovi esplosivi o gas per ampliare il potenziale di attacco degli eserciti. Grazie all’ingente quantità di strumenti bellici necessaria in ciascun paese, la grande industria e gli speculatori che seppero convertirsi alla produzione diretta alla guerra, trassero dalle commissioni statali ingenti profitti.
La manodopera femminile venne impiegata sia nel più tradizionale settore tessile, sia nell’industria pesante che aveva occupato fino ad allora manodopera maschile. Tutti, donne, uomini e ragazzi, furono sottoposti a sistemi di produzione più moderni e a nuovi regimi disciplinari.
La mobilitazione delle risorse

Manifesto per il razionamento del cibo in Germania
Ma non fu solo l’impiego nell’industria a segnare il coinvolgimento di vasti strati della società nell’impresa bellica poiché i governi dei vari paesi misero in atto anche sistemi di mobilitazione annonaria e di controllo delle risorse che incisero più globalmente sull’intera società.
Il controllo sulle risorse disponibili veniva esercitato attraverso una campagna propagandistica che intendeva spingere la popolazione a modificare le proprie abitudini alimentari in direzione di quelle risorse di cui si aveva maggiore disponibilità. Questi suggerimenti, che di frequente venivano presentati come strumenti a beneficio della salute da medici e scienziati dell’alimentazione, proponevano un minore consumo di carne a vantaggio delle più salutari verdure e enfatizzavano i benefici del pane nero rispetto a quello raffinato a un pubblico che aveva comunque difficoltà a procurarsi cibo di qualunque natura.
La scarsità di risorse, provocata dalla riduzione dei commerci, dalla diminuzione della manodopera disponibile e dalla necessità di destinare ingenti quantità di beni agli eserciti, venne concretamente tamponata con l’adozione di calmieri e di strumenti di vigilanza annonaria messi in piedi dai Ministeri dell’alimentazione o dei consumi per evitare l’accaparramento delle risorse da parte di pochi. In realtà questo non bastò a fermare il proliferare della borsa nera né a fermare le speculazioni dei commercianti.
Una delle immagini più frequenti nelle città in tempo di guerra erano le code di persone in attesa di tessere annonarie, di sussidi di qualche genere o di beni di consumo razionati.
Propaganda e mobilitazione civile: la guerra entra nella vita quotidiana
Manifesto di propaganda: "la Serbia umiliata dalle altre potenze"
La prima guerra mondiale segnò il coinvolgimento dell’intera società in uno scenario bellico, e di mobilitazione, che rendeva tutti partecipi dell’evento nel quale il proprio paese era impegnato. La popolazione civile non poté non sentirsi coinvolta né pensare alla guerra come qualcosa che accadeva, lontano da casa, solo sul fronte e nelle trincee.
Il sistema di produzione era cambiato: donne e giovani erano impegnati a preparare proiettili e armi, i consumi domestici erano fortemente ridotti e sottoposti al controllo annonario. Ma anche altri aspetti della vita quotidiana nelle città furono segnati dalla guerra.

Cartolina precompilata dal fronte: una prima forma di censura e tenere ignara la popolazione civile dei reali eventi
La stampa, in primo luogo, sulla quale fu esercitata la censura intendendo così diffondere solo le informazioni che ciascun paese riteneva adeguate al mantenimento di uno stato di tensione delle popolazioni che non degenerasse nel disfattismo. Le notizie venivano così vagliate, modificate, o censurate appunto, perché i periodici rimandassero l’idea di un paese solidamente unito nel desiderio di vittoria. Anche le lettere dei soldati prima della pubblicazione venivano valutate e sottoposte a censura. Ben pochi furono gli organi di informazione che si allontanarono da questo cliché: i bolscevichi russi, gli spartachisti tedeschi e, in Italia, il PSI e gli anarchici che furono per questo considerati nemici della nazione.
Strumenti di propaganda furono anche le associazioni filantropiche, in gran parte costituite da donne, che raccoglievano fondi per sostenere le famiglie dei richiamati, o che cucivano zaini, divise militari, calzettoni per i soldati ma anche bandiere nazionali.
Le donne nelle industrie e nei campi

Operaia in fabbriaca, 1918
La manodopera femminile fu impegnata massicciamente nella sostituzione degli uomini partiti per il fronte sia nell’attività industriale sia in agricoltura. Si trattò di un fenomeno diffusosi in ogni paese impegnato in guerra i cui caratteri sono stati in parte amplificati in parte sminuiti soprattutto in relazione alle necessità di ripristino di modelli sociali più accettabili alla fine della guerra.
Il numero massiccio di donne al lavoro in quegli anni pose sotto gli occhi di tutti l’esistenza di un fenomeno che, seppure in termini numerici ridotti, non era completamente nuovo. Le donne lavoravano già nelle industrie e nei campi: fu però, ancor più che la quantità, il timore di veder innescarsi un processo di cambiamento delle identità maschili e femminili che, da una parte, fece gridare allo stupore e, dall’altra, tentò di sminuirne l’importanza.
Nonostante le donne avessero dimostrato di sapere svolgere gli stessi lavori degli uomini, ottenendo in alcuni casi gli stessi loro stipendi, e di sapere anche mobilitarsi nelle agitazioni che ebbero luogo durante il conflitto mondiale, furono sostituite dai reduci alla fine della guerra perdendo il posto di lavoro e ogni riconoscimento. La smobilitazione industriale in questo caso non ebbe soltanto connotati economici ma fu volta principalmente allo ristabilimento dei ruoli tra generi in cui fino ad allora ci si era riconosciuti.
I giovani: adulti o soldati

Soldati intrattengono un gruppo di bambini con le loro storie al fronte
Negli anni della prima guerra mondiale il brusco passaggio all’età adulta caratterizzò la vita di molti adolescenti e contribuì a determinare, tra i più giovani, nuove prese di coscienza e di posizione inedite fino ad allora.
L’assenza degli uomini, costretti a lasciare le famiglie per andare in guerra, non modificò soltanto il ruolo delle donne ma anche quello dei giovani sui quali riversò nuovi compiti e responsabilità sia nell’impegno lavorativo che nelle relazioni all’interno della famiglia.
Molti furono quelli che presero su di sé parte della responsabilità economica e che andarono a lavorare nelle fabbriche per contribuire al sostentamento della famiglia e che allo stesso tempo si ritagliarono il ruolo di capofamiglia anche in termini di equilibri familiari. In tutti quei casi in cui i soldati morirono in guerra questo processo divenne irreversibile e i giovani divennero definitivamente adulti.
L’assunzione di nuove responsabilità sia economiche sia affettive portò molti giovani ad acquisire la consapevolezza dei propri diritti e spesso ciò dette luogo ad agitazioni e proteste pubbliche di cui furono protagonisti. Rivendicazioni che nascevano in primo luogo dall’acuta contraddizione che essi percepirono tra le nuove responsabilità e la scarsa attenzione sociale di cui erano oggetto. Nessuna delle organizzazioni filantropiche che si occupò dei soldati o dei bambini prese in seria considerazione la situazione in cui si erano venuti a trovare i giovani e nessuna organizzò opere di assistenza nei loro confronti. Riconoscimenti per il ruolo da loro svolto non arrivarono nemmeno nel dopoguerra quando, anche a causa della assoluta mancanza di prospettive, parteciparono massicciamente alle proteste che scoppiarono in Europa..
Gli uomini in trincea: una lettera

Una lettera dal fronte, mai arrivata a destinazione
In una delle tante lettere spedite dal fronte e censurate la guerra veniva descritta, con toni molto differenti da quelli della propaganda giornalistica tutta tesa e tenere alti gli animi della popolazione, la vita in trincea e la paura dei ‘superiori’ e degli spari dei nemici:
“[…] Vi voglio raccontare un pochino come me la passo io qui, come ci trattano al fronte. […] Si fa altro che maledire i nostri superiori […] che vogliono tante mondizie, dico mondizie perché è fuori di ogni immaginazione […]. Sino che eravamo al masatorio cioè in prima linea, in rischio di farci macelare ogni minuto, e ci trattavano un po’ meglio perché avevano paura più di noi, e quando si fava per avanzare cridavano avanti, avanti altrimenti vi sparo. Altro che dire nella stampa, e voi certo l’avrete letto sul Corriere che spiegava quei drappelli della morte che vanno seriamente e volontariamente a quella pericolosissima operazione di mettere i tubi di alto espulzione, e di tagliare i fili; che specialmente chi va non torna più […] certo si rischia la pelle, altrimenti la pelle me la fanno i nostri superiori. […] Spera Cara Molie che vada terminata questa guerra micidiale che invece di diminuire, va allargandosi sempre più e fa piangere Madri, Padri, Molie, Figli, Fratelli e Sorelle di tutti quelli che si ritrovano in detta guerra”.
Una terribile epidemia: la “spagnola”

29 maggio 1919, Massachusetts. Come in tutti i paesi, anche qui, in seguito al riempirsi degli ospedali, si fecero costruire ospedali da campo per sopperire alle esigenze dei malati
Ai quasi dieci milioni di morti nelle trincee si devono aggiungere tutti quelli che, militari o civili, furono colpiti, a partire dal 1918, dall’epidemia detta “spagnola”.
Il nome di questa epidemia virale, che pure non nacque in Spagna, deriva dal fatto che si diffuse dal sud al nord del globo e dal fatto che i primi a darne l’allarme furono proprio gli spagnoli.
Di “spagnola” morirono circa 25 milioni di persone dall’India al Giappone, dalla Francia agli USA, dall’Italia alla Cina.
Il virus, che una volta contratto provocava una malattia che costringeva la popolazione a letto per poi esplodere in una forma di poliencefalite che uccideva in tre giorni, proveniva dall’Oriente o più probabilmente dagli Stati Uniti, si diffuse in Europa con l’arrivo dei soldati americani e fu scoperto soltanto nel 1933.
A casa dopo la guerra

Freikorps tedeschi durante i disordini postbellici su di un autoblindo Garford-Putilov
Dalle trincee tornarono uomini ansiosi di riprendere il proprio lavoro, di rioccupare il proprio posto nella famiglia e nella società ma anche profondamente segnati dal conflitto, incapaci di adattarsi con facilità alla vita civile e pronti ad assumere un ruolo sociale e politico rilevante nei paesi usciti dal conflitto.
I reduci parteciparono da protagonisti al biennio rosso italiano, alle manifestazioni in Francia, ai Soviet russi, ai Räte della rivoluzione tedesca e ai disordini kaki in Gran Bretagna.
Il peso delle migliaia di compagni morti al loro fianco in trincea risultava difficile da conciliare con la sensazione di una vittoria “mutilata” per questo essi ribadirono ed enfatizzarono il loro desiderio di risarcimento materiale e di riconoscimento per avere combattuto per la nazione intera.
Fu per questo che in tutti i paesi che erano stati coinvolti nel conflitto, i reduci si riunirono in associazioni assistenziali e politiche con connotazioni e orientamenti differenti tra loro: in Francia come in Germania (dove si erano riuniti sotto nomi diversi quasi più di due milioni di uomini), in Italia (dove fu fondata l’Associazione Nazionale Combattenti e la Lega proletaria mirov) come negli USA.
Le vecchie e le nuove identità di uomini e donne
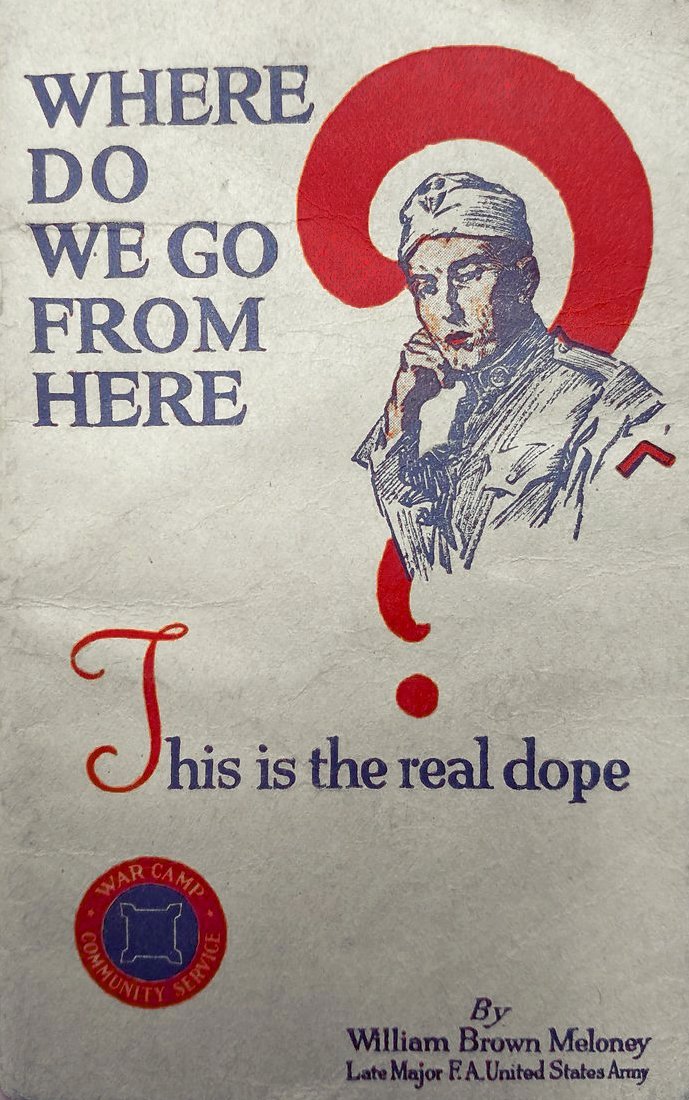
Libretto dato ai soldati veterani americani che avrebbe dovuto aiutarli al rientro in madrepatria
Il ritorno a casa assunse le forme del ritorno ai ruoli di maschile e femminile che costituivano l’asse portante dei rapporti tra sessi prima del conflitto.
Le donne che avevano lavorato erano diventate capofamiglia avevano sperimentato forme di aggregazione e di autonomia fino ad allora non comuni si trovarono costrette all’abbandono del lavoro nelle fabbriche a vantaggio dei reduci e a tornare ad occuparsi principalmente della sfera domestica. Nessuno volle riconoscere il loro nuovo ruolo e l’autonomia che, forzate dalle contingenze, avevano assunto fu di fatto ignorata e, anche volontariamente, minimizzata.
Ciò che assunse grande importanza fu infatti il ritorno a casa degli uomini che dopo aver combattuto pretendevano non solo il riconoscimento dei propri meriti e dei propri sacrifici ma anche il riconoscimento della diversità che li contrapponevano a quanti non erano stati in trincea con loro: fossero essi uomini o donne.
L’esigenza di reintegrarsi nella società passava infatti attraverso la riappropriazione del ruolo di capofamiglia, rispetto alle donne, e nell’enfasi data all’avere combattuto per la nazione e all’essersi sacrificati rispetto a quanti la guerra non l’avevano vissuta in trincea.
Il cameratismo maschile e la retorica delle associazioni di combattenti sottolineavano semmai le caratteristiche di mascolinità che essi avevano fatto asse portante della propria identità.
La guerra cioè aveva contribuito a creare nuove identità sia negli uomini che nelle donne, inizialmente però queste novità vennero di fatto negate, mentre la consapevolezza che una rottura era avvenuta fu riconosciuta solo più tardi.
La lotta per la cittadinanza: le “suffragette”

Una suffragetta che per protesta rifiutava il cibo viene alimentata forzosamente nella prigione di Holloway, 1911
Il movimento delle suffragette rivendicava il diritto di voto per le donne al fine di essere riconosciute e considerate cittadine a pieno titolo. Nel 1903 in Inghilterra era stata fondata da Emmeline Pankhurst la Women’s Social and Political Union (WSPU) e più o meno negli stessi anni era nata anche la National American Woman Suffrage Association (NAWSA). Negli anni del conflitto mondiale, dopo avere combattuto fino ad allora le battaglie per il voto, le donne si concentrarono sulla guerra, prendendo a volte anche all’interno delle stesse organizzazioni posizioni differenti.

Emily Davidson pochi istanti dopo essere stata travolta da un cavallo da corsa nella sua invasione dil campo
Questo non significò però la fine del movimento suffragista: con la guerra le donne erano uscite dalla sfera domestica si erano impiegate nelle fabbriche avevano invaso spazi fino ad allora esclusivamente maschili e acquisito una nuova consapevolezza delle proprie capacità.
Nel 1918 alle donne britanniche che avessero superato i 30 anni fu dato il diritto di voto e nel 1920 anche le statunitensi furono ammesse alla cittadinanza politica ottenendo il diritto di votare.
La costruzione della memoria

Sacrario militare, ricordo dei caduti della prima Guerra Mondiale, Redipuglia (Trieste)
La guerra divenne parte fondamentale della memoria nazionale dei paesi belligeranti. Innanzitutto per le celebrazioni che fin da subito vennero fatte ai caduti nel conflitto: furono costruiti monumenti ai caduti, i resti dei soldati vennero riuniti in ossari e sacrari, le varie tappe della guerra furono ricordate attraverso zone loro dedicate sulle montagne e nei boschi. Nelle città la celebrazione dei caduti assunse la forma di targhe o lapidi ai margini della strada, di piazze e parchi intitolati ai caduti, e di vie denominate con nomi dei luoghi in cui si erano svolte le battaglie.
La commemorazione diventava anche strumento di nazionalizzazione quando nei discorsi pubblici, la memoria della guerra fu elaborata al fine di divenire la base della memoria della nazione e venne collegata alla creazione di nuove tradizioni a questa collegata che diventavano cemento della popolazione.
Anche per i soldati la guerra aveva costituito uno strumento di socializzazione delle esperienze poiché in trincea si trovarono fianco a fianco, spesso per la prima volta, uomini che provenivano da regioni lontane tra loro, che parlavano dialetti diversi, che avevano usi e tradizioni tra sé sconosciute. Dal punto di vista della costruzione di un’identità nazionale, dunque, il percorso era cominciato anche prima della fine del conflitto e anche con caratteri molto distanti da quelli che assumerà successivamente con le riletture in senso nazionalista da parte del regime fascista e nazista.
Arte, Cinema e Letteratura
L’uomo come passaggio e tramonto: “Die Brücke”

Ernst Ludwig Kirchner, "Davos in estate"
Nel 1905 quattro giovani studenti di architettura fondarono un gruppo denominato “Die Brücke”. Il nome del gruppo che in italiano si traduce con “Il ponte” derivava da un’affermazione di Nietzsche in Così parlò Zarathustra nel quale affermava che l’uomo non era un fine bensì un ponte “ciò che si può amare nell’uomo è che egli è passaggio e tramonto”. Il ponte stava ad indicare, inoltre, anche il legame che li univa agli altri gruppi non impressionisti.

Paul Klee, "Panorama con canarini"
Essi, infatti, semplificarono i tratti dei loro dipinti tracciando pennellate rapide e dure e tutti sperimentarono anche la xilografia: tecnica scelta anche per riprendere una tradizionale arte tedesca. L’uso di determinate tecniche piuttosto che altre fu collegato anche all’orientamento del gruppo. Essi intendevano sottolineare l’importanza del lavoro manuale che collegavano alle attività delle classi lavoratrici. L’arte perciò veniva staccata dal contesto intellettuale delle classi dirigenti e avvicinata a quelle di lavoratori.
Il soggetto che più rappresentarono fu il nudo inteso come simbolo dello stato paradisiaco e si richiamavano, come emblemi delle civiltà non contaminate, all’arte primitiva e medioevale.
Dopo un’importante esposizione alla Galleria d’Arte Moderna di Berlino il gruppo si sgretolò alla vigilia della prima guerra mondiale.
Schiele e l’espressionismo austriaco

Egon Schiele, "Autoritratto"
Egon Schiele, Klimt e Kokoschka furono i protagonisti dell’espressionismo viennese che giunse al culmine del suo sviluppo negli anni Dieci del Novecento.
Schiele, all’epoca della sua formazione artistica, fu profondamente influenzato dallo stile di Klimt dal quale però si distaccò ben presto abbandonando ogni elemento decorativo e privilegiando la rappresentazione di figure drammatiche e connotate da profondo pessimismo che avevano più affinità con l’arte espressionista di Alfred Kubin e Kokoschka.
Gli acquerelli e i disegni di Schiele – tra gli altri Gli amanti e L’abbraccio – rappresentano prevalentemente corpi umani distorti, caricaturalizzati, immortalati in pose grottesche che mostrano il limite che la fisicità impone all’espressione interiore. Gli espressionisti privilegiarono, infatti, l’indagine delle percezioni dell’inconscio più che della realtà per mostrare l’inquietudine umana in linea con le ricerche psicoanalitiche che Freud stava svolgendo in quegli anni nella stessa Vienna. Alla fine della sua breve vita, Schiele morì a soli 28 anni nel 1918, egli si dedicò alla raffigurazione di paesaggi e spazi bidimensionali caratterizzati dall’uso di linee incisive e colori spregiudicati: il matrimonio con Edith Harms, avvenuto nel 1915, e il trasferimento in campagna diedero, infatti, maggiore serenità alla sua vita e impressero un mutamento di stile alla sua arte.
Kandinskij, Klee e il “Cavaliere Azzurro”

Prime sperimentazioni del 1908, ispirato dagli impressionisti
Nel 1911 a Monaco Vasilij Kandinskij insieme ad altri artisti tra cui Klee presentarono un’esposizione che prese il nome di “Der Blaue Reiter” (Il Cavaliere Azzurro). Fu piuttosto la presentazione di un manifesto della poetica del gruppo che si fondava sull’immagine fiabesca e popolare del cavallo e dall’uso del colore azzurro identificato come il colore spirituale che evoca l’infinito.
Nell’Almanacco Der Blaue Reiter, pubblicato nel 1912, essi si soffermarono sul significato dell’arte e non solo dell’arte pittorica affermando l’esistenza di un fine dell’arte coincidente con la “necessità interiore” dell’artista. La ripresa dell’arte primitiva e infantile permetteva di compiere un viaggio alle sorgenti della creatività e di raggiungere l’emotività e la spiritualità, fonte di ispirazione artistica. Essi non vollero usare le immagini per descrivere ma per toccare direttamente l’emotività dell’osservatore di volta in volta, esaltando, come Klee, l’ingenuità dell’infanzia o le immagini oniriche.
Nel 1913 fecero la loro ultima esposizione al Salone d’Autunno di Welden, prima della dispersione del gruppo in coincidenza con lo scoppio della guerra.
Lo sviluppo di un’arte non figurativa

Primo quadro astratto ad olio con titolo: "Quadro con cerchio del 1911"
La prima opera che si può definire astratta è un acquerello di Kandinskij del 1910 intitolato Acquerello astratto dipinto contemporaneamente alla scrittura del saggio teorico sulla separazione di arte e natura che sancisce l’autonomia di colori e forme e, di fatto, la nascita dell’astrattismo (Sulla spiritualità nell’arte). Prima di questa data altri pittori avevano dipinto opere che muovevano in direzione dell’astrattismo, gli studi dei movimenti neoimpressionisti e i dipinti di Gauguin nei quali i colori usati non rispondono esattamente ai colori della realtà, ma la compiutezza teorica della nuova corrente giunse solo con Kandinskij.

Vassily Kandinsky, "Ritratto di Nina Kandinsky", olio su tela, 1917
Egli desiderava, infatti, che la sua arte non fosse più vincolata alla riproduzione della realtà e che si fondasse, invece, solo sull’accoppiamento di linee e colori in una molteplicità di combinazioni diverse, scelta che fu avvalorata nel 1908, indirettamente, da uno storico dell’arte che riconosceva nell’astrazione la caratteristica dell’arte delle civiltà nordiche distinguendola da quella delle civiltà classiche sempre alla ricerca dell’immedesimazione con la realtà.
A partire dal 1912 Kandinskij dipinse tele in cui linee e colori rappresentavano compiutamente tutte le emozioni dell’artista, pur non raffigurando oggetti reali o identificabili. La ricerca di un’armonia nella pittura si spinse ai confini dell’armonia musicale con la quale cercò una connessione che si esplicitava anche nei titoli dati alle proprie opere (Improvvisazioni, Composizioni).
Il dinamismo palingenetico futurista

Umberto Boccioni, "il Mattino"
I futuristi fondavano la propria arte sulla frenesia della vita moderna e ponevano alla base del concetto di bellezza il movimento, il dinamismo, la velocità e le dissonanze. Sintesi efficaci di queste caratteristiche sono l’automobile e l’aeroplano strumenti che, in quegli anni, rappresentavano egregiamente la modernità e che assunsero il ruolo di simboli del futurismo. Il dinamismo era anche emblema delle metropoli e Milano sembra essere eletta la città ideale dei futuristi che vi ritrovavano masse di uomini in movimento, rumore, ferrovie, cantieri, industrie e caffè tutti uniti in un’attività quotidiana frenetica.

Giacomo Balla, la moglie con la figlia
Nella loro arte essi volevano cogliere il movimento del corpo e lo spazio in cui questo si muove nella sua forma unitaria, motivo per cui per rappresentare la dinamicità incessante dell’oggetto ritenevano necessario evidenziare le linee-forza che caratterizzano l’oggetto raffigurato.

Giacomo Balla, 1912, "Dinamismo di un Cane al Guinzaglio" (Dynamism of a Dog on a Leash), Albright-Knox Art Gallery
In quest’ottica vennero compiute le opere di Boccioni e di Russolo Dinamismo di una automobile (1913) e La città che sale (1911); e Velocità d’automobile + luce + rumore (1913), Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912) di Balla.
Staccandosi da ogni stile di rappresentazione tradizionale essi volevano portare lo spettatore all’interno della composizione nella quale venivano usati colori puri, toni accesi, che permettono di sconvolgere la visione dello spazio cui il pubblico era abituato.
La distruzione delle Accademie: i manifesti

Prima pagina del quotidiano francese "Le Figarò" del 20 febbraio 1909 con la pubblicazione del "Manifesto del Futurismo" di Filippo Tommaso Marinetti
Nella sua predilezione per il dinamismo e tutto ciò che rappresentava la modernità, i futuristi desideravano la fine della cultura del passato: concretamente la distruzione dei musei e delle Accademie.
Il desiderio di una nuova estetica che fosse simbolo del progresso venne enunciata da Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto del futurismo. Marinetti fu il fondatore anche della rivista “Poesia” nella cui cura si affiancarono non solo letterati e poeti, ma anche musicisti, pittori, fotografi, architetti.
Il movimento multidisciplinare che nacque elaborò un progetto di rinnovamento culturale ad ampio raggio. Il Manifesto di Marinetti fu seguito da quello dei pittori, nel quale si affermava il disprezzo dell’arte come imitazione e l’esaltazione dell’originalità, e da un altro detto Manifesto tecnico nel quale si preconizzava l’avvento di una nuova poetica: la sensazione dinamica.
Nel 1911 si tenne la prima esposizione delle opere futuriste. La critica fu durissima nei loro confronti e soprattutto lo fu “La Voce” di Ardengo Soffici con il quale il gruppo futurista interruppe ogni relazione dedicandosi invece alla promozione del futurismo all’estero e soprattutto a Parigi dove Marinetti organizzò nel 1911-12 una grande esposizione di pittura futurista.
I manifesti futuristi continuarono ad essere stampati sotto forma di volantini nei quali essi si scagliavano aggressivamente contro qualcosa o qualcuno: Contro Roma passatista, Contro il matrimonio, Contro il papato; essi volevano distruggere l’ordine esistente per edificarne uno nuovo.
Scultura aerodinamica

"Forme uniche della continuità nello spazio" (1913), MoMA, New York. L'immagine è stata ripresa nella moneta di 20 centesimi di euro di conio italiano
Un ulteriore manifesto fu scritto da Boccioni nel 1912, il Manifesto tecnico della scultura futurista; in questo si sanciva la fine dell’idea di staticità fino ad allora insita nelle statue. Più precisamente Boccioni intese affermare “l’assoluta e completa abolizione della linea finita e della statua chiusa”.
Per rendere l’effetto plastico del movimento anche nelle statue, egli inventò la forma aerodinamica: l’uomo in movimento è rappresentato tenendo conto dello spostamento d’aria che egli crea, dell’attrito, e delle modificazioni fisiche. Ciò crea un tutto unico fra l’ambiente e l’oggetto in movimento, in una dinamica compenetrazione di spazi e linee nella quale si prolungavano i piani dell’immagine posta nello spazio per rendere appunto l’idea di spostamento. Il risultato era la creazione di sculture più astratte di quelle concepite fino ad allora, sebbene rimanessero sempre riconoscibili gli oggetti raffigurati. I futuristi oltre alla sperimentazione di forme dinamiche nella scultura introdussero l’uso di nuovi materiali sia rigidi (vetro, cemento, specchi) che duttili (cartone, stoffa, cuoio).
Futurismo e avanguardie russe

Natalija Gonciarova, "Autoritratto"
Il futurismo italiano giunse in Russia prima con la traduzione del Manifesto del futurismo pubblicato su una rivista russa, poi con la visita che Marinetti vi fece nel 1910 incontrando gli esponenti dell’avanguardia pittorica.
Tra i protagonisti di quest’avanguardia stavano i fratelli Burljuk (che avevano fondato un gruppo col nome “Uomini del futuro”) l’artista Michel Larionov e Natalja Goncarova. Larionov si concentrò sull’esplorazione dei colori che contenevano, a suo parere, una carica vitalistica. Poco tempo dopo coniò il nome ‘raggismo’ per definire quest’avanguardia che individuava nel raggio l’emblema della sintesi tra luce e movimento. Influenzato dal futurismo e dal cubismo orfico si ricollegava però, proprio tramite il ‘raggio’, anche alla tradizione delle icone e dei mosaici russi.
Nel 1913 venne stampato un Manifesto del raggismo. Il raggismo non rimase un fenomeno isolato e produsse invece un vivace dibattito che coinvolse anche artisti di altri generi, come registi, architetti e letterati.
I fondatori del raggismo, Larionov e Goncarova, che arrivarono all’astrattismo abbandonando ogni riferimento al reale, si trasferirono nel 1914 a Parigi per fare da scenografi al ballerino russo Diaghilev.
Parigi ai primi del Novecento

"Il Bateau-Lavoir", in Rue Ravignan a Montmartre, dove avevano il loro studio Picasso e Braque
A Parigi, fino all’inizio della prima guerra mondiale, il mercato e la produzione dell’arte erano al culmine. Nei quartieri di Montmartre e Montparnasse vivevano in alloggi economici un gran numero di artisti: nel primo vi abitò, dal 1904 al 1909, Picasso, ma anche Braque, Severini, Dufy, Utrillo, i fratelli Duchamp e Modigliani. Nelle stesse strade, e frequentando gli stessi locali, vi risiedevano anche lo scrittore Max Jacob e il musicista Satie. Fu lì che nacquero il cubismo e il fauvismo di cui, in quegli anni, si fece sostenitore un mercante tedesco Kahnweiler, che aprì una galleria esponendo le tele di Picasso e dei cubisti.
Punto di ritrovo degli artisti bohemienne che risiedevano a Montmartre erano i caffè e la Place du Tertre e in generale ogni luogo in cui si teneva una mostra, un balletto, un concerto poiché ciascuno di questi luoghi era occasione di incontro e di scoperta di nuove forme espressione artistica.
Al polo opposto della città era Montparnasse dove si trasferì Picasso nel 1912 e dove si ergeva un edificio ottagonale, La Ruche, nel quale avevano sede gli studi e le abitazioni dei pittori che all’epoca non erano ancora diventati famosi, tra i quali Chagall, Modigliani, Van Dongen, Léger, Soutine e Brancusi (anch’egli abitò in questo quartiere anche se volontariamente isolato dagli altri artisti).
Le prime mostre cubiste

Jean Metzinger, Baigneuse, "Deux nus dans un jardin exotique"
Nel 1911 al Salon des Indépendants si tenne una mostra collettiva dei pittori cubisti. Non vi esposero i propri lavori né Picasso né Braque, che erano tra gli esponenti di maggiore spicco del movimento, ma nonostante ciò il pubblico percepì il momento di rottura che quelle tele costituivano per l’arte contemporanea.

Albert Gleizes, "Les Baigneuses" (The Bathers)
Nel 1912 l’esperienza fu ripetuta con la mostra denominata ‘La section d’Or’. Vi esposero le proprie opere tutti quei pittori cubisti o che avevano subito l’influenza del cubismo ma non i padri fondatori. Si trattava di un appuntamento voluto fortemente da Metzinger e Gleizes i quali intendevano in quell’occasione teorizzare le ‘regole del cubismo’. In realtà la regola non esisteva e non poteva essere stabilita con questo mezzo. Tra i giovani artisti esposti, si fecero notare Duchamp e Picabia per i quali il cubismo fu solo una tappa di un processo di crescita artistica che sfocerà poi nel dadaismo.
Il cubismo orfico di Delaunay

Robert Delaunay, Paysage au disque
L’orfismo come movimento pittorico fu fondato da Apollinaire e vi incluse molti pittori che facevano esercizi e ricerche sulla luce, sul dinamismo, sul colore. Delaunay prese le distanze dal cubismo puro per sperimentare nuovi rapporti tra luce e colore come in Tour Eiffel che dipinse nel 1910. Successivamente, nel 1913, inventerà il Disco simultaneo che costituirà un ennesimo allontanamento dal cubismo: egli dipinse su una tela tonda una serie di cerchi concentrici con colori opposti che rappresenta l’essenza stessa del colore e della luce.
Modigliani e Brancusi a Parigi

"Ragazza in camicetta a pois"
Dal 1905 viveva a Parigi lo scultore rumeno Brancusi. Pur conducendo una vita piuttosto isolata dagli altri artisti ebbe un’intensa amicizia con Modigliani, uomo caratterizzato da uno stile di vita sregolato che arrivava a vendere i propri disegni per poche monete o un bicchiere di liquore.
L’intento dell’opera scultorea di Brancusi era non già la riproduzione della realtà ma la spinta verso la meditazione che egli intendeva raggiungere attraverso la descrizione di una forma elementare. I suoi soggetti prediletti furono le teste umane, l’uovo, la foca e l’uccello delle favole rumene che egli traduceva in sculture che solo lontanamente richiamavano il reale e nelle quali la mano dell’artista scompariva nelle superfici perfettamente levigate.

Constantin Brancusi, "il bacio"
Fu Brancusi ad introdurre Modigliani alla scultura e all’arte africana e da quest’incontro nacquero le sculture in pietra, raffiguranti teste, che riprendevano lo stile essenziale di Brancusi. Fino al 1914 Modigliani continuò a scolpire ispirandosi anche all’arte egizia, indiana e greca arcaica; dopo quella data tornò alla pittura trasferendovi, però, le forme che aveva interiorizzato con l’esercizio scultoreo. Dall’esperienza compiuta negli anni in cui si dedicò alla scultura e alla ripresa dell’arte del passato – la tradizione toscana del Trecento e del Quattrocento, l’arte primitiva ed egizia – egli trarrà, infine, il suo linguaggio pittorico più personale giungendo alla raffigurazione di volti allungati e interrogativi, emblemi di una bellezza pura e limpida, che costituiranno il tratto più presente della sua produzione da allora in avanti.
Chagall a Montparnasse

Marc Chagall, "Il Calvario"
Chagall aveva studiato a Pietroburgo e dal 1910 abitava, come altri artisti russi, a Montparnasse nel complesso de La Ruche.
Molti pittori dell’est europeo all’inizio del XX secolo sceglievano di trasferirsi a Parigi per il clima che la caratterizzava portando, con le proprie tradizioni e conoscenze, nuovo respiro nel dibattito sull’arte.
Negli anni passati nella capitale francese, dal 1910 al 1914, Chagall si avvicinò al cubismo e pur continuando a rappresentare temi che lo legavano alla sua terra d’origine (i rituali ebraici, la famiglia e l’infanzia), egli sperimentò la scomposizione della forma tipica del cubismo.
I fratelli De Chirico

Giorgio De Chirico, "Le mauvais génie d'un roi"
Anche alcuni artisti italiani si spostarono nella cosmopolita capitale francese. I fratelli De Chirico, di origine italiana, soggiornarono a Parigi per quattro anni a partire dal 1910. Giorgio e Andrea erano inseparabili e solo dopo aver elaborato una comune ricerca, che si distaccava dal cubismo e dalle avanguardie, si differenziarono. Andrea cambiò nome in Alberto Savinio e coltivò soprattutto la vena letteraria entrando a contatto con Apollinaire e con Valéry.
Giorgio elaborò in quegli anni la sua visione metafisica la cui formulazione compiuta, come base della sua arte, avverrà al suo ritorno in Italia dove incontrerà Carrà e De Pisis.
In questa fase di sperimentazione egli esprimeva nelle proprie opere il senso di vuoto, l’assenza di tempo, con le sue architetture in bilico tra realtà e irrealtà.
Le tele, esposte alla galleria di Guillaume, furono fonte di ispirazione per i surrealisti.
Il cinema degli anni Dieci

Fotogramma del primo episodio di "Intolerance" di Griffith, 1916
Nei primi decenni del Novecento il cinema divenne, in particolare in Europa, luogo di sperimentazione di nuove tecniche. In Germania dominava l’espressionismo che scelse di narrare, attraverso le pellicole cinematografiche, inquietudini e angosce di quegli anni. Il cinema sovietico, frutto della nazionalizzazione dell’industria cinematografica, produsse importati film-saggio sulla Russia post-rivoluzionaria non tralasciando la sperimentazione di nuove tecniche.
In Francia venne prediletto il cinema impressionista che tendeva a comunicare allo spettatore le emozioni dei protagonisti.
Gli Stati Uniti invece si muovevano in una direzione più commerciale di cui Hollywood rappresentava già l’emblema.
Photogénie: l’impressionismo francese

Albert Dieudonné interpretò Napoleone in "Napoléon" di Abel Gance, 1927
Abel Gance, Jean Epstein, Louis Delluc, e più tardi Dimitri Kirsanov, Marcel Herbier, e Jean Renoir, furono i registi che, in Francia a partire dal 1918, sperimentarono una nuova forma d’arte cinematografica che si opponeva al cinema ‘ufficiale’ fino ad allora dominante.
L’impressionismo cinematografico ripercorreva i passi che i pittori impressionisti avevano compiuto nell’ultimo ventennio dell’Ottocento: allora Monet, Renoir, Sisley rifiutando l’arte accademica avevano propugnato un nuovo stile pittorico basato sulla scomposizione dei colori che rendesse più libera la sensibilità dell’artista. Monet in particolare studiò il mutare della luce durante la giornata raffigurando il medesimo soggetto in differenti ore del giorno componendo la serie de le Ninfee e delle Cattedrali di Rouen.
L’impressionismo cinematografico si sviluppò più tardi ma nasceva dalla comune esigenza di superare le tecniche allora in voga, che vincolavano il cinema ad un accademismo sorpassato, e di suscitare nello spettatore un’esperienza emotiva. Essi introdussero il concetto di Photogénie che si fondava sulla possibilità di presentare soggetti e oggetti estrapolati dagli scenari in cui erano normalmente collocati, assumendo perciò dei significati propri. Di frequente fecero uso di effetti speciali ottenuti attraverso mascherine, filtri e specchi deformanti in modo da modificare le immagini consuete e far percepire allo spettatore in maniera diretta le impressioni dei personaggi. Uno dei film che meglio esemplifica questa tecnica narrativa è quello di Herbier L’Eldorado (1912) nel quale la preoccupazione della ballerina, protagonista del film, per il figlio malato e la distrazione che ne deriva viene resa attraverso la sfumatura della sua figura alla quale si contrappongono, invece, le nitide figure di coloro che le sono accanto.
La loro sperimentazione venne sostenuta dalle grandi case cinematografiche e non rimase perciò un’esperienza isolata.
Le simbologie del cinema tedesco

La Torre di Babele del film "Metropolis" di Lang, 1926
L’espressionismo è la corrente più originale della cinematografia tedesca dei primi anni del Novecento: non furono solo il cinema e l’arte d’altro canto a orientarsi in questa direzione, ma anche l’architettura, il teatro e la letteratura.
Nel cinema si prediligeva la deformazione della realtà, la ricorrenza di simbologie ossessive e tutto quanto potesse rendere la drammaticità dello stato d’animo e potesse rievocare la tragicità dei fatti narrati, mostrando gli istinti animaleschi e la vita psichica più recondita dei personaggi.

Le forme deliberatamente distorte di una scena del film Il gabinetto del dott. Caligari di R. Wiene, 1919
Il film emblema dell’espressionismo tedesco è Il gabinetto del dottor Caligari di R. Wiene del 1920; ma anche le opere di F. Lang, sempre degli anni Venti, Destino, Il dottor Mabuse, e Nosferatu di F.W. Murnau, Ombre ammonitrici di A. Robison e Vanina di A. von Gerlach. Chiude la serie, nel 1925, Faust di F.W. Murnau.
Parallela all’espressionismo si svolse però anche la produzione del regista Ernst Lubitsch, che fece parte del filone kolossal storico che prese le mosse dalla sua Madame Dubarry nel 1919.
A partire dalla metà degli anni Venti, salvo poche eccezioni, il cinema tedesco subì un crollo qualitativo provocato in parte dall’emigrazione dei registi tedeschi verso l’America e Hollywood e in parte perché raggiunti in patria da capitali finanziari che spingevano verso una produzione più leggera e verso un’ ‘americanizzazione’ delle pellicole.
Agosto 1919: nasce il cinema sovietico

La carrozzina sulla scalinata di Odessa, famosa scena de "La corazzata Potemkin" di Sergej Ejzenstein, 1925
Nel 1919 l’industria cinematografica zarista venne nazionalizzata: le pellicole sovietiche furono prodotte però solo a partire dal 1922 con la fine della guerra civile.
Gli anni della conquista del potere dei Soviet furono per il cinema anni di sperimentazione da parte di avanguardie anche con poetiche molto diverse tra loro. In particolare ‘Il laboratorio sperimentale’ di Kulesov, ‘La fabbrica dell’attore stravagante’ di Feks e i Kinoki furono quelli maggiormente sostenuti dal governo. Da questo fiorire di iniziative emersero i quattro registi più significativi di quell’epoca: Ejzenstejn, Dovzenko, Pudovkin e Vertov.
Alcuni privilegiando gli aspetti legati al montaggio, altri l’immagine o il meticoloso lavoro di regia, crearono dei film strettamente connessi alla realtà rivoluzionaria, e profondamente aderenti all’ideologia bolscevica, diventando quasi dei ‘saggi cinematografici’ rappresentativi dell’epoca.
Nonostante la nazionalizzazione dell’industria cinematografica, non fu ostacolata la nascita di società indipendenti che esprimevano poetiche di altro genere.
I primi passi del cinema Usa: Hollywood

Jack e sua madre, una scena del film "Il cantante di jazz" di Crosland, 1927
Hollywood, prima ancora che un simbolo di una concezione del cinema e della comunicazione, è un luogo fisico, una località nei paraggi di Los Angeles, in cui nel 1907 uno sparuto gruppo di cineasti stabilì alcuni teatri di posa. Dopo gli esordi ancora poco celebri (The squaw man, primo film del regista Cecil B. de Mille), è il dopoguerra, con il prepotente progresso economico dell’intera nazione, a sancire la definitiva consacrazione di Hollywood quale capitale mondiale della cinematografia. Uno sviluppo che si sviluppò, in sintonia col più generale “spirito” statunitense, a livello soprattutto quantitativo: le grandi compagnie cinematografiche (Fox, Paramount, Universal, Loew, Metro Pictures Corp) rappresentavano infatti dei veri e propri colossi finanziari che investivano ingenti capitali in una “macchina” che sfornava pellicole alla stregua di qualsiasi altro prodotto di consumo. Il battage pubblicitario si integrava perfettamente con la produzione filmica, contribuendo enormemente, attraverso la “creazione” dello star-system, alla mitizzazione dell’intera galassia hollywoodiana.
“Parade”, il “ballet realiste”

Frontespizio della riduzione del balletto per pianoforte a 4 mani, costumi e scene di Pablo Picasso
Erik Satie fu un compositore fortemente predisposto alla collaborazione con altri generi artistici; egli, infatti, collaborò con pittori, scrittori, e con scenografi. Frutto significativo di questa collaborazione fu ad esempio il “balletto realista” Parade, che fu messo in scena nel 1917 al Ballets Russes, a Parigi, il cui testo era stato scritto da Jean Cocteau e costumi e scene disegnati da Picasso.
L’opera, connotata da bizzarria e irriverenza, non fu apprezzata dalla borghesia parigina ma questo non smorzò la tensione di Satie verso la ricerca dei valori più veri nella semplicità. Le sue composizioni più importanti, sono Ogives e Gymnopédies, della fine dell’Ottocento, le musiche per Les Ballets Russes e, sintesi estrema della sua opera, Socrate, una cantata per quattro soprani, entrambe degli anni Venti.
Nuovi ritmi e sonorità: Stravinskij

Stravinsky e Rimsky-Korsakov (a sinistra)
Igor Stravinskij nato vicino Pietroburgo, alla fine dell’Ottocento compose lungo l’arco di quasi un secolo (morì nel 1971) musiche incessantemente diverse caratterizzando la sua arte per una costante ricerca.
Dopo le prime opere composte negli anni Dieci, che attingevano direttamente dalla tradizione russa – L’oiseu de feu Petrouschka – con le quali esordì a Parigi, compose rispettivamente nel 1913 e nel 1918 Le sacre du printemps e L’histoire du soldat, opere nelle quali sgomentava gli ascoltatori con ritmi nuovi e violenti. Nel 1918-19 scrisse Ragtime e Rag-music accostando musiche popolari al primo jazz. Si può anzi pensare che egli fosse uno dei primi estimatori, in ordine di tempo, delle sonorità d’oltreoceano.

"The King & Carter Jazzing Orchestra" fotografata a Houston, Texas
Il jazz, nato alla fine dell’Ottocento a Chicago e New Orleans tra la popolazione di colore, negli anni dopo la prima guerra mondiale era soprattutto rag time (suonato al pianoforte) e blues (cantato) e cominciava a diffondersi tra i bianchi anche al di fuori degli Stati Uniti, portando nuovi stimoli nell’ambiente musicale.
L’Ulisse sulla “Little Review”

"Ulysses", Egoist Press, 1922
Nel 1918 l’opera più importante di Joyce, divenuta un simbolo della letteratura del Novecento, apparve a puntate sulla “Little Review” stampata a New York. Ma non fu solo oltreoceano che si colse l’importanza del romanzo di James Joyce visto che, nel 1921 quando la pubblicazione era ancora solo parzialmente stampata, Valéry Larbaud, allora il maggiore critico letterario francese, tenne una conferenza in una nota libreria parigina.
Nel 1922 l’Ulisse venne pubblicato integralmente: consta di 18 capitoli che descrivono un arco di tempo di 24 ore con continui rimandi alla tradizione omerica dell’Odissea. Leopold Bloom, il protagonista, rappresenta il moderno Ulisse. La narrazione procede secondo quello che è stato definito il ‘flusso di coscienza’. Joyce ha riportato senza mediazioni, direttamente sulla pagina, i pensieri e le immagini così come nascevano nella testa dei protagonisti, motivo per cui è stato ed è considerato un capolavoro della narrativa contemporanea.
La strada di Swann: nasce la Recerche di Proust

Jacques-Émile Blanche, "Ritratto di Marcel Proust"
Il primo volume del romanzo di Proust venne stampato nel 1913. È ambientato, come gli altri sette, nella Parigi di fine Ottocento e mette in luce il percorso interiore del protagonista che a partire da eventi minimi e casuali della realtà rilegge e indaga sulle scelte e sui significati di eventi accaduti nel passato.
L’ottica psicoanalitica che emerge nel romanzo, scritto negli stessi anni in cui Freud elaborava le sue teorie, è l’affermazione dell’idea che solo attraverso la memoria l’uomo può cogliere tutti i mutamenti e le trasformazioni cui nel corso del tempo è sottoposto.
Uno dei brani più significativi, e più citati, per descrivere l’intento di Proust è quello della ‘maddalenina’ quando il protagonista immergendo distrattamente un biscotto nel tè viene riportato immediatamente al passato e invaso da una sensazione di piacere, lontano dalle contingenze in cui si trovava a vivere nel momento immediatamente precedente. Il sapore della maddalenina aveva suscitato in lui ricordi felici del passato, ma più egli tenta di coglierne l’origine ripetendo l’operazione, più essi svaniscono.
Scienza e Tecnologia
La relatività generale
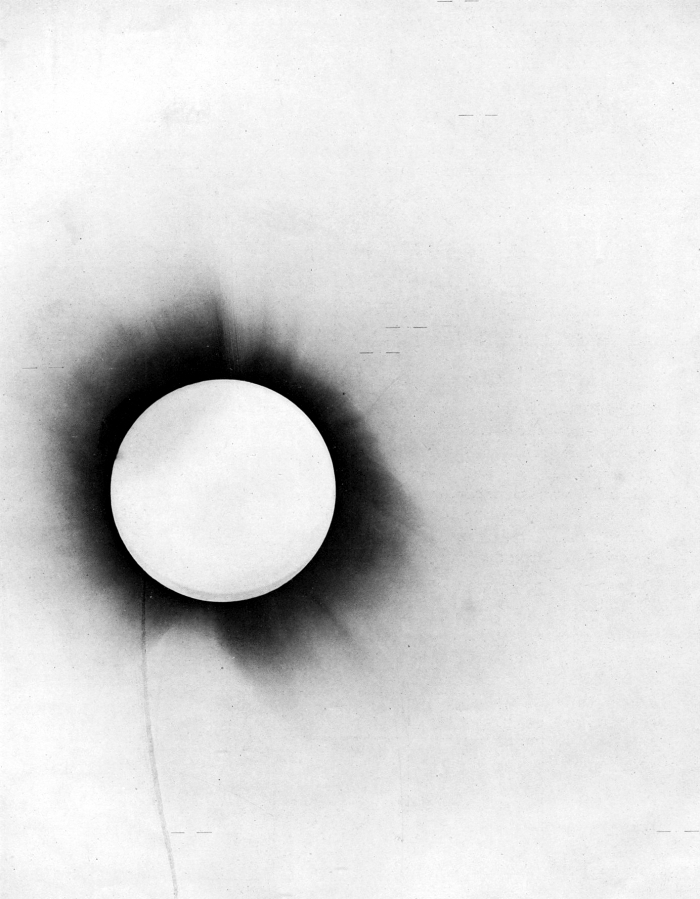
L'eclissi del 1919 che fornì una prova a sostegno della teoria della relatività generale
Dopo aver elaborato, nel 1905, la teoria della relatività ristretta, Einstein la sviluppò ulteriormente giungendo ad una teoria della relatività generale che estendeva il principio della relatività ristretta ad ogni sistema di riferimento, permettendo anche la descrizione dei fenomeni gravitazionali. Le novità introdotte non si limitarono ad influenzare la fisica teorica, ma anche filosofia in merito al rapporto tra spazio e tempo.
Einstein affermò l’impossibilità di distinguere accelerazione e gravità in maniera oggettiva: l’affermazione è sostenuta da calcoli matematici molto complessi, ma può essere resa comprensibile con due semplici esempi.
Si immagini un’astronave che si muove nello spazio con una forza di accelerazione verso l’alto uguale alla gravità terrestre (1g” title=” >}}: se all’interno dell’astronave venisse lasciata cadere una palla la si vedrebbe giungere al pavimento esattamente come avviene sulla terra. L’eventuale osservatore esterno che potesse guardare cosa accade sull’astronave vedrebbe, però, la palla ferma e il pavimento dell’astronave che le va incontro colpendola.
Allo stesso modo se gli occupanti dell’astronave salissero su una bilancia avrebbero un peso uguale a quello che hanno sulla terra, ma chi osservasse dall’esterno vedrebbe la bilancia premere verso l’alto. Tali esempi ci fanno comprendere perché non sia possibile una distinzione oggettiva tra accelerazione e movimento e che mostrano che lo spazio che noi vediamo è determinato da raggi di luce che si propagano nel vuoto in linea retta e le cui traiettorie vengono deviate dai campi gravitazionali dei corpi celesti divenendo linee curve.
Nel 1919, pochi anni dopo l’elaborazione di questa teoria, un’eclissi di sole dimostrò che quest’ultimo poteva deviare i raggi luminosi delle altre stelle: una nuova idea di spazio era nata dalla teoria della relatività generale.
Ritorno a Cartesio

Ritratto di Cartesio
Le implicazioni filosofiche della teoria della relatività generale di Einstein furono di notevole importanza poiché attingevano alle questioni del tempo e dello spazio che avevano costituito alcune delle domande più ‘antiche’ nella cultura occidentale.
Einstein scrisse “Non esiste uno spazio vuoto”, avallando l’idea di Cartesio che aveva sostenuto di non poterne affermare l’esistenza; e aggiunse che l’affermazione cartesiana appariva assurda solo se la realtà fisica veniva vista nei corpi ponderabili.
Con la riscoperta di Cartesio, Einstein si allontanò nettamente da Newton e modificò i presupposti dei ragionamenti dei fisici classici introducendo l’idea di “campo” che permetteva di rivelare, insieme al principio generale di relatività, il punto centrale dell’idea di Cartesio: “non esiste spazio vuoto di campo”.
L’effetto fotoelettrico secondo Einstein

Albert Einstein, 1921
Einstein proseguì alla soluzione di interrogativi lasciati ancora insoluti dalle teorie di Planck. Quest’ultimo aveva stabilito che la luce fosse costituita da corpuscoli di energia detti “quanti, che si muovevano in modo ondulatorio. Einstein dimostrò che un metallo stabile colpito da una luce, o da un’altra radiazione elettromagnetica, può liberare cariche negative. Questo fenomeno, chiamato effetto fotoelettrico, gli fu comprensibile grazie alla precedente teoria dei “quanti” che aveva già evidenziato la natura particellare della luce.
L’esperimento che Einstein condusse dimostrò che se una superficie metallica veniva colpita da una radiazione con un’alta frequenza, dalla superficie si staccavano degli elettroni: ma il numero di elettroni che si staccavano non era proporzionale all’intensità della radiazione che colpiva la lastra. Infatti, l’energia massima degli elettroni, e perciò la loro velocità, dipendeva dalla frequenza della luce incidente e non dall’intensità della luce.
Definì, infatti, “effetto fotoelettrico” il processo attraverso il quale le radiazioni elettromagnetiche vengono trasmesse e assorbite dai corpi sotto forma di “quanti”; tutte le volte che un “quanto” di energia colpisce un elettrone quest’ultimo viene liberato.
La scoperta del nucleo atomico e l’apporto di Bohr

Sir Joseph John Thompson
Il primo modello di atomo, stabilito da Thomson nel 1904, non contemplava l’esistenza di un nucleo. Secondo questa interpretazione la massa atomica sarebbe stata costituita da elettroni con carica negativa disposti su anelli concentrici che ruotavano su una sfera con carica positiva che ne neutralizzava la carica.
Ernest Rutheford (1871- 1937) nel 1911 stabilì, attraverso esperimenti sulle particelle alfa e sulle loro deviazioni (dette scattering” title=” >}}, il primo modello di atomo in cui si poneva al centro un nucleo dotato di carica positiva attorno al quale ruotavano elettroni con carica negativa. L’esperimento che egli aveva condotto era il seguente: sottoponendo una lamina d’oro ai raggi alfa aveva notato che molte delle particelle riuscivano a oltrepassare la lamina mentre altre venivano respinte. L’ostacolo che le bloccava doveva essere una massa forte e compatta posta al centro dell’atomo. Le deviazioni si potevano spiegare, infatti, solo immaginando che all’interno dell’atomo vi fosse una carica positiva (il nucleo) compatta e forte in cui si addensasse la maggior parte della massa atomica.
Di qualche anno più tardi è il saggio di Niels Bohr On the costitution of atoms and molecules, pubblicato nel 1913, che costituisce un salto di qualità rilevante nella teoria della fisica atomica, tanto che il fisico è stato paragonato, per l’importanza della sua elaborazione, a Galileo e a Newton. Partendo dalle teorie sui “quanti” di energia di Planck e unendole a quelle sulla struttura interna degli atomi, egli elaborò il modello planetario.
Nel suo saggio egli affermò che l’atomo quando si trova in uno “stato stazionario”, non emette radiazioni: emette o assorbe, invece, radiazioni quando passa in maniera improvvisa da uno stato di energia ad un altro.

Partecipanti al Congresso Solvay del 1927: (ultima fila, in piedi) Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph H. Fowler, Léon Brillouin; (fila centrale, seduti) Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr; (fila davanti, seuduti) Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Antoon Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Charles Eugène Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson
L’energia – e si tratta di un’ulteriore novità – non viene emessa (o assorbita) in modo graduale ma per unità “discrete”. Le radiazioni, e cioè le porzioni di energia denominate “quanti”, non vengono emesse con continuità e dunque si può concludere che negli atomi vi siano delle orbite fisse con contenuto energetico differente, sulle quali circolano gli elettroni. L’emissione delle radiazioni avviene quando un elettrone salta da un’orbita a maggiore livello di energia ad una a minore livello energetico. Le orbite tra le quali un elettrone può saltare vengono indicate con un numero n “numero quantico” dai valori interni positivi.
Questa rilevazione permette di calcolare l’energia di un ‘quanto’ e di spiegare il funzionamento degli spettri atomici che con le loro righe indicano una discontinuità di energia. Da allora i dati spettroscopici possono essere interpretati.
Il passaggio della cometa

Passaggio della cometa di Halley, 1910
Nel 1910 il mondo intero rimase sconvolto dall’apparizione di un corpo celeste, la cometa, che suscitò ovunque un diffuso sentore di catastrofe. In realtà si trattava della cosiddetta “cometa di Halley” (dal nome dell’astronomo inglese, Edmund Halley, che nel 1682 per primo ne rilevò l’esistenza), che periodicamente, ogni 75 anni, diventa visibile dal pianeta terrestre. Più in generale, tali corpi descrivono orbite ellittiche, notevolmente allungate, si muovono all’interno del sistema solare e spesso vengono turbate, nel loro moto, dall’azione di altri pianeti. Gli astronomi sono soliti distinguervi parti differenti, un nucleo, una chioma, una coda, pur risultando assai eterogenee morfologicamente. Il nucleo è costituito da metano, ammoniaca, anidride carbonica e acqua allo stato solido: approssimandosi al sole, tali sostanze tendono a sublimare, generando una chioma gassosa, una cui parte va a costituire quella che noi percepiamo come “coda”.
La medicina
I maggiori progressi in campo medico furono compiuti negli anni successivi alla prima guerra mondiale ma, sia dal punto di vista dell’evoluzione delle teorie psicoanalitiche, sia per quello che riguarda la medicina vera e propria, gli anni Dieci rappresentarono un importante passo avanti. E’ proprio in questi anni, infatti, che si giunse all’individuazione dell’origine del tumore e si iniziarono a sperimentare le prime cure.
Jung e Adler si allontanano da Freud

Alfred Adler
Nel 1910 venne fondata l’Associazione Psicoanalitica internazionale: la psicoanalisi nata pochi anni prima continuava a svilupparsi anche attraverso scissioni interne.
Carl Gustav Jung, collaboratore di Freud a Vienna, si distaccò dal maestro fondando la scuola di psicologia analitica. La sua visione della libido e dell’inconscio non collimavano con quelle di Freud. Jung non si riferiva alla libido richiamando solo un carattere sessuale e ridefinì il concetto nella sua opera del 1912 Trasformazione della libido; egli ipotizzava, inoltre, l’esistenza, accanto all’inconscio individuale, di un inconscio collettivo al quale afferivano le esperienze ancestrali e archetipiche del genere umano che erano evidenziabili sia nei sogni, sia nelle leggende.
Anche Alfred Adler si allontanò, nel 1911 dalla scuola e dall’interpretazione psicoanalitica freudiana andando a fondare la Scuola di Psicologia individuale. Motivo della scissione fu in primo luogo la sua attenzione all’importanza della dimensione sociale nello sviluppo della personalità. Nel corso degli anni Dieci pubblicò Il temperamento nervoso (1912), Prassi e teoria della psicologia individuale (1918).
La scoperta del cancro

Yamagiwa Katsusaburō
Fin dai primi anni del XX secolo l’epidemiologia mise in luce come l’insorgenza di tumori fosse provocata da fattori tossici esterni. Era stato, per esempio, riscontrato il collegamento tra insorgenza del tumore e determinate professioni: gli spazzacamini erano frequentemente soggetti al tumore allo scroto e molti operai impegnati nella produzione e lavorazione di coloranti come l’anilina venivano colpiti dalla terribile malattia.
Nel 1911 due ricercatori giapponesi, Yamagiwa e Ichikawa, diedero una parziale spiegazione sulla formazione delle masse tumorali. Essi avevano ricondotto la comparsa dei tumori alla contaminazione con alcune sostanze chimiche e in particolare con il catrame: avevano verificato, in laboratorio, che sulla pelle di alcuni animali, spennellata col catrame, insorgeva il cancro.
A fianco delle cause chimiche furono indagate anche le altre possibili origini delle masse tumorali; si intrapresero studi anche sulle radiazioni e sulle cause genetiche (tumori spontanei).
Le prime cure contro il cancro
I rimedi usati per la cura del cancro, o semplicemente per rallentarne gli effetti mortali, erano prevalentemente sostanze “velenose”: l’arsenico veniva spalmato sui tumori della pelle, il cloruro di zinco il clorato di potassio e gli acidi lattico, formico e acetico (tutte sostanze corrosive) venivano diffusamente somministrati ai malati.
Nei primi anni del Novecento Moseting-Moorhof un medico tedesco provò a fermare la proliferazione delle cellule tumorali con iniezioni di anilina ma si rivelò poi troppo tossica e venne sostituita con un altro colorante: il blu di metilene.
Dopo la prima guerra mondiale vennero sperimentate altre sostanze derivate dall’azoto relativamente più efficaci. Ma l’opinione diffusa era che la cura migliore fosse l’intervento chirurgico per l’asportazione delle zone attaccate dalla malattia.
Nuovi strumenti di guerra: carri armati e aerei

Primo tank usato in battaglia, il British Mark I, usato dagli inglesi nella battaglia della Somme (1916)
Con la prima guerra mondiale si inaugurò una sempre più capillare sperimentazione di strumenti tecnologici applicati alla guerra.
Non solo venne introdotto l’uso delle mitragliatrici e gli eserciti furono dotati di carri per il trasporto delle truppe, ma soprattutto furono introdotti i carri armati impiegati per la prima volta nel 1916 sul fronte occidentale, divenendo poi uno dei simboli delle due guerre mondiali.
Colpì altrettanto anche l’introduzione dell’aereo prima utilizzato per le ricognizioni, fotografiche e non, delle zone di guerra e poi come supporto alle operazioni belliche.
L’aeronautica si sviluppò da quel momento in poi in modo consistente e rapido: nuovi motori, nuove eliche, nuove strutture sempre più robuste – nate dalla sperimentazione di vari materiali – e velocità sempre più elevate.
L’aviazione: una nuova dimensione bellica

Ricostruzione dell'aereo del barone rosso, un Fokker DR.1 Triplane
Con la prima guerra mondiale gli aerei passarono dall’essere strumento pionieristico di eroismo individuale a strumento di guerra sempre più efficiente. La velocità degli aeroplani consentì di colpire obiettivi dall’alto, allontanarsi velocemente e indenni.
Durante il primo conflitto mondiale vennero prodotti diversi modelli adatti a molteplici usi: caccia, bombardieri, ricognitori. Francesco Baracca progettò il biplano che, insieme al caccia tedesco del Barone Rosso, faranno da protagonisti dell’aviazione in quel periodo in compagnia anche del Sopwith Camel e del Fokker , entrambi ulteriormente perfezionati alla fine del conflitto.
Gli aerei bombardarono le retrovie dei nemici, furono d’ausilio alle artiglierie fornendo indicazioni per i movimenti delle truppe ed ebbero mitragliatrici sincronizzate al movimento delle eliche. Indubbiamente questi grandi uccelli d’acciaio sconvolsero popolazioni e soldati incapaci d’immaginare prima d’allora che la guerra venisse anche dall’alto.
Blocco navale e guerra sottomarina

Un sottomarino U-Boot SM U 35, a sinistra, e uno SM U 52, a destra, si incontrano nel mediterraneo
Il mare costituiva, durante la prima guerra mondiale, il principale canale di trasferimento dei rifornimenti e delle risorse dirette ai paesi belligeranti provenienti, per lo più, dalle colonie. Fu per questo che controllare e ostacolare gli spostamenti navali rappresentò uno dei migliori strumenti per assicurarsi il buon esito della guerra. La Gran Bretagna riuscì proprio con un blocco navale a ridurre sempre più le capacità di resistenza della Germania: bloccando l’accesso al Mare del Nord, impediva l’arrivo a destinazione dei rifornimenti per le truppe che combattevano nel centro Europa. Nonostante che la Germania avesse provato più di una volta a forzare il blocco utilizzando contro la prestigiosa flotta britannica la sua flotta nazionale, non riuscì a vincere l’Inghilterra, come ben ricordano gli esiti della battaglia navale che si svolse nella penisola dello Jütland.

Il capitano Turner a bordo del Lusitania
Da allora la Germania inaugurò l’uso dei sommergibili e, agevolata dall’invisibilità e dalla potenza di fuoco di questi ultimi, nei primi mesi del 1917 riuscì ad affondare 110.000 tonnellate di carico agli inglesi, colpendo dal basso gli scafi delle loro navi. La flotta tedesca affondò anche, e sarà l’episodio che spinse gli USA all’ingresso in guerra, il transatlantico Lusitania, nave civile che trasportava anche molti passeggeri americani.
Solo alla fine del 1917 la Gran Bretagna riuscì a sviluppare strumenti di difesa contro i sottomarini tedeschi, tornando ad essere la potenza navale che era, ostacolando con l’intensità precedente i movimenti delle navi tedesche. Sarà perciò l’esaurimento delle forze una delle principali ragioni del crollo della Germania.
L’altra faccia del progresso: il disastro del Titanic

Il Titanic attraccato al molo nel porto di Southampton prima della partenza
Il Titanic affondò la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912: era il primo giorno del viaggio inaugurale della più grande nave destinata al trasporto di passeggeri dichiarata inaffondabile.
Le compagnie di navigazione britanniche e tedesche si facevano concorrenza nella costruzione di transatlantici da passeggeri: la compagnia britannica, White Star, mise in cantiere, nel 1911, una nave che potesse trasportare 3.000 passeggeri.
Le ragioni del naufragio sono ancora circondate dal mistero, ma l’ipotesi più volte sollevata fu che il comandante avesse scelto di percorrere la rotta più breve dirigendosi verso nord non sapendo che la zona fosse piena di iceberg.
La nave, scontrandosi con uno di questi iceberg, si divise in due tronconi e affondò a sud dell’isola di Terranova: i passeggeri di seconda classe andarono a costituire il maggior numero delle 1.635 vittime poiché le vie d’uscita gli furono sbarrate per consentire ai ricchi e influenti passeggeri della prima classe di prendere posto sulle scialuppe di salvataggio.
Il segnale di allarme SOS lanciato via radio, per la prima volta, non venne captato da nessuna nave rendendo così inevitabile la tragedia che si impresse indelebilmente nella memoria dell’opinione pubblica.
L’affondamento del Titanic oltre a costituire una sconfitta per la marina mercantile inglese, rappresentò, per gli europei, il simbolo della persistente debolezza umana rispetto alle forze della natura che, al contrario, si credeva essere sotto il pieno controllo degli uomini e della tecnologia.
Il Pensiero
Logica e matematica, un nuovo connubio
Il superamento della logica sillogistica aristotelica che aveva costituito la base delle elaborazioni medievali in materia pareva aver destinato la logica stessa ad un definitivo accantonamento, fino all’inizio del Novecento. Ad inizio secolo si assisté, invece, ad un rinnovato interesse per la materia, che venne tuttavia rivoluzionata nei suoi fondamenti metodologici: vide la luce, infatti, quel connubio con la disciplina matematica che sarà foriero di intensi sviluppi, in particolare nella filosofia analitica. Si trattò di una vera e propria rifondazione della disciplina, denominata spesso “logica simbolica”: essa venne rigorosamente formalizzata attraverso l’utilizzo di strumenti matematici, quali funzione, costanti, variabili. Alla base del processo di “matematizzazione” della logica si pone un intenso lavoro di analisi del linguaggio, che venne sezionato nella sua composizione strutturale: fondamentale risultò l’apporto di G. Frege, al quale si deve l’introduzione dei “quantificatori”.
Nel Novecento questa nuova branca, connubio di filosofia e scienza, ha conosciuto uno sviluppo inaudito, diramandosi in numerosi settori specialistici sia secondo l’ambito d’indagine (ad esempio semantica e sintattica) sia in base al metodo applicato, come nei casi, ad esempio, della logica “modale”, la logica “intuizionista”, la logica del primo ordine e quelle di ordini superiori.
Frege e i fondamenti della matematica
Il contributo di Gottlob Frege (1848-1925) allo sviluppo della logica contemporanea si inserì nel solco teorico già tracciato dall’irlandese George Boole (1815-1864), dal tedesco Ernst Schröder (1841-1902), e dall’italiano Giuseppe Peano (1858-1932), che a loro volta avevano messo a frutto il presupposto metodologico di sintesi tra logica e metodo matematico intravisto già nel XVII secolo da Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Frege muoveva i suoi passi dal presupposto comune alle scuole criticistiche tedesche (vale a dire l’indipendenza e la conseguente validità del concetto), dal riferimento alle cose empiriche e dalle operazioni psichiche che lo formulano. Ne costituisce un esempio la nozione di numero, che Frege sintetizzò così: “l’attribuzione di un numero contiene sempre un’affermazione intorno ad un concetto”, teorizzazione che veniva sussunta al tentativo di far convergere logica e aritmetica tramite, appunto, la definizione in termini logici dei concetti dei numeri. Tale tentativo, che avrebbe trasformato gli assiomi matematici in teorie puramente logiche, si dimostrò tuttavia destinato a fallire, dato che Frege fece ricorso ad una teoria degli insiemi che si rivelò infondata. Attualmente, nonostante altri illustri e differenti tentativi in tal senso (ad esempio di B. Russell), si tende a considerare la “teoria degli insiemi” come un ambito autonomo dalla logica formale.
Bertrand Russell: un mondo di “oggetti semplici”
Un altro dei fondamentali contributi di Bertrand Russell alla filosofia contemporanea è costituito, oltre alla logica, dalla teoria del linguaggio. In un suo scritto del 1918, Filosofia dell’atomismo logico, egli ne delineava così i capisaldi: 1) il linguaggio è costituito da proposizioni; 2) gli elementi che costituiscono le proposizioni (i simboli) significano i “costituenti” dei fatti che rendono vere o false le proposizioni; 3) solo la conoscenza diretta degli elementi che costituiscono i fatti consente di capire il significato dei simboli; 4) la conoscenza diretta muta da individuo a individuo. I costituenti dei fatti rappresentano i “fatti atomici”, entità non scomponibili ulteriormente, detti anche “oggetti semplici”. Tali oggetti costituiscono dati sensoriali, dei quali si ha una conoscenza diretta (ad esempio sapori, colori, odori), mentre gli “oggetti complessi” sono conoscibili soltanto in maniera indiretta. Quindi, secondo Russell, la conoscenza indubitabile sarebbe relativa ai soli oggetti semplici, che rappresentano la base del parallelismo tra ordine della realtà, ordine del linguaggio e ordine della conoscenza. Tuttavia il problema nasce quando si constata che il linguaggio non è costituito solo da nomi (simboli) ma anche da “verbi”, che esprimono relazioni tra oggetti, quindi oggetti non percepibili, fuori dal tempo e dallo spazio: si pone così il problema degli universali. D’altra parte Russell ammetteva, in modo apparentemente contraddittorio, che si potesse parlare di oggetti senza averne una conoscenza diretta: e lo ammetteva attraverso la teoria della “denotazione”. Esistono infatti frasi che non asseriscono alcunché circa oggetti esistenti, ma dicono invece qualcosa sui simboli presenti nella frase stessa: ad es. “l’autore di Romeo e Giulietta è inglese” non asserisce nulla circa Shakespeare (non contiene alcun atomo logico che denoti Shakespeare) ma deve essere interpretata come se dicesse: “esiste una sola entità che scrisse Romeo e Giulietta e chiunque scrisse Romeo e Giulietta è inglese”. Una simile traduzione della frase denotante rende possibile parlare anche delle cose non esistenti.
L’idealismo gnoseologico kantiano
Il termine idealismo ha assunto, nel corso della storia del pensiero filosofico, due significati fondamentali. Il primo, di natura gnoseologica, implica la tesi secondo la quale la realtà, gli oggetti della conoscenza, sono rappresentazioni mentali, “idee”, e dunque costituisce la premessa di una teoria della conoscenza. Il secondo, invece, si basa sulla concezione del pensiero quale attività creatrice degli oggetti e della realtà esterna e non soltanto quale sede delle rappresentazioni mentali. In questo caso da una valenza gnoseologica, il termine “idealismo” passa ad assumere un significato ontologico, relativo cioè alla struttura dell’essere, della realtà, e non soltanto alla sua conoscibilità. Immanuel Kant, nel fondare il proprio idealismo critico, identificava tali “idee” con le strutture a priori della mente (idea di spazio, di tempo, categorie dell’intelletto), che costituiscono le premesse necessarie dei giudizi sintetici a priori e che appartengono al soggetto e non all’oggetto; quest’ultima caratteristica li rende indagabili e giustificabili, in maniera tale da poter garantirne la validità di asserti scientifici. La nostra conoscenza del mondo, in quanto legata alle universali strutture a priori, risulta comunque limitata ai fenomeni: la radice, l’essenza ultima delle cose (il noumeno) era, secondo Kant, preclusa alla mente umana, escludendola possibilità, in linea di principio, di una “intuizione intellettuale”, in sostanza di un’illuminazione interiore. L’“io-penso” rappresenta nel criticismo kantiano la funzione logica che unifica le operazioni conoscitive dell’intelletto: è implicito dunque che assuma una valenza gnoseologica e non empirica.
L’“idea creatrice” della filosofia tedesca
Gli sviluppi del pensiero kantiano ad opera della filosofia tedesca della prima metà dell’Ottocento traggono spunto dall’interpretazione in chiave idealistico-coscienzialistica sviluppata in particolare da Karl Leonhard Reinhold (1758-1823), che fu professore all’Università di Jena e la cui esegesi in particolare della Critica della ragion pura esercitò profonda influenza sull’elaborazione di Fichte, Schelling, Hegel, Fries ed Herbart. In particolare, Reinhold fornì una propria soluzione del presunto dualismo insito nella gnoseologia kantiana, quello cioè tra fenomeno e noumeno, quest’ultimo individuato come esistente e al contempo inconoscibile. Tale supposta contraddizione – che nasceva oltretutto dall’analisi della prima edizione della Critica, che molto più della seguente dava adito ad ambiguità ed equivoci in merito – venne risolta ricorrendo a quell’intuizione intellettuale che Kant aveva estromesso dalle facoltà accessibili alla mente umana. La cosa in sé era sì rappresentabile, ma non come cosa od oggetto, bensì come puro concetto: costituiva la forma della rappresentazione, a sua volta generata dal soggetto nella sua libera attività spontanea. Come si intravede, la strada verso gli sviluppi della filosofia dell’infinito e del soggetto creatore era così spianata. Nelle pur differenti elaborazioni di Fichte, Schelling ed Hegel, tali presupposti fonderanno un idealismo dai connotati ontologici assai distanti dall’impostazione criticistica datane da Kant, presupposti che influenzeranno profondamente gli sviluppi italiani di questo filone di pensiero.
Il pensiero idealista di Croce e Gentile
Alla tradizione ottocentesca di Augusto Vera e di Bertrando Spaventa, nonché agli autonomi percorsi intellettuali di Francesco De Sanctis e di Antonio Labriola, si ricollegano i due massimi esponenti dell’idealismo italiano del Novecento, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, che collaborarono lungamente con la rivista “La critica”, prima di separare le proprie strade filosofiche e personali in merito alla discriminante rappresentata dal regime fascista.
Costituiva radice comune ad entrambi l’opposizione al positivismo e ai suoi capisaldi teorici (determinismo, meccanicismo e naturalismo), nonché la riaffermazione del valore della libera attività creatrice della vita nei suoi momenti ideali e morali. D’altra parte, vi era una netta divaricazione dalle concezioni metafisico-trascendenti, che scindono l’esistente nei livelli dell’essere e del dover essere, di volta in volta identificata con Dio, l’Assoluto, la legge morale ed altro ancora, per affermare una concezione immanentistica della totalità dell’essere: la realtà è una, e il principio superiore, immutabile, vive ed opera al suo interno. Gentile e Croce furono inoltre accomunati dal continuo confronto dialettico con il pensiero hegeliano, così come la propensione per la disciplina pedagogica per la pedagogia, sfociata per il filosofo di Castelvetrano nell’attività di Ministro dell’Educazione Nazionale nel governo Mussolini dal 1922 al 1924. La dottrina dello spirito crociana era imperniata attorno alla “dialettica degli opposti” che si dispiega nei due momenti dell’attività teoretica (arte e filosofia) e nei due dell’attività pratica (etica ed economia). Legate tra loro da una rete di reciprocità, mantengono un’indipendenza del tutto relativa e una costante dialettica interna. Lo spirito può attuarsi in un concetto, in un atto di volontà o in un’opera d’arte, senza tuttavia esaurirsi in alcuno di essi. L’autoqualifica della filosofia crociana come “storicismo assoluto” sta a significare - a differenza dello storicismo contemporaneo basato sul problema critico della storiografia e delle basi teoriche dell’interpretazione – che “la vita e la realtà è storia e nient’altro che storia”: viene dunque riaffermato il principio hegeliano della coincidenza di reale e razionale, di essere e dover essere. La vera storia è, dunque, per Croce soltanto quella che ha il proprio fondamento nella concreta vita dello spirito.
La “dialettica degli opposti”: Benedetto Croce
La riflessione teorica di Benedetto Croce è concentrata durante gli anni Dieci in particolare sulle problematiche artistiche ed estetiche: del 1910 è Problemi di Estetica, del 1912 Breviario di Estetica, mentre al 1920 risale Nuovi saggi di estetica. Proprio l’estetica rappresenta un campo di incessante elaborazione del filosofo di Pescasseroli e costituisce l’ambito nel quale le idee crociane hanno forse lasciato l’impronta più duratura. L’arte costituisce il primo momento dello spirito universale: essa viene definita visione o intuizione e come tale significa immagine nel suo valore di mera immagine, che esclude qualsiasi distinzione tra realtà ed irrealtà. Ciò implica una netta contrapposizione tra conoscenza filosofico-concettuale (sempre realistica poiché intende stabilire la realtà contro l’irrealtà o a degradare l’irrealtà a momento subordinato nella realtà stessa), e dimensione artistica stessa, che al contrario illanguidisce e svanisce se si trasforma in riflessione e giudizio. In sintesi Croce afferma la totale autonomia dell’arte, che trova in sé stessa il proprio fine, ossia la bellezza, e si pone contro qualsiasi pretesa intellettualistica, edonistica, utilitaristica e moralistica. Di conseguenza l’opera d’arte e l’artista sono sempre moralmente incolpevoli: la loro vera moralità è intrinseca al loro compito e alla loro missione, vale a dire il dovere verso l’arte. Essa è sempre intuizione lirica, sintesi aprioristica di sentimento ed immagine; in quanto tale si identifica con l’espressione, e in particolare con il linguaggio della poesia, ritenuto creazione originaria dello spirito. Da qui la radicale avversione costantemente mantenuta dal Croce verso il romanzo, “l’espressione prosastica”, giacché “la sola parola è veramente l’espressione poetica”.
Il vitalismo attualistico di Giovanni Gentile
Gli anni Dieci furono il periodo nel quale prese corpo il nucleo centrale del pensiero gentiliano: del 1912 sono L’atto del pensare come atto puro e Sistema di pedagogia come scienza filosofica, del 1916 La teoria generale dello spirito come atto puro e I fondamenti della filosofia del diritto, mentre nel 1917 ha inizio la sua opera più vasta, che si concluderà nel 1922, Sistema di logica come teoria del conoscere (2 voll).
Rispetto al sistema crociano, del quale condivideva i presupposti idealistici, quello gentiliano assunse una connotazione più marcatamente e profondamente vitalistica e immanentistica. La distinzione fondante tra “pensiero pensante” e “pensiero pensato” rappresenta una suddivisione gerarchica e di valore, dal momento che il secondo costituisce una forma illanguidita e reificata dell’essere, che non assurge alla valenza di vera vita. La filosofia costituisce dunque autoconsapevolezza vivente dell’atto, il quale solo è capace di vivificare altrimenti morte astrazioni quali tutte le conoscenze relative al mondo fisico. L’Io trascendentale e assoluto rappresenta il soggetto dell’atto e i singoli individui ne sono astrazioni contingenti. Ma furono il diritto e la pedagogia gli ambiti nei quali, storicamente, il pensiero gentiliano esercitò una più profonda e rilevante influenza. Società e stato, diritto e politica non derivano infatti, secondo Gentile, da un legame pattizio tra individui ed interessi differenti e diversificati, ma sono risolti in interiore homine: la volontà volente è infatti già per se stessa il proprio comando e legge e trovandosi di fronte un comando o una legge, trova un proprio momento oggettivato. Di conseguenza la coattività delle norme giuridiche e dello stato è interiore e spirituale; diritto e morale si identificano così come stato e individuo: si tratta dunque di quelle basi teoriche che giustificheranno le future aspirazioni totalitarie del regime fascista. D’altro canto la pedagogia gentiliana, attraverso la concezione di insegnante che rivive e trasfigura nell’atto di insegnare i contenuti e i metodi particolari, poneva le premesse di quella negazione degli aspetti tecnico-scientifici dell’educazione che venne attuata nella riforma del 1923, con l’abolizione dell’insegnamento della psicologia e del tirocinio didattico negli istituti magistrali.
Il recupero del criticismo kantiano: la Scuola di Marburgo
Il cosiddetto “ritorno a Kant” si diffuse in tutti i paesi nella seconda metà dell’Ottocento, assumendo tuttavia all’inizio del Novecento, in Germania, manifestazioni particolarmente significative ed organiche, concretizzatesi nell’attività della Scuola del Baden e, soprattutto, della Scuola di Marburgo. Neocriticismo significò innanzi tutto il ritorno all’insegnamento fondamentale del filosofo di Koenigsberg, vale a dire all’esigenza di non ridurre la filosofia a fisiologia, metafisica, teologia o psicologia, ma di ricondurla al compito di analisi delle condizioni di validità del mondo dell’uomo.
L’elaborazione filosofica venne intesa ed esercitata come riflessione critica sulla scienza e sulle altre forme dell’esperienza, al fine di rintracciarvi le condizioni che ne rendano possibile la validità. Se da un lato legittimava il mondo scientifico come quello morale ed estetico come validi, d’altra parte il neocriticismo era contrario alla metafisicizzazione della scienza di matrice positivistica, così come alle integrazioni metafisico-religiose e al pensiero scientifico compiute dall’idealismo e dallo spiritualismo. Esso teneva ferma la distinzione kantiana tra validità della scienza, della morale, dell’arte e le condizioni di fatto, empiriche o soggettive, con le quali esse sono legate. Il neocriticismo è pertanto contrassegnato dalla polemica contro l’empirismo e lo psicologismo che riducono le forme del conoscere alle condizioni in cui si manifestano. La Scuola di Marburgo conduceva la distinzione kantiana tra conoscenze oggettivamente valide e percezioni come meri fatti psichici alle estreme conseguenze. Essa rappresenta l’antitesi dell’idealismo postkantiano: se quest’ultimo individuava nella soggettività pensante l’unica e sola realtà, quella la riconosce invece nell’oggettività pensabile. La quale tuttavia non ha niente a che fare con l’oggettività empirica (la natura), che ne rappresenta solo una determinazione particolare: veniva così coniugato Kant con Platone, che individuava nella pura idea il significato e il valore di ogni conoscenza possibile.
Paul Natorp, Hermann Cohen e la metodologia della scienza
Hermann Cohen (1842-1918) fu il fondatore della Scuola e pubblicò la terza parte del proprio Sistema di filosofia, Estetica del sentimento puro nel 1912. Egli, partendo dall’esperienza scientifica, affidava alla filosofia il compito di individuare le condizioni logiche immanenti dell’esperienza stessa: escludendo i fatti e comportamenti psicologici, muoveva alla ricerca di concetti “puri”, cioè di contenuti logici provvisti di una loro validità peculiare. Cohen respinse così ogni tipo di realismo, considerando la cosa in sé come concetto-limite e attribuendo alla conoscenza un valore creativo.
Paul Natorp (1854-1924) è un altro rappresentante della Scuola e produsse, oltre a studi storici su Platone, un’opera sui Fondamenti logici delle scienze esatte (1910). Dette avvio ad una nuova fase dell’interpretazione della filosofia platonica, vedendo nelle idee non tanto realtà simili agli oggetti empirici, ma più perfette, bensì regole e valori ideali, condizioni della conoscenza e della valutazione.
Sostanza, funzione, simbolo: Ernst Cassirer
Professore a Berlino e ad Amburgo e notevole, pur se originale, esponente della Scuola di Marburgo fu Ernst Cassirer (1874-1945), autore di importanti saggi sul Rinascimento e l’Illuminismo e di monografie su Leibniz, Kant e Cartesio. Il suo pensiero teoretico presenta, come sopra accennato, specifiche peculiarità rispetto alla Scuola: egli infatti valorizzò e sottolineò l’importanza dell’espressione simbolica, del linguaggio, nella costruzione del mondo umano, includendo in esso non soltanto la dimensione scientifica, ma anche quelle del mito, della religione, dell’arte. Se dunque da un lato la sua filosofia si inscrive in quell’articolato movimento del pensiero contemporaneo che considera privilegiato oggetto di indagine il linguaggio, dall’altro comunque la ricerca di Cassirer resta ancorata alle premesse di fondo della Scuola, cioè rintracciare l’origine degli oggetti della scienza e delle altre attività umane nelle strutture che ne garantiscano la validità. Nella sua fondamentale opera Concetto di sostanza e concetto di funzione (1910), sostenne che tali strutture fossero funzioni e non già sostanze, opponendo i due concetti e sottolineando come, a partire da I principi della meccanica di Hertz (1894) la scienza abbia abbandonato la nozione di sostanza e con essa la concezione di se stessa come rispecchiamento delle sostanze naturali. Veniva così implicitamente riconosciuto il valore del “segno” e con esso la funzione costitutiva del linguaggio rispetto agli oggetti della ricerca scientifica.
La filosofia delle individualità: lo storicismo
Lo storicismo prese corpo, quale corrente filosofica autonoma, alla fine dell’Ottocento, ispirandosi al criticismo kantiano e sottoponendo ad un costante vaglio critico le filosofie della storia, in particolare quelle di matrice idealistica. Il problema sostanziale che gli esponenti di tale corrente posero fu quello della coscienza storica, chiedendosi in particolare quanto la storia potesse essere considerata conoscenza, che tipologia di conoscenza costituisse e quale fosse la valenza del soggetto conoscente. Le risposte a tali interrogativi furono molteplici e diversificate, tutte comunque convergenti attorno a nodi quali la consapevolezza del carattere relativo, condizionato e non universalizzabile della conoscenza storica, nonché il rifiuto di qualsiasi ipoteca metafisica o trascendente sul percorso della conoscenza stessa. In particolare il filone tedesco di questa corrente di pensiero, sviluppatasi fino agli anni Quaranta, si soffermava sulla natura dell’oggetto della conoscenza storica, riconoscendone un’irriducibile individualità, opposta al carattere generalizzabile e ripetibile degli oggetti della conoscenza naturale. Da qui l’operazione gnoseologica fondamentale era individuata nel “comprendere” (verstehen), al quale veniva riconosciuta la capacità di descrivere le specifiche individualità storiche.
Il tramonto dell’Occidente: Oswald Spengler
La componente relativistica del pensiero storicistico venne condotta alle sue estreme conseguenze da Oswald Spengler (1880-1936). Nella sua opera più famosa e discussa, Il tramonto dell’Occidente. Abbozzo di una morfologia della storia del mondo (1918-1922), egli contrappose ontologicamente natura e storia, operazione che ad esempio Dilthey aveva compiuto da un punto di vista funzionale, facendone di due oggetti diversi due tipi di ricerca differenti. Spengler le rese incommensurabili: se la natura è la dimensione del divenuto, la storia rappresenta l’ambito del divenire, della vita che di continuo crea nuove forme. Unità di base della storia sono le culture e le civiltà, organismi che nascono, crescono e muoiono realizzando ciò di cui sono capaci. L’espletamento di questa funzione di “civilizzazione” coincide con l’esaurirsi del ciclo vitale stesso. Ogni cultura possiede una propria “natura”, una scienza, una filosofia, una morale, che le sono legate organicamente e necessariamente: al di fuori di essa sono prive di valore. Un relativismo che si delinea come un “assolutismo relativo”, relativo in quanto legato indissolubilmente al ciclo vitale della cultura (ciclo i cui sviluppi si dispiegano secondo la necessità del destino, di fronte al quale l’unica azione giustificabile è quella che va nella sua medesima direzione). Spengler vedeva nella democrazia e nel socialismo, nella crisi della morale e della religione e nella plutocrazia i sintomi evidenti della prossima eclisse della civiltà occidentale, e nell’avvento dell’autoritarismo del nazismo germanico un possibile orizzonte palingenetico.
Windelband, Rickert e l’autonomia della conoscenza storica
Entrambi i filosofi, esponenti della Scuola neocriticista di Baden, portarono alla riflessione storicistica un contributo incentrato sul tipo di scientificità delle discipline storiche. Windelband (1845-1915) stabilì una distinzione tra scienze naturali e scienze dello spirito, indicando le prime come nomotetiche, ossia rivolte a scoprire le leggi a cui obbediscono i fatti, mentre le seconde come idiografiche, vale a dire rivolte alla singolarità nella sua forma storicamente determinata, le prime ancora come scienze di leggi, le seconde come scienze di eventi.
Anche Rickert (1863-1936) fondò la differenza tra le due branche non tanto sull’oggetto, quanto sul metodo. La realtà empirica, a seconda dell’uno o dell’altro punto di vista, può essere considerata come natura oppure come storia. Tuttavia, come discernere quali siano, nella loro estensione numerica infinita, gli eventi individuali che possano suscitare l’interesse dell’indagine storica? La risposta di Rickert individuava quale discrimine i valori che costituiscono la civiltà: il valore di una determinata individualità storica è costituito dai valori fatti propri dalla civiltà cui essa appartiene.
La ricerca dell’eterno nell’attimo: Friedrich Meinecke
Storico della Germania moderna, Friedrich Meinecke (1862-1954) contrappose alla filosofia del diritto naturale la prospettiva filosofica dello storicismo: se la prima costituiva un caposaldo morale e gnoseologico, stabilendo la ragione umana come eterna ed atemporale e quindi capace di guidare l’uomo nella molteplicità delle congiunture storiche, il secondo ha trasformato la ragione stessa in forza storica, con differenti fisionomie nelle diverse epoche, inducendo ad una conseguente relativizzazione dei valori. Relativizzazione a cui Meinecke volle sottrarsi, riprendendo il pensiero di Goethe, che concepiva il ruolo individuale e relativo come assoluto ed eterno, perché voluto da Dio. Si trattava quindi di non smarrire, pur nella consapevolezza della propria finitudine storica, la sorgente di forza che deriva dalla fede in valori assoluti ed atemporali.
Il pensiero marxista: il dibattito tra riforme e rivoluzione
Parallelamente allo sviluppo politico e sociale del movimento operaio e comunista mondiale, prese le mosse una corrente di rielaborazione della filosofia marxista, che si basava sul rifiuto dell’interpretazione che ne era stata data dalla Seconda Internazionale (1889-1917). Sulla base dei parametri imperanti alla fine dell’Ottocento, si era infatti sviluppata una forma di marxismo, teorizzata principalmente da Karl Kautsky (1854-1938), permeata di categorie naturalistico-deterministiche, concretizzatasi in una visione fatalistica della storia e della transizione da capitalismo a comunismo, ritenuta ineludibile ed inevitabile. Tale tipologia di marxismo, che implicava la progressiva marginalizzazione del momento dialettico del pensiero di Marx, andava di pari passo con numerosi tentativi di “revisione” della teoria marxiana, soprattutto dal punto di vista politico. In particolare, i concetti di rivoluzione e di dittatura del proletariato vennero surrogati, in vista del necessario crollo del sistema “borghese”, da un’indefinita operazione riformistica del sistema stesso: filone questo incarnato, sul piano politico, da Eduard Bernstein (1850-1932), mentre a livello filosofico dai cosiddetti “marxisti neokantiani”: Max Adler (1873-1937) e Karl Vorländer (1860-1928). Determinismo filosofico e revisionismo politico avevano così indotto, non soltanto alla perdita di spinta rivoluzionaria, ma anche allo smarrimento dell’originale contenuto dialettico di matrice hegeliana del pensiero di Marx. Sarà contro le intrusioni positivistiche, neokantiane e empiriocriticistiche che si indirizzerà la polemica filosofica e politica del materialismo dialettico sovietico, che avrà in Nikolaj Lenin l’esponente più significativo.
Lenin: Stato e rivoluzione
La riflessione di Nikolaj Lenin (1870-1924), le cui analisi teoriche si intrecciarono con la Rivoluzione di ottobre, costituisce uno degli eventi fondamentali del Novecento. Essa si basava sull’idea di evoluzione del capitalismo nell’imperialismo, nonché sulla teoria del partito quale avanguardia della classe operaia e depositario del potere all’interno della rivoluzione proletaria. In Stato e rivoluzione (1917) il concetto di dialettica della storia costituita dalla lotta degli opposti (lotta di classe), cui debba seguire la loro sintesi finale nella società senza classi, viene applicato anche alla teoria dello stato. Esso, che rappresenta lo strumento del dominio di una classe sull’altra, si fa mezzo della classe proletaria, nel senso che la maggioranza degli oppressi reprime la minoranza degli oppressori.
Una volta instaurato il comunismo, tuttavia, lo stato tende a diventare inutile e a scomparire, visto che il nuovo sistema eliminerebbe l’occasione stessa dei delitti. La negazione dialettica sarebbe comunque conservazione e progresso, dato che le conquiste del capitalismo non verrebbero negate, bensì condotte dal comunismo ad un livello più elevato.
Rosa Luxemburg: l’accumulazione del capitale
Le conseguenze del conflitto mondiale e il potente richiamo della Rivoluzione russa portarono, anche in Germania, ad una radicalizzazione della lotta politica: il fondamentale apporto socialdemocratico alla nascita della repubblica andava di pari passo col progressivo acuirsi del conflitto ideologico e politico con il movimento rivoluzionario “spartachista”, la cui teorica fu Rosa Luxemburg. Il suo contributo teorico è efficacemente rappresentato nella sua opera principale, L’accumulazione del capitale, del 1913: essa prendeva le distanze dalle elaborazioni in chiave revisionistica e riformista di Bernstein come dalle ipotesi deterministico-fataliste sulla transizione al comunismo proprie di Karl Kautsky. Pur considerato esito inevitabile delle contraddizioni interne al sistema capitalistico-borghese, l’avvento del nuovo sistema poteva inverarsi soltanto attraverso l’azione di un proletariato organizzato e cosciente. Su queste basi, dopo l’iniziale entusiasmo per le vicende sovietiche, Luxemburg prese nettamente le distanze dalla teoria e dalla prassi del bolscevismo: accusò le misure accentratrici e partitocentriche leniniste del 1918 e 1919, di favorire la dittatura “sul” proletariato e non “del” proletariato; tali critiche venivano formulate in nome di una rinascita della vita pubblica, di un’attiva e progressiva partecipazione delle masse, di un loro completo controllo sull’attività politica, che sole avrebbero potuto garantire la vita dei Soviet.
L’austromarxismo: Max Adler e Rudolf Hilferding
La scuola marxista austriaca partecipò attivamente al dibattito aperto all’interno del pensiero marxista dalle tesi “revisioniste” a partire dalla fine dell’Ottocento: il suo contributo si indirizzava in particolare verso problematiche quali la scientificità del marxismo stesso e la fondazione dei valori del socialismo. Le suggestioni teoriche che più la influenzarono erano costituite dal filone neokantiano, nonché dall’empiriocriticismo machista (cioè di Ernst Mach): determinante risultava inoltre la prossimità, anche fisica, della Scuola viennese di economia. Max Adler e Rudolf Hilferding ne furono due tra i principali esponenti: il primo si concentrava in particolare sull’esigenza di depurare il pensiero marxista dagli elementi metafisici di stampo deterministico che, oltretutto, non erano neppure presenti nelle originali elaborazioni marxiane (la derivazione meccanica dell’ideologia dalla struttura economica non è contenuta in neppure un passo dei testi di Marx, essendo invece indicata come collegamento necessario tra i due livelli). Pertanto egli non riteneva il materialismo storico come una metafisica della storia, bensì un’indicazione programmatica a valutare attentamente l’aspetto economico nell’analisi scientifica dei fatti storici. Hilferding, che con la sua opera principale, Il capitale finanziario (1910), influenzò profondamente Lenin nella sua teoria dell’imperialismo, sostenne con forza, soprattutto prima della guerra, la coalizione con i partiti borghesi, nella convinzione che il riformismo parlamentare costituisse il presupposto per un passaggio al socialismo differente dal metodo bolscevico.