Gli Anni Ottanta
1980-89
Cronologia
1980
- 24 marzo: assassinio in Salvador dell’arcivescovo Romero. Nel corso dei funerali reparti militari sparano sulla folla compiendo una strage.
- Aprile: fallisce il tentativo di liberare, con un’azione di forza, gli ostaggi americani tenuti prigionieri a Teheran. Grave insuccesso per Carter.
- Maggio: Sacharov viene condannato al confino per aver protestato contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan.
- 4 maggio: muore il maresciallo Tito.
- Le Olimpiadi di Mosca vengono boicottate dagli USA per protesta contro l’invasione dell’Afghanistan.
- 22 settembre: a Danzica viene fondato il libero sindacato Solidarnosc.
- Settembre: dopo ripetuti scontri di confine, ha inizio la guerra tra Iran e Iraq.
- Novembre: il repubblicano Ronald Reagan viene eletto presidente degli Stati Uniti.
- Nello Zimbabwe (ex Rodesia) la minoranza bianca lascia il potere alla maggioranza nera.
- Accordo tra la IBM e la Microsoft di Bill Gates per prendere in licenza e installare sui computer il sistema operativo Ms-Dos.
- Esce Il nome della rosa di Umberto Eco.
- Esce L’ultimo metrò di François Truffaut con Catherine Deneuve e Gerard Depardieu.
- Esce Atlantic city di Louis Malle.
- Esce Mon oncle d’Amèrique di Alain Resnais.
- Il prodotto nazionale lordo per abitante dell’Africa è di 280 dollari (in dollari del 1960) contro i 2.670 dollari dei paesi dell’Europa occidentale e i 4.290 dollari dell’America del Nord.
- Inizia a Londra il movimento dark. Impera il colore nero e la musica che si ispira alla
- tradizione gotica.
1981
- Gennaio: vengono liberati gli ostaggi dell’ambasciata statunitense di Teheran.
- Febbraio: il generale Jaruzelski viene eletto primo segretario del Partito operaio polacco nonché primo ministro.
- 13 dicembre: Jaruzelski proclama lo stato d’assedio. Lech Walesa e altri esponenti di Solidarnosc vengono arrestati.
- Il presidente statunitense Reagan vara un nuovo indirizzo di politica estera, la “nuova guerra fredda”.
- Gli astronauti John Young e Crippen guidano la prima missione della navetta Space Shuttle Columbia (STS-1). La missione dura due giorni, sei ore e ventuno minuti.
- La IBM comincia a produrre personal computer che adottano il sistema MsDos.
- Il dottor Michael Gottlieb riferisce al Center of Disease Control di Los Angeles di cinque casi di morte di omosessuali per una rara polmonite. Si tratta dei primi casi accertati di Aids (Acquired Immuno Deficency Syndrome).
- Elias Canetti riceve il premio Nobel per la letteratura.
- Esce Cronaca di una morte annunciata di Gabriel Garcia Marquez.
- Esce nelle sale Anni di piombo di Margarethe Von Trotta, un film che affronta il complesso tema del terrorismo.
- Ece Fitzcarraldo di Werner Herzog, con Klaus Kinsky.
- Esce La signora della porta accanto di François Truffaut.
- Esce Ti ricordi di Dolly Bell, primo film del regista jugoslavo Emir Kusturica.
- Esce Mephisto di Szabo.
- 13 marzo: il turco Mehemet Alì Agca spara in piazza San Pietro al pontefice Giovanni Paolo II.
- 29 luglio: nella cattedrale di Saint Paul a Londra si celebra il matrimonio tra Carlo, principe di Galles ed erede al trono inglese, e Diana Spencer. L’evento è seguito da oltre un miliardo di persone in diretta televisiva.
- Esce nelle sale cinematografiche il primo film new wave, Polyester, di John Waters.
- In tutta l’Inghilterra vedono la luce gruppi musicali (Spandau Ballet, Duran Duran, Depeche Mode) che suonano un tipo di pop elettronico sofisticato dal ritmo ballabile, che diviene la colonna sonora della moda new-romantic.
- A Brighton, come diciassette anni prima, scoppiano incidenti tra mods e polizia.
- Complice anche un certa tendenza unisex, esplode la moda dell’abbigliamento sportivo, un settore nel quale, più che in altri, il “marchio” diviene uno status symbol.
1982
- Aprile: l’esercito argentino occupa l’arcipelago britannico delle Falkland.
- Maggio: la Gran Bretagna invia una spedizione militare nelle Falkland.
- Maggio: iniziano a Ginevra i negoziati per la riduzione e il controllo dei missili strategici (START, Strategic Arms Reduction Talks).
- Giugno: Israele invade il Libano meridionale e occupa la zona est di Beirut. Si ritirerà in settembre.
- Giugno: l’Inghilterra vince rapidamente il conflitto per il possesso delle isole Falkland, provocando la crisi della dittatura militare in Argentina.
- 22 agosto: le truppe palestinesi lasciano la capitale del Libano, Beirut, sotto la protezione di una forza multinazionale di pace.
- Ottobre: scoperto alla periferia di Buenos Aires un cimitero dove sono sepolti i corpi di migliaia di desaparecidos, oppositori politici della dittatura militare.
- 10 novembre: muore il leader sovietico Leonid Breznev.
- 12 novembre: viene eletto segretario del Partito comunista sovietico Jurij Andropov.
- 12 dicembre: Jaruzelski dichiara la fine dello stato d’emergenza in Polonia.
- Governo democratico in Bolivia presieduto da Suazo.
- William Gibson conia il termine cyberspace.
- La Sony e la Philips introducono sul mercato i CD, supporti molto più resistenti di quelli in vinile o magnetici.
- Gabriel Garcìa Marquez riceve il premio Nobel per la letteratura.
- Esce Blade runner di Ridley Scott con Harrison Ford.
- Esce Gandhi di Richard Attenborough con Ben Kingsley.
- Lo Stato delle cose di Wim Wenders riceve il Leone d’oro al festival di Venezia.
- Esce Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni.
- Esce Il bel matrimonio di Erich Rohmer.
- Esce Veronica Voss di Rainer Werner Fassbinder.
- Diritto di voto in Norvegia, alle elezioni comunali e provinciali, a tutti gli stranieri residenti da almeno tre anni nel paese.
- Crisi messicana: l’ingente fuga di capitali verso gli Stati Uniti e il grande debito estero del paese portano il Messico sull’orlo della bancarotta, con effetti potenzialmente destabilizzanti per l’economia americana e mondiale.
- Le statistiche segnalano la diffusione della marijuana negli USA presso circa venti milioni di consumatori abituali, e stimano la presenza di circa quattro milioni di eroinomani e morfinomani.
- Grace Kelly, principessa di Monaco, muore in un incidente d’auto.
- Nascono i Cure che divengono uno dei gruppi guida della moda dark.
- Grande successo riscuote “Stykes”, il nuovo inserto di moda del “New York Times”.
- Mondiali di calcio in Spagna: l’Italia conquista per la terza volta la Coppa del mondo battendo in finale la Germania Occidentale per 3 a 1.
1983
- Marzo: in Germania Federale i cristiano-democratici vincono le elezioni: Helmut Kohl diventa il nuovo cancelliere.
- Luglio: il segretario socialista Craxi è il nuovo presidente del Consiglio italiano.
- La Apple introduce sul mercato il computer Macintosh, che ottiene un vasto successo per le sue caratteristiche innovative e la sua facilità d’uso.
- Viene isolato per la prima volta il virus dell’Aids, l’Hiv.
- Iniziano le pubblicazioni annuali, a cura del World Watch Institute, dei rapporti annuali The state of the World, alla cui redazione partecipano varie organizzazioni ambientaliste.
- Toni Morrison riceve il premio Nobel per la letteratura.
- Esce Il grande freddo di Lawrence Kasdan, con Tom Berenger, Glenn Close, Jeff Goldblum, Kevin Kline, William Hurt: una riflessione sulla generazione della contestazione.
- Esce Scarface di Brian De Palma.
- Esce Zelig, di Woody Allen.
- Esce E la nave va di Federico Fellini.
- Esce L’argent di Robert Bresson.
- Esce Prènom Carmen di Jean-Luc Godard.
- Al festival del cinema di Montreal viene presentata la pellicola Liquid sky del regista russo Slava Tsukerman, che diviene un vero e proprio cult-movie per i new waver.
- Paul Weller fonda gli Style Council e assurge al ruolo indiscusso di portavoce della gioventù mod.
- Il film War games (Giochi di guerra), con Matthew Broderick, annuncia la moda degli hackers.
- A causa del “riflusso” e del revival degli anni ‘50, due colossi del jeans, Blue Bell e Levi Strauss, devono chiudere diciassette fabbriche e licenziare decine di migliaia di dipendenti negli USA.
- Primo network americano per i telefoni cellulari.
- 25 ottobre: invasione statunitense dell’isola di Grenada, dove è al potere un governo d’ispirazione marxista.
- Novembre-dicembre: viene avviata l’installazione dei Pershing 2 e dei Cruise nelle basi militari americane situate in Germania Occidentale, Gran Bretagna e Italia. Per protesta contro l’azione americana, l’URSS abbandona i negoziati Start e INF (Intermediate Nuclear Forces).
1984
- Ronald Reagan viene rieletto presidente degli Stati Uniti.
- 9 febbraio: muore Andropov.
- Marzo: l’ONU accusa l’Iraq di utilizzare armi chimiche nella guerra con l’Iran.
- Aprile: a causa della guerra Iran-Iraq, si verificano attacchi alle petroliere che transitano nel Golfo Persico.
- 1 maggio: Solidarnosc sfida il governo polacco organizzando manifestazioni senza il permesso.
- 8 maggio: l’URSS annuncia che non parteciperà ai giochi olimpici di Los Angeles.
- Luglio: le Olimpiadi di Los Angeles sono boicottate dall’URSS e da altri paesi socialisti.
- In Israele dopo le elezioni si costituisce un governo di unità nazionale guidato dal laburista Shimon Peres.
- Cina e Gran Bretagna siglano un accordo con cui quest’ultima si impegna a restituire il territorio di Hong Kong entro il 1997.
- Kenzaburo Oe (Giappone) riceve il premio Nobel per la letteratura.
- Esce L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera.
- Esce Heimat di Edgar Reitz.
- Il film Je vous salue, Marie di Jean-Luc Godard scatena polemiche per le immagini senza veli dell’attrice che interpreta una Madonna contemporanea.
- Paris, Texas di Wim Wenders vince la Palma d’oro al festival di Cannes.
- Esce La leggenda della fortezza di Suram di Paradzanov.
- Esce Una domenica in campagna di Bernard Tavernier.
- Trionfa lo stile anni ‘60, e riesplodono l’optical di quegli anni e la minigonna a oltranza.
- La squadra di calcio del Napoli sborsa oltre quindici miliardi per l’acquisto dell’asso argentino Maradona.
- Olimpiadi di Los Angeles: trionfo dell’atleta statunitense Carl Lewis che eguaglia il record di Jesse Owens (stabilito alle Olimpiadi di Berlino del 1936) vincendo quattro medaglie d’oro (salto in alto, 100m, 200m e staffetta 4x100m).
1985
- 11 marzo: Michail Gorbaciov viene eletto segretario del Partito comunista sovietico.
- 14 marzo: accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone tra i paesi dell’Unione Europea. Accordi poi più volte modificati.
- Aprile: Gorbaciov inaugura la politica della perestroika.
- 29 maggio. Bruxelles: nello stadio Heysel, prima della finale della Coppa dei campioni di calcio, trentanove spettatori rimangono uccisi in seguito agli incidenti provocati dai tifosi della squadra inglese del Liverpool.
- 13 luglio: in seguito alla mobilitazione in favore delle popolazioni etiopiche colpite dalla carestia, si svolge a Wembley in Inghilterra il Live Aid. Al concerto partecipano molte delle principali star della musica tra le quali: David Bowie, Bob Dylan, Mick Jagger, Paul McCartney, Elton John, Madonna, Tina Turner, U2.
- Pol Pot lascia (ufficialmente) la guida dei khmer rossi, che combattono contro il governo filovietnamita.
- Brasile: Sarney, dopo la breve presidenza Neves, è il primo presidente della Repubblica dopo vent’anni di dittatura militare. Anche in Uruguay si ritorna alla democrazia.
- Stato d’assedio in Sudafrica, in seguito all’intervento della polizia contro una manifestazione di protesta (trecento morti).
- Sanzioni internazionali contro il Sudafrica.
- Jaruzelski diventa capo del governo polacco.
- 19 novembre: a Ginevra si tiene il primo vertice tra Reagan e Gorbaciov; riprende il dialogo tra USA e URSS per il disarmo.
- La Sony costruisce una radio grande come una carta di credito.
- Viene perfezionata la tecnica della risonanza magnetica nucleare. Ancora più sicura per il paziente rispetto alla TAC, utilizza gli ultrasuoni che poi il computer trasforma in immagini.
- Iniziano i primi trattamenti sperimentali con l’Azt per la cura dell’Aids.
- Il filosofo italiano Gianni Vattimo scrive La fine della modernità.
- Papà è in viaggio d’affari di Emir Kusturica vince la Palma d’oro al festival di Cannes.
- Ingmar Bergman realizza Fanny e Alexander.
- Esce La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani.
- Esce La messa è finita di Nanni Moretti.
- Diritto di voto in Olanda alle elezioni comunali a tutti gli stranieri residenti da almeno cinque anni nel paese.
- La speranza di vita alla nascita è di 53 anni in Congo, di 59 anni in India a fronte dei 75 anni della Francia o dei 74 dell’Inghilterra.
- Prima edizione a Parigi degli Oscar della moda.
- Debuttano con successo gli stilisti italiani Dolce e Gabbana.
1986
- 13 aprile: Giovanni Paolo II visita la sinagoga di Roma.
- 15 aprile: aerei statunitensi bombardano Tripoli e Bengasi, in Libia, provocando settanta morti.
- giugno: l’articolo Germania: un passato che non passa di Ernst Nolte, pubblicato sul quotidiano “Frankfurter Allgemainer”, avvia il dibattito sul nazismo, i crimini di genocidio, il revisionismo storico.
- Mondiali di calcio in Messico: vittoria dell’Argentina. Esplode il talento di Diego Armando Maradona.
- 27 ottobre: ad Assisi si incontrano i capi delle religioni di tutto il mondo per una giornata comune di preghiera.
- L’URSS ritira un contingente simbolico di ottomila uomini, sugli oltre centomila inviati in Afghanistan.
- Novembre: le autorità iraniane rivelano l’acquisto di armi dagli Stati Uniti, nonostante l’embargo che questi hanno posto. Negli USA scoppia lo scandalo “Irangate”.
- La leader democratica Cory Aquino diventa presidente delle Filippine.
- Accordo di Reykjavik fra Gorbaciov e Reagan sul dimezzamento delle armi strategiche offensive.
- Il XXVII congresso del PCUS approva la linea riformista di Gorbaciov.
- Riabilitazione del dissidente sovietico Andrej Sacharov, il quale viene richiamato dal confino di Gorkij.
- La sonda statunitense Voyager 2 sorvola Urano, dopo aver sorvolato Giove (1979) e Saturno (1981).
- A seguito di un’esplosione nella centrale nucleare di Chernobyl, presso Kiev, in Ucraina, si ha una fuoriuscita di materiale radioattivo, le cui componenti volatili, trascinate dalle correnti atmosferiche in quota, raggiungono la penisola scandinava, la Polonia, l’Austria, l’Italia e la Francia.
- Esce Ginger e Fred di Federico Fellini.
- Esce Il raggio verde di Erich Rohmer.
- Esce Round Midnight di Bernard Tavernier.
- Esce La legge del desiderio di Pedro Almodovar.
- Esce Senza tetto né legge di Varda.
- “Uruguay round”: nuovi accordi tra i paesi aderenti al GATT
- Alcuni grandi marchi, come Benetton, Lovable e Cfm entrano in Borsa.
- Grazie all’apparizione del suo nome su di una maglietta indossata da Sylvester Stallone in Rocky IV, scoppia il fenomeno Hugo Boss.
1987
- Gennaio: Gorbaciov annuncia al Comitato centrale del PCUS un rinnovamento dei rapporti con i mass media (glasnost).
- Vengono introdotti in Unione Sovietica elementi di libero mercato.
- Inizio dell’Intifada, la rivolta palestinese nei territori occupati da Israele.
- Gli Stati Uniti intervengono nel Golfo Persico per proteggere le petroliere del Kuwait.
- Febbraio: i paesi più industrializzati stipulano un accordo per la stabilizzazione del dollaro (“accordo del Louvre”).
- Aprile: inizia la “guerra commerciale” tra USA e Giappone, con le sanzioni americane per il
- mancato rispetto degli accordi sul commercio dei prodotti elettronici.
- Aprile-maggio: inizia la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il Giappone.
- 7 agosto: piano di pace regionale firmato dai cinque presidenti degli Stati centroamericani.
- Ottobre: La borsa di Wall Street subisce un crollo (il “lunedi nero”).
- 8 dicembre: Stati Uniti e URSS firmano l’accordo per la progressiva eliminazione degli “euromissili”.
- Inizia il ritiro delle forze vietnamite dalla Cambogia.
- Il poeta dissidente russo Brodskij riceve il premio Nobel per la letteratura.
- Esce Full Metal Jacket il nuovo capolavoro di Stanley Kubrick.
- L’ultimo imperatore del regista italiano Bernardo Bertolucci vince tutti i principali premi Oscar.
- Esce Oci ciornie di Nikita Michalkov.
- Esce Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders.
- Esce Arrivederci ragazzi di Louis Malle.
- Il buco nella bilancia dei pagamenti statunitense raggiunge i centosessanta miliardi di dollari.
- Il surplus commerciale del Giappone raggiunge gli ottantasette miliardi di dollari.
- Gli anni ‘60 vengono “elasticizzati” grazie a un nuovo tessuto, lo stretch (una combinazione di lycra, cotone e lana), che consente di realizzare abiti capaci di aderire perfettamente al corpo.
- Il pugile americano Mike Tyson conquista il titolo mondiale dei massimi (WBA), diventando il più giovane campione della storia della boxe in questa categoria (venti anni).
1988
- 14 aprile: viene firmato a Ginevra il trattato che prevede il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan entro il 15 febbraio 1989 e il rientro dei profughi.
- Giugno: vertice tra Reagan e Gorbaciov a Mosca.
- 18 luglio: Khomeini accetta la risoluzione dell’ONU del 20 luglio 1987, ponendo fine alla guerra con l’Iraq.
- Agosto: la polizia reprime con la forza gli scioperi a Danzica, Stettino e in Alta Slesia.
- 30 settembre: esce la lettera apostolica Mulieris dignitatem, la prima dedicata alle donne.
- Novembre: il repubblicano George Bush viene eletto presidente degli Stati Uniti.
- Cile: dopo quindici anni di dittatura, il generale Pinochet, attraverso un referendum popolare, viene deposto dalla carica di presidente della Repubblica.
- Ampia offensiva militare sandinista in Nicaragua contro la guerriglia contras.
- Rain man di Barry Levinson con Dustin Hoffman e Tom Cruise, che affronta il tema dei portatori di handicap, riceve il premio Oscar.
- Esce Un affare di donne di Claude Chabrol.
- Esce La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi.
- Risulta che ben quindici nazioni hanno un debito verso l’estero superiore al prodotto interno lordo.
- Il reddito pro capite del Giappone supera quello statunitense.
- Convenzione ONU “contro il traffico illecito di narcotici e sostanze psicotrope”. Viene promosso un progetto di proibizione internazionale delle sostanze stupefacenti, che prevede l’emanazione nei vari paesi di leggi proibizioniste.
- Olimpiadi di Seoul (Sud Corea). Lo sprinter canadese Ben Johnson, vincitore della gara dei cento metri (con il nuovo record mondiale), viene trovato positivo al test anti-doping e squalificato.
- Alle Olimpiadi invernali di Calgary si mette in luce Alberto Tomba.
- Senna è campione del mondo di Formula Uno. Il successo si ripeterà nel 1990 e nel 1991.
1989
- Marzo: Eltsin viene eletto presidente della Repubblica federativa russa.
- Aprile-maggio: inizia il ritiro delle truppe sovietiche dalla Repubblica Democratica Tedesca, dalla Cecoslovacchia e dall’Ungheria.
- Primavera: manifestazioni degli studenti a Pechino nella piazza Tien’anmen.
- 3 e 4 giugno: gli studenti riuniti in piazza Tien’anmen vengono massacrati dall’esercito cinese.
- L’ayatollah Khomeini chiede “giustizia” contro lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie per il libro I versetti satanici, colpevole di “blasfemia”. Viene promessa una ricompensa di tre milioni di dollari per chi punirà lo scrittore.
- Giugno: muore Khomeini. La guida del paese viene assunta da Ali Khamenei.
- Giugno: per la prima volta in Polonia vengono indette libere elezioni: vince Solidarnosc e nasce il primo governo non comunista sotto la guida di Mazowiecki.
- 24 giugno: Jiang Zemin diventa segretario generale del Partito comunista cinese.
- Agosto: raduno neonazista a Wunsiedel, in Germania, nei pressi del cimitero dove è sepolto Rudolph Hess, morto da due anni. I neonazisti commemorano l’ex gerarca, organizzando un raduno internazionale che diventa negli anni successivi un appuntamento annuale. A organizzare la manifestazione è, in particolare, la NSDP-AO, organizzazione internazionale di estrema destra al centro di molti episodi analoghi e progetti internazionali negli anni successivi.
- 9 novembre: Viene abbattuto il muro di Berlino.
- Novembre: Havel e Dubcek guidano le manifestazioni di protesta contro il governo comunista cecoslovacco, che costringono alle dimissioni i vertici del Partito comunista.
- Novembre: Deng Xiao Ping viene sostituito alla testa della Commissione militare cinese.
- Dicembre: truppe statunitensi invadono Panama e rovesciano il regime del dittatore Noriega.
- Dicembre: Havel diventa presidente della Repubblica cecoslovacca.
- Dicembre: a Scutari, in Albania, scoppiano le prime dimostrazioni antigovernative.
- 21 dicembre: in Romania scoppiano le proteste e iniziano le manifestazioni popolari contro il governo.
- 23 dicembre: il dittatore romeno Ceausescu e sua moglie Elena, in fuga dal paese, vengono arrestati e giustiziati sul posto.
- Esplode il conflitto sociale in Corea del Sud: contestazioni studentesche e scioperi nell’industria.
- Riconoscimento da parte del governo sudafricano della principale organizzazione della maggioranza nera: l’African National Congress.
- La sonda statunitense Voyager 2 sorvola Nettuno.
- Viene effettuato il primo trapianto di geni in un essere umano.
- Ad Altamira, in Brasile, si tiene il primo incontro dei popoli indigeni dello Xingu, nel corso del quale viene denunciato il dramma di intere tribù dell’Amazzonia cancellate dalla faccia della terra assieme a ettari e ettari di foresta vergine.
- Camilo Josè Cela (Spagna) riceve il premio Nobel per la letteratura.
- Esce Decalogo di Kieslowski.
- Per la prima volta nella storia europea il saldo migratorio (differenza matematica tra immigrati e emigrati) supera il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi): la popolazione europea cresce grazie all’afflusso di immigrati dai paesi del Sud del mondo.
- Settembre: l’Ungheria apre le frontiere con l’Ovest: una massa di automobili provenienti da tutta l’Europa orientale si riversa sul confine per andare in Occidente.
- Crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale. Si apre il problema della riconversione delle economie di questi paesi.
- Rapporto Delors sull’Unione monetaria ed economica europea. Il rapporto contiene un piano, articolato in tre fasi, per l’obiettivo della moneta unica.
- Tutto il mondo è invaso dal marchio “United Colors of Benetton”, in breve il più conosciuto.
- Nasce a Seattle la moda grunge, uno stile informale che stratifica gli abiti.
Nel mondo
La fine della guerra fredda: da Gorbaciov al 1989

Porta di Brandeburgo, 10 novembre 1989
Nel corso degli anni Ottanta i regimi comunisti entrarono in una crisi sempre più profonda. Il nuovo leader sovietico Gorbaciov, giunto al potere nel 1985, attuò un imponente piano di riforme. Non riuscì però a frenare il processo di declino. Nel 1989 cadde uno dei simboli della guerra fredda: il muro di Berlino. Questo avvenimento segnò in tutti gli stati del blocco sovietico la fine dei regimi comunisti che accadde in modo differente da paese a paese. La rivoluzione cecoslovacca avvenne in maniera incruenta e fu avviata una politica riformista sotto la guida di Havel e Dubcek. In Romania, invece, la caduta del dittatore Ceausescu fu conseguente ad una sanguinosa guerra civile. Gli altri paesi, come l’Ungheria, l’Albania e la Bulgaria, vissero anch’essi in maniera varia il cambio di regime. Se l’Ungheria e la Bulgaria hanno superato meglio la crisi, l’Albania è rimasta coinvolta in una situazione di grave tensione politica fino a tutti gli anni ‘90.
La fine incruenta del comunismo scatenò conflitti terribili in alcune aree, come nel caso della guerra civile jugoslava. La Cina comunista, invece, sembra aver resistito riformando in senso liberista parte dell’economia, ma non la sfera della politica reprimendo ogni forma di dissenso, come nel caso degli studenti di piazza Tien’anmen nel 1989.
Il 1989 rappresentò un anno di svolta per l’immaginario collettivo e la fine di un’epoca. L’abbattimento del muro di Berlino assunse un valore simbolico per l’opinione pubblica mondiale, sancendo il definitivo crollo del “socialismo reale”; sembrò aprirsi una fase nuova caratterizzata dal trionfo del modello capitalista e liberale e dalla pacificazione dei conflitti internazionali.
L’uomo e la natura fra Chernobyl e gli Shuttle

La città fantasma di Pripyat. Sullo sfondo la centrale nucleare di Cernobyl
A partire dagli anni Settanta, si è sviluppata una consapevolezza crescente dei forti rischi ambientali, provocati dallo sviluppo industriale esteso su scala globale. L’impatto ambientale della combustione di materie energetiche, consumate in misura sempre maggiore, ha raggiunto livelli allarmanti. Ad esso si è affiancato un rilascio di quantità crescenti di materiali chimici dannosi e un aumento incontrollabile della popolazione. Lo sviluppo del capitalismo contemporaneo rischia di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della specie umana sulla terra, e ha già provocato catastrofi ambientali di vaste conseguenze. La necessità di programmare una crescita sostenibile non è più ormai una scelta politica, ma una determinazione imposta dagli eventi.
Le sciagure naturali e quelle causate dall’uomo hanno spesso occupato la prima pagina dei giornali e il titolo d’apertura dei notiziari televisivi: una lunga scia di nomi, ormai tristemente famosi, costella gli anni Ottanta, decennio che segna uno spartiacque per l’avvertita sensibilità dell’opinione pubblica su questi temi. Spesso le televisioni hanno fatto programmi e documentari specifici sui disastri della natura e dell’uomo: immagini spettacolari, talvolta in diretta, di incendi, terremoti, alluvioni, uragani, naufragi, esplosioni fanno ormai parte dell’immaginario collettivo. In Italia tutti ricordano le immagini delle eruzioni e delle colate laviche dell’Etna, coi tentativi dell’uomo di deviarne il corso sperimentando soluzioni inedite.
Quando, nell’aprile 1986, dopo l’incidente alla centrale atomica di Chernobyl, dal reattore fuoriuscì una nube radioattiva che si spingeva verso l’Europa centro-occidentale, l’opinione pubblica rimase sotto shock. Sull’onda di questo evento e di fronte alla sempre più drammatica distruzione della natura, prese forza in tutto il mondo il movimento ambientalista che denunciava la limitatezza e la necessità di proteggere le risorse della terra.
Allo stesso modo, l’opinione pubblica è rimasta affascinata da altre immagini televisive: quelle provenienti dal mondo scientifico che testimoniavano l’enorme sviluppo delle scoperte e delle realizzazioni dell’uomo. In particolare, hanno colpito le missioni degli Shuttle, le immagini trasmesse dallo spazio sempre più frequentemente che hanno riacceso l’eterna discussione sulla “solitudine” del genere umano. “L’incontro” con la cometa di Halley e l’astronauta che si libra senza nessuna connessione o cavi nello spazio sono stati l’apice della raggiunta capacità tecnologica; ma la conquista dello spazio ha vissuto anche una nuova tragedia con l’esplosione, poco dopo il decollo, della navetta Challenger nel 1986.
Gli USA di Reagan

Reagan e il vice presidente George H.W. Bush nel 1981
La crisi economica mondiale apertasi nel 1973, la caduta di Nixon a seguito dello scandalo Watergate, la sconfitta in Vietnam, gli insuccessi riportati negli anni della presidenza Carter (era dell’aprile 1980 quello della fallita liberazione degli ostaggi a Teheran), sembravano prefigurare il declino dell’egemonia mondiale USA. La politica interna e quella estera del nuovo presidente americano Reagan rilanciarono l’immagine di un paese aggressivo che voleva riconquistare il suo spazio sulla scena politica internazionale.
Alle elezioni del 1980 il malcontento diffuso presso la società americana provocò la sconfitta di Carter. Nuovo presidente divenne quindi il repubblicano Ronald Reagan, ex attore di Hollywood ed esponente della destra del partito, il cui programma si fondava sul richiamo all’orgoglio nazionalista, su un anticomunismo viscerale e sull’adesione alle “crociate” ideologico-morali promosse da gruppi religiosi fondamentalisti. Il tratto maggiormente caratterizzante del reaganismo fu tuttavia la sua politica economica, la “reaganomics”, ispirata alle teorie economiche neoliberiste, o “dell’offerta”: essa si contrappose al keynesismo e ai fautori del Welfare State, che puntavano al controllo della domanda, sostenendo che il ritorno alla prosperità fosse possibile solo stimolando il risparmio e gli investimenti produttivi e, di conseguenza, riducendo l’inflazione. A tale scopo furono necessarie, secondo quanto sostenuto dal programma della “reaganomics” massicce riduzioni fiscali alle imprese e ai ceti abbienti, sostanziosi tagli alle spese statali e, al fine di ridare libertà all’iniziativa individuale, l’eliminazione delle regolamentazioni imposte sul mondo degli affari (“deregulation”). La proposta fu quindi una drastica limitazione dell’intervento dello Stato, le cui funzioni avrebbero dovuto limitarsi al controllo nell’afflusso del danaro e ai compiti di natura militare. Sin dall’inizio le misure di politica economica messe in atto erano ispirate direttamente a tali principi. Corollario di quest’azione fu la durezza mostrata dal governo nei confronti del sindacato, come dimostra la conclusione, all’inizio del 1981, della vertenza dei controllori di volo: tutti gli scioperanti, dipendenti pubblici, furono licenziati e processati. Nei primi due anni della presidenza Reagan, segnati dal permanere della recessione, le iscrizioni al sindacato subirono un tracollo, i salari furono fortemente ridimensionati e la disoccupazione toccò alti livelli. Nel 1983 giunse tuttavia la ripresa, considerata dai fautori della “reaganomics” un diretto effetto dell’operato del governo.
Una politica estera di potenza

Ronald Reagan e Michail Gorbaciov al vertice per il disarmo (Ginevra, 19 novembre 1985)
Reagan impresse una svolta anche nel campo della politica estera. Dopo la crisi politica e morale provocata dall’insuccesso nel Vietnam, e dopo le incertezze e gli errori commessi da Carter, gli Stati Uniti aspirarono a un pieno recupero del ruolo di leader mondiale e ad un inasprimento dei rapporti con l’Unione Sovietica e con gli altri stati che si dimostravano ostili. La risposta di Reagan fu il ritorno a un anticomunismo radicale, dimenticato nel decennio precedente, in cui sulla contesa politico-ideologica con i paesi dell’Est si innestarono le forme di una lotta del Bene contro il Male, e i toni di una crociata religiosa (l’URSS era definita l’“impero del male”): si parlava a tale proposito di “nuova guerra fredda”. Ne risultò un notevole incremento degli stanziamenti statali per la spesa militare, necessari per mantenere un alto livello di armamenti e una continua innovazione tecnologica. In particolare, a partire dal 1983, notevole rilevanza assunse il progetto dell’Iniziativa Strategica di Difesa (SDI, Strategic Defense Initiative), un avveniristico e costosissimo scudo elettronico spaziale, in grado di neutralizzare, mediante raggi laser, qualsiasi minaccia missilistica. La riaffermazione del ruolo di superpotenza e l’ammodernamento dell’arsenale riuscirono a realizzare quello che era probabilmente il principale obiettivo di questa politica: spingere l’Unione Sovietica a una rincorsa intollerabile per la sua economia.
Unitamente al rilancio della contrapposizione frontale con la superpotenza nemica, nei primi anni di presidenza, Reagan si impegnò per rafforzare la presenza americana nei punti più caldi del globo, facendo assumere al proprio paese il ruolo di garante dell’ordine internazionale. L’invasione di Grenada (1983), l’attacco alla Libia (1986) e l’intervento, seppure non diretto, in Nicaragua, ne furono la prova. Tuttavia, durante il secondo mandato di Reagan, a partire dal 1984, si riavviò il dialogo tra USA e URSS.
Obiettivo Gheddafi

Gheddafi durante una conferenza stampa
Dal momento della sua elezione, Reagan riaccese i toni della contesa con l’URSS, cui contrapporsi senza cedimenti e incertezze. Al tempo stesso, all’insegna dell’acceso anticomunismo reaganiano, non solo i paesi del blocco orientale furono considerati nemici, ma anche molti stati mediorientali (Iran, Siria, Libia), accusati di finanziare e sostenere le organizzazioni terroristiche arabe. Alla metà degli anni Ottanta, infatti, queste ultime rilanciarono la propria azione, segnando in maniera sempre più tragica la politica internazionale. La strage all’aeroporto di Fiumicino (27 dicembre 1985), l’esplosione di una bomba a bordo di un aereo della TVA diretto da Roma ad Atene (2 aprile 1986), l’esplosione di un’altra bomba in una discoteca di Berlino Ovest, frequentata da soldati americani (5 aprile 1986): attentati, questi, che provocarono molti morti e crearono forti timori nei paesi europei. Grandi furono la paura e lo sconcerto anche tra gli americani, che si ritennero potenziali vittime, nonché i principali destinatari politici del messaggio contenuto negli attentati. La Libia ne fu ritenuta l’organizzatrice e la mandante, e venne considerata altresì la principale ispiratrice del terrorismo internazionale: Reagan ritenne necessario compiere un’azione immediata ed esemplare contro di essa.
L’11 aprile la Sesta Flotta americana partì dirigendosi verso la Libia: quattro giorni dopo, squadriglie di aerei bombardarono Tripoli e Bengasi, provocando settanta morti senza tuttavia raggiungere il principale obiettivo della missione: uccidere il leader libico Gheddafi. Il raid statunitense generò forti attriti tra il governo americano e gli alleati europei, tra i quali solo la Gran Bretagna cooperò con gli americani. Fu tuttavia l’Italia a risentire maggiormente delle tensioni createsi dopo i bombardamenti. Come reazione, la Libia, infatti, lanciò verso l’isola di Lampedusa due missili che non causarono alcun danno, ma generarono forte agitazione in tutto il paese.
Lo scandalo “Contras-Irangate”

Truppe Contras, 1987
All’inizio del novembre 1986, pochi mesi dopo l’attacco alla Libia, un grosso scandalo incrinò l’immagine degli Stati Uniti. Fonti iraniane rivelarono che il governo americano avrebbe venduto segretamente armi all’Iran (contro il quale aveva posto l’embargo), per ottenere la liberazione di alcuni ostaggi nelle mani delle forze islamiche. La notizia destò enorme scalpore poiché l’Iran, con il suo governo fondamentalista guidato dall’ayatollah Khomeini, era stato indicato dal presidente statunitense come uno dei principali sostenitori del terrorismo internazionale. Lo scandalo “Irangate” (così chiamato per evocare il Watergate) non si fermò tuttavia a questo. Ben presto si scoprì che il traffico era in realtà più complesso: gli iraniani pagavano le armi, e i soldi erano utilizzati per finanziare le operazioni in Nicaragua. In questo paese, a partire dalla rivoluzione sandinista nel 1979, gli USA erano intervenuti fornendo armi e denaro alle forze guerrigliere controrivoluzionarie, i “contras”, al fine di rovesciare il nuovo governo.
Reagan, messo immediatamente sotto inchiesta, con la sua popolarità scesa al minimo nei sondaggi d’opinione, alla fine riuscì a cavarsela dimostrando di non essere a conoscenza dei fatti a lui contestati; per la vicenda furono condannati soltanto alcuni suoi collaboratori e personaggi di secondo piano. Il presidente smentì le accuse e recuperò i consensi perduti, affermando che, in ogni caso, le illegalità sarebbero state commesse per il bene della patria.
Il secondo mandato di Reagan (1984-88) fu segnato da altri fatti di grande importanza. Nel 1985 il governo intervenne in maniera diretta sullo scenario dell’economia internazionale pilotando il dollaro verso il basso, e promuovendo la creazione del gruppo dei sette paesi più industrializzati (G7) allo scopo di garantire il controllo sul mercato mondiale. Nello stesso anno, si infittirono intanto i negoziati per il disarmo avviati con il leader sovietico Gorbaciov e, nel dicembre 1987, si giunse alla stipulazione del trattato per lo smantellamento degli “euromissili”. In politica interna la ripresa iniziata nel 1983 si consolidò, lasciando ormai definitivamente alle spalle la recessione apertasi alla fine del decennio precedente. Nel 1988 l’era reaganiana si chiuse (poiché Reagan era già stato eletto due volte) con un bilancio fatto di molti successi ma anche di grandi ombre: l’aumento della povertà e delle disuguaglianze tra la popolazione statunitense era la principale di esse. Il giudizio popolare degli elettori fu ampiamente positivo.
L’eredità della politica reaganiana

Foto segnaletica di Manuel Noriega, generale di Panama e de facto un leader militare del paese dal 1983 al 1989. Soprannominato "faccia d'ananas" (cara de piña) a causa del viso vistosamente butterato per le cicatrici lasciate dal vaiolo venne catturato nel 1990 dalla DEA e condannato per riciclaggio, traffico di droga e violazione dei diritti umani a 40 anni di carcere
Nel novembre del 1988 fu eletto presidente degli Stati Uniti George Bush, vicepresidente nei due mandati di Reagan. Vinse quindi la linea della continuità poiché le elezioni rappresentarono, più che la scelta tra due candidati, un giudizio sul reaganismo.
Nel corso dei quattro anni di mandato, Bush si distinse soprattutto per il grande rilievo dato alla politica estera. Fu, infatti, chiamato a gestire i difficili equilibri seguiti al crollo del comunismo nell’Europa dell’Est e in URSS e alla conseguente fine del bipolarismo e della guerra fredda, che avevano segnato tutta la storia del secondo dopoguerra. Il suo impegno si diresse allora verso la definizione di un nuovo ordine mondiale, in cui numerose potenze controllavano gli equilibri regionali e contribuivano a definire l’assetto internazionale, mentre all’unica superpotenza rimasta, gli USA, competeva il coordinamento del sistema degli stati e il mantenimento dell’ordine. Alla base vi sarebbe stata dunque la centralità del livello regionale nella regolazione delle tensioni, e, soprattutto, la piena riaffermazione della leadership americana in campo internazionale. La cattura del dittatore panamense Noriega, nel 1989, e, soprattutto, la guerra del Golfo nel ‘91, in cui gli statunitensi coordinarono una forza multinazionale contro l’Iraq, rappresentano le più importanti concretizzazioni di questo progetto egemonico. Un progetto che tuttavia, proprio in questo periodo, rivelò anche una profonda debolezza; nel tentare di definire una forma di regolazione dei rapporti con le altre potenze, in primo luogo con il Giappone e i paesi europei, esso analizzava infatti in termini militari una concorrenza che invece si svolgeva soprattutto sul terreno economico e dell’innovazione tecnologica.
Il re della cocaina: Pablo Escobar

Foto segnaletica di Pablo Escobar, 1977
La violenza endemica che società la colombiana stava soffrendo, con scontri tra i vari guerriglieri rivoluzionari e l’esercito e i gruppi paramilitari, aveva raggiunto il suo culmine, nel 1980, con l’aumento spettacolare dei traffici dei cartelli della droga, le organizzazioni criminali focalizzate sul traffico di droga che avevano accumulato fortune esorbitanti e che, nella sua ansia di egemonica, avevano scatenarono una guerra contro lo stato. Il capo del cartello di Medellin, Pablo Escobar, era la figura iconica di questo periodo.
Con la domanda di cocaina negli Stati Uniti sempre in aumento, Pablo formò reti con base nel sud della Florida, California e in varie altre parti degli Stati Uniti Lui con il suo socio, Carlos Ledher, acquistando la maggior parte delle terre di Norman’s Key, nelle Bahamas. Questi lotti comprendevano una pista di atterraggio, portando circa di 70-80 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti al mese. La sua attività nel mercato della cocaina controllava la maggior parte delle droghe che entravano negli Stati Uniti, Portorico, Venezuela, Repubblica Dominicana, Messico e Spagna. Fu responsabile della morte di centinaia di persone, compresi poliziotti e funzionari statali. Si pensa che Escobar fu direttamente responsabile per l’assassinio del candidato presidenziale colombiano Luis Carlos Galán. Al culmine della sua attività, il cartello della droga ricavava oltre 60 milioni di dollari al giorno. Il suo patrimonio netto è stato stimato ammontare a circa tre miliardi di dollari nel 1989, tanto da essere citato dalla stessa rivista “Forbes” come l’uomo più ricco del mondo. Escobar aveva la reputazione di essere generoso ed era ben voluto tra la gente Medellín. Costruì chiese, ospedali, campi sportivi e scuole, attirandosi anche il benvolere della Chiesa cattolica romana. Si dette anche da fare per i poveri della città attraverso attività filantropiche. I cittadini di Medellín proteggevano spesso Escobar e lo aiutavano a nascondersi dalle autorità. Nei primi anni novanta, la guerra alla droga subì un’accelerazione mentre il cartello di Escobar combatteva per mantenere la propria supremazia. Escobar forniva ai suoi uomini ricompense in contanti per l’uccisione di poliziotti, causando oltre 600 agenti morti nei primi anni Novanta. Quando l’amministrazione di César Gaviria cominciò a mettere pressione sui cartelli della droga, il governo fu in grado di negoziare con Escobar. In cambio di una riduzione della pena e di un trattamento preferenziale nel 1991, accettò di consegnarsi. Soggiornò in una lussuosa prigione privata chiamata La Catedral. Quando il governo scoprì che aveva proseguito a seguire le sue operazioni dal carcere, tentarono di spostarlo in un altro carcere, ma ne scappò il 22 luglio 1992. Dopo una lunga ricerca da parte dei governi colombiano e statunitense, fu scoperto in un quartiere borghese di Medellín. Nel tentativo di fuggire, venne colpito dalla polizia alla gamba, al petto, e in un orecchio. Alcuni dei suoi familiari, tra cui il fratello Roberto, sono convinti che si suicidò trovandosi di fronte alla cattura. Morì il 2 dicembre 1993, a 44 anni.
Un conflitto logorante: la guerra Iran - Iraq

I resti di un carro iracheno
La rivoluzione iraniana del 1979, a cui avevano partecipato forze molto diverse, si trasformò - sotto la guida dell’ayatollah Khomeini - in una rivoluzione islamica. Isolato sul piano internazionale a causa del sequestro del personale dell’ambasciata USA a Teheran, il nuovo regime dovette affrontare la guerra con il vicino Iraq per otto anni dal 1980 al 1988.
Il leader della “rivoluzione islamica” all’inizio si schierò con l’ala più estremista dell’integralismo islamico mentre negli anni successivi mostrò atteggiamenti, almeno in parte, più moderati. Tuttavia nel 1989, poco prima di morire, proclamò la “fatwa”, una condanna a morte, contro lo scrittore anglo-iraniano Salman Rushdie, autore del libro Versetti satanici, ribadendo quindi una forte chiusura ad alcuni dei diritti fondamentali di libertà.
All’inizio degli anni Ottanta l’Iran era in gravissima difficoltà: da un lato si trovava isolato internazionalmente; dall’altro era alle prese con un’economia in profonda crisi. Nel tentativo di sfruttare questa situazione, nel settembre del 1980, l’Iraq lo attaccò al fine di strappargli alcuni territori da tempo contesi tra i due paesi e particolarmente ricchi di petrolio. Nel condurre l’attacco il dittatore iracheno Saddam Hussein godette dell’appoggio di gran parte del mondo arabo e delle potenze occidentali, che speravano con ciò in una rapida fine della Repubblica islamica.
La guerra assunse ben presto un andamento non previsto. L’Iran riuscì, nel giro di poco tempo, a imporre all’interno un ulteriore irrigidimento autoritario e la militarizzazione dell’intera società, reprimendo sanguinosamente ogni opposizione e organizzando la vita di tutto il paese in funzione della vittoria del conflitto. Quella che doveva essere una guerra breve e con un limitato numero di vittime, si trasformò nel suo contrario a causa anche dell’ampio ricorso a strumenti bellici rifiutati da quasi tutti gli altri paesi e proibiti dagli accordi internazionali. In particolare, l’Iraq fece ampio uso di gas, non solo contro l’Iran ma anche contro le popolazioni curde situate nella parte nord dello stato, da decenni in lotta per raggiungere la propria indipendenza.
Il conflitto terminò dopo ben un milione di morti, nel luglio 1988, quando, al termine di lunghe e difficili trattative, i due paesi firmarono l’armistizio proposto dall’ONU che sanciva il ritorno allo status quo precedente alla guerra. Cominciata il conflitto con una bilancia commerciale in attivo di 30 miliardi di dollari, l’Iraq si ritrovò con un passivo di oltre 100 e con l’impossibilità di pagare gli interessi sul debito: sarà questa una delle cause alla base della successiva guerra nel 1990-1991 col Kuwait.
Distensione e crisi internazionale: la pace dei missili

La sede del vertice tenusi presso l'ex ambasciata francese in Islanda
All’inizio degli anni Ottanta il drammatico deterioramento dei rapporti tra le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica, sembrava prefigurare una nuova “guerra fredda”. L’occupazione dell’Afghanistan da parte dell’URSS nel 1979, cui si oppose ben presto un vasto movimento di resistenza da parte degli afgani, diede il via ad un’escalation di tensioni. Poco dopo, inoltre, venne avviato il dispiegamento di missili a testata nucleare in Europa: prima da parte dell’URSS e poi da parte degli USA. La tensione toccò livelli mai raggiunti dal tempo della crisi dei missili a Cuba.
Nella seconda metà degli anni ‘70, l’Unione Sovietica aveva avviato l’ammodernamento dei propri armamenti, in linea con le più recenti innovazioni tecnologiche. Già dal 1976 era iniziata la sostituzione dei missili puntati sull’Europa, adottando i moderni Ss-20, più precisi e dotati di testate nucleari multiple, al posto degli Ss-4 e Ss-5. Ben presto tuttavia divenne evidente che l’operazione avviata dai sovietici non era una semplice sostituzione; i vecchi missili vennero, infatti, smantellati molto lentamente. Quello che si stava realizzando era in realtà una crescita notevole, per dimensioni ed efficacia distruttiva, del dispositivo atomico dislocato in URSS e negli stati aderenti al Patto di Varsavia puntato verso i paesi dell’Europa occidentale. Questi ultimi, di conseguenza, si trovarono seriamente minacciati dai nuovi missili, in grado di raggiungere i loro territori.
Trattative per la riduzione dei missili erano già cominciate alla fine degli anni Settanta, con la ratifica dell’accordo Salt I, ma, subito dopo, il presidente Carter sospese la procedura, rispondendo in questo modo all’invasione sovietica dell’Afghanistan. I negoziati per la limitazione degli armamenti subirono una brusca battuta d’arresto: a partire dal 1979, in seguito alla mancata conclusione dei negoziati Salt II con gli USA, l’installazione degli Ss-20 divenne più consistente. In risposta la NATO deliberò l’installazione di missili nucleari a medio raggio statunitensi in Europa (i cosiddetti “euromissili”). In continuità con questi ultimi sviluppi, a partire dall’inizio del 1981 il presidente statunitense Reagan varò un nuovo indirizzo di politica estera, definito dai politologi la “nuova guerra fredda”. Nel 1983 fu avviata l’installazione di 108 Pershing 2 e di 464 Cruise nelle basi militari americane situate in Germania Occidentale, Gran Bretagna e Italia. Questa decisione scatenò forti proteste da parte dei movimenti pacifisti europei che, soprattutto negli anni 1981 - 1984, dettero vita ad imponenti mobilitazioni, le quali non impedirono tuttavia il dispiegamento dei missili. L’Europa si trovava al centro di una rinnovata escalation sul piano della corsa agli armamenti, e questo fatto destava timore anche in parti non politicizzate delle popolazioni dei diversi paesi.
La crisi degli “euromissili” provocò la dura reazione dei sovietici, che abbandonarono i negoziati Start per la riduzione degli arsenali strategici, aperti l’anno precedente a Ginevra. Per due anni i rapporti tra le due superpotenze si svolsero all’insegna di una rinnovata tensione e della sospensione delle trattative per la limitazione o la riduzione degli armamenti. Nella prima metà del decennio i negoziati lasciarono quindi il posto a una recrudescenza ideologica contro l’“impero del male” sovietico, all’aumento delle spese militari e al lancio del progetto dello “scudo spaziale”, con l’intento di costringere l’URSS a un’impossibile rincorsa che ne acuisse le difficoltà economiche e le tensioni interne.
Nel 1985, grazie anche al nuovo indirizzo impresso alla politica sovietica dal segretario del PCUS Michail Gorbaciov, riprese il dialogo. Vennero rilanciati i negoziati per lo smantellamento dei Pershing, dei Cruise e degli Ss-20, e per l’effettiva distruzione di tutti i missili a corto raggio installati in Europa. Questi negoziati portarono, l’8 dicembre 1987, a siglare a Washington l’accordo INF (Intermediate Nuclear Forces). Contemporaneamente, Gorbaciov e il presidente statunitense Reagan riavviarono i negoziati Start (Strategic Arms Reductions Talks) per la riduzione degli arsenali strategici. Dopo il vertice di Reykjavik (1986), si giunse all’accordo Start I (integrato due anni dopo dallo Start II), firmato nel giugno 1991 dal leader sovietico e dal nuovo presidente americano George Bush. In un contesto internazionale attentissimo ed entusiasta, dopo il felice esito delle trattative, appariva veramente concreta e solida la prospettiva di pace che si andava delineando. La fine dell’Unione Sovietica, pochi mesi dopo, avrebbe cambiato, tuttavia, in maniera radicale la situazione, ponendo definitivamente termine al bipolarismo e alla guerra fredda.
Il Vietnam russo: l’Afghanistan

Un gruppo di mujaheddin nella Provincia di Kunar nel 1987
Nel 1978 in Afghanistan un colpo di stato aveva portato al governo il Partito comunista e l’URSS considerava un suo diritto e dovere intervenire a sostegno di quel governo che ben presto si trasformò in un regime militare a lei favorevole. Ma il governo afgano si era scontrato sin dall’inizio con la resistenza dei guerriglieri, i mujaheddin, dell’Alleanza islamica per la liberazione dell’Afghanistan che conseguirono una serie di successi, grazie all’appoggio degli Stati islamici della regione. I sovietici decisero di intervenire direttamente nel dicembre 1979.
Il presidente Carter promosse un embargo nei confronti dell’URSS, ma i paesi occidentali, tranne la Gran Bretagna, pur denunciando l’invasione, si rifiutarono di appoggiare le contromisure dell’amministrazione americana. Dopo due anni di guerra, nel 1982 si aprirono a Ginevra le trattative indirette per giungere ad un accordo di pace, trattative che si rivelarono fin dall’inizio irte di difficoltà e che si protrassero per molti anni.
L’URSS sottovalutò lo spirito e la combattività della popolazione afgana, divisa oltretutto da contrasti etnici, e l’occupazione sovietica si protrasse per anni senza giungere mai ad una vera vittoria, in una situazione per certi versi simile a quella in cui si erano venuti a trovare gli USA in Vietnam. Il 14 aprile 1988 l’URSS firmò un trattato con cui si impegnava al ritiro delle truppe entro il 15 febbraio 1989 e ad approntare misure per il rientro in patria dei quasi cinque milioni di profughi.
Ritiratesi le truppe di Mosca, non si arrestò tuttavia la guerra civile: essa continua tuttora, sebbene la fazione dei Talebani (gli studenti islamici), appoggiati dal Pakistan, abbia conquistato nel corso del 1997-98 più di tre quarti del paese instaurando un regime oscurantista che si richiama direttamente alle tradizionali leggi islamiche.
Il vento dei cambiamenti in URSS: la “perestrojka” e la “glasnost”

Michail Gorbačëv, Segretario generale del PCUS dal marzo 1985
Dopo la morte di Kruscev si era assistito in URSS alla caduta delle speranze di riforma del regime. Si aprì una fase della cosiddetta stagnazione brezneviana: un periodo di conservatorismo politico e di stasi economica. La morte di Breznev, nel 1982, significò per l’Unione Sovietica la fine di uno dei periodi più bui della sua storia. Il posto di segretario generale fu assunto da Jurij Andropov, già ambasciatore a Budapest nel 1956 durante la rivolta e capo del KGB. Si trattava dunque di un personaggio fortemente compromesso con alcuni degli episodi più oscuri della storia dell’Unione Sovietica, ma che aprì con molta cautela la strada verso le riforme economiche e politiche.
Andropov restò al potere solamente due anni: morì infatti nel 1984 e venne sostituito da Konstantin Cernenko, stretto collaboratore di Breznev ed esponente dell’ala conservatrice del PCUS. Sotto la sua direzione si assistette ad una nuova chiusura sia in politica interna sia in politica estera. In particolare i rapporti con gli Stati Uniti subirono un netto peggioramento. Anche Cernenko rimase tuttavia al potere per un periodo di tempo molto breve e alla sua morte, nel 1985, venne eletto segretario generale del partito Michail Gorbaciov, l’uomo che avrebbe dato una svolta significativa alla storia dell’Unione Sovietica e di tutti i paesi del Patto di Varsavia. Gorbaciov, pur provenendo dai quadri del Partito comunista, era ben conscio che la crisi economica e politica in cui si dibatteva l’URSS non poteva essere superata senza un radicale rinnovamento e una prudente ma decisa democratizzazione della vita politica. Gorbaciov fece delle parole glasnost (trasparenza) e perestrojka (rifondazione) la chiave del suo progetto politico. Per quanto riguarda la glasnost i suoi atti erano rivolti in particolar modo a rendere più trasparenti le nomine all’interno del gruppo dirigente del PCUS e a combattere la corruzione che affliggeva ormai da tempo il sistema sovietico. Varò poi tutta una serie di iniziative volte a dar voce alle istanze dei cittadini tramite un progressivo allentamento della censura sull’editoria e la stampa e tramite il riconoscimento di realtà associative indipendenti dal Partito comunista. Inoltre cominciò la liberazione dei numerosi dissidenti al confino. Nel 1986 richiamò Andrej Sacharov dall’esilio di Gorkij. Questa politica di liberalizzazione provocò un forte risveglio della società civile che potette finalmente esprimere le proprie opinioni e pubblicare libri e giornali fino allora vietati. Gorbaciov mise in moto anche la rifondazione dello Stato sovietico, cercando in primo luogo di separare l’apparato statale vero e proprio dal partito, due entità che ormai dagli anni ‘30 erano assolutamente indivisibili. Nel 1989 venne formato un nuovo organo istituzionale, il Congresso dei deputati del popolo dell’URSS, e venne intrapresa una revisione legislativa al fine di creare uno stato di diritto. Dal punto di vista economico l’obiettivo di Gorbaciov era quello di incrementare l’industria dei beni di consumo a scapito dell’industria pesante, e soprattutto di quella militare. Pur introducendo, dopo il 1987, elementi di libero mercato all’interno del sistema economico sovietico, non si ebbero effettivi progressi e si creò una situazione di forte malcontento all’interno del paese.
Per quanto riguarda la politica estera Gorbaciov e Reagan dettero inizio ad una serie di trattative che portano alla significativa riduzione dell’arsenale nucleare dei due paesi. Il primo atto di Gorbaciov fu quello di sostituire il ministro degli esteri Gromiko con il georgiano Eduard Shevarnadze, suo alleato nell’opera di smantellamento del vecchio equilibrio su cui si reggeva lo Stato sovietico. Su un altro fronte, nel 1989, Gorbaciov approvò il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan, contribuendo anche con quest’azione a rendere più credibile la politica di rinnovamento dell’URSS.
L’uomo del cambiamento: Gorbaciov

Incontro tra Reagan e Gorbaciov
Tentare un giudizio storico sul ruolo di Gorbaciov è cosa più complessa di quanto possa apparire in un primo momento. E’ indubbio che senza la sua forte volontà di rinnovare lo Stato sovietico, il processo di cambiamento sarebbe stato molto più lungo e tormentato. Va però tenuto presente che il periodo brezneviano (detto anche della “stagnazione”) portava verso una resa dei conti che non si sarebbe potuta procrastinare tanto a lungo.
L’economia sovietica era ormai sull’orlo del collasso e la corruzione degli apparati statali, unita al totale parassitismo degli stessi, non permetteva una soluzione della crisi nell’ambito dei canali istituzionali, senza l’intervento di una figura che avesse l’autorità per assumersi le responsabilità di rivoluzionare tutto il sistema. Senza dubbio Gorbaciov ha avuto il merito di rendersi conto della situazione tragica in cui versava il paese, prima che vi fosse il tracollo definitivo. Al tempo stesso Gorbaciov è stato un uomo di partito e un uomo che credeva fermamente nei valori del comunismo e della loro realizzazione. Il suo tentativo è stato, infatti, quello di riformare un sistema, di aprire determinati canali di democrazia, ma di continuare a credere fermamente che tale sistema, per quanto corrotto e in crisi, fosse in ogni modo riformabile.
Gorbaciov, d’altronde, si è reso conto troppo tardi che il processo da lui stesso innescato non poteva essere interrotto a metà: una cauta apertura al libero mercato così come l’autorizzazione ad esprimere le proprie opinioni non avrebbero fatto che accelerare una totale rivoluzione del sistema. Quest’ultimo, infatti, non riceveva più alcun consenso da parte dei cittadini non solo sul piano politico e sociale, ma anche, soprattutto in quest’ultima fase, su quello economico. Gorbaciov nel 1990, pur comprendendo la possibilità di un precipitare degli eventi, evitò di farsi promotore di un’accelerazione del processo di democratizzazione, al contrario, tentò di dargli una battuta d’arresto, pressato anche da quegli apparati del partito che non vedevano di buon occhio il rinnovamento e la loro conseguente perdita di potere. Da questa congiuntura politica nacque il tentativo di colpo di stato del 1991.
Un altro elemento sottovalutato da Gorbaciov è stato il problema delle nazionalità. La dissoluzione dello stato e la sua debolezza portarono le numerose etnie presenti sul suolo sovietico a rivendicare maggiori ambiti di autonomia, quando non d’indipendenza. Gorbaciov era convinto invece che l’integrità del territorio sovietico andasse mantenuta e mostrava di non accogliere simili sollecitazioni. Lo statista si è rivelato incapace di gestire il conflitto che scoppiò nel Caucaso tra armeni e azeri, e uguale difficoltà ha mostrato nei confronti delle rivendicazioni dei paesi baltici (Lettonia, Estonia e Lituania).
Le rivoluzionarie iniziative di Gorbaciov vennero accolte dai paesi occidentali con grande interesse e partecipazione. I due campi in cui con più evidenza si mostrò l’avvento del nuovo corso erano quello dei rapporti con i paesi del Patto di Varsavia e quello delle relazioni con gli USA. Per quanto riguarda il primo aspetto, sin dal suo arrivo al potere, il nuovo segretario generale del PCUS fece capire ai paesi satelliti che d’ora in avanti avrebbero dovuto andare avanti da soli e che in ogni caso non vi sarebbe stata più alcun’ingerenza dell’URSS nella politica interna, come invece era successo ai tempi della rivolta in Ungheria e della Primavera di Praga. Il motivo principale di una simile decisione risedette, senza dubbio, nelle difficoltà in cui versava l’URSS, incapace di far fronte alla crisi economica all’interno delle sue frontiere e quindi, a maggior ragione, anche all’esterno. Oltre a ciò, Gorbaciov aveva ormai ben chiaro che l’Unione Sovietica, nonostante i continui sforzi bellici, non aveva alcun modo di stare alla pari con gli Stati Uniti.
Questo netto cambio di prospettiva portò nel 1989 alla caduta del muro di Berlino e al pacifico processo di riunificazione delle due Germanie, senza che da parte dell’URSS vi fossero tentativi di ingerenza. Sulla scia della Repubblica Democratica Tedesca anche gli altri paesi del blocco sovietico diedero inizio a un processo di democratizzazione che sarà più o meno cruento nei diversi stati a seconda dell’attaccamento al potere delle classi dirigenti comuniste.
Il papa straniero: Karol Wojtyla

L'apertura della Porta santa in occasione del Giubileo del 1983
L’avvento al pontificato di Karol Wojtyla con il nome di Giovanni Paolo II nel 1978 ha segnato l’inizio di una nuova era per la Chiesa cattolica, in primo luogo, perché non era un papa italiano, in secondo luogo perché proveniva dalla Polonia. La sua elezione fece dunque presagire un rinnovato impegno della Chiesa cattolica in favore di una democratizzazione dei paesi dell’Est. Inoltre Wojtyla mostrò una notevole sensibilità per le questioni sociali e in alcune encicliche (come la Centesimus annus del 1991) ribadì la necessità di un superamento non solo del socialismo ma anche del capitalismo. Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, la Chiesa cattolica si è mostrata particolarmente recettiva anche verso i problemi del Terzo Mondo, come testimoniano i numerosi viaggi compiuti dal papa in quei paesi.
Se, dunque, sul terreno della politica estera la Chiesa degli ultimi vent’anni si è mostrata molto aperta, sul piano più strettamente religioso, questa stessa Chiesa ha mostrato un volto fortemente integralista. Su temi quali l’aborto, gli anticoncezionali, l’omosessualità, sono state espresse posizioni di chiara condanna ed è stato ribadito il ruolo centrale della Chiesa nella direzione morale della popolazione cattolica e non. Questo integralismo è in parte comprensibile se si pensa agli sforzi che la Chiesa cattolica ha dovuto affrontare per affermare la sua identità in un mondo sempre più secolarizzato.
Molti passi avanti sono stati fatti sul terreno dell’ecumenismo religioso. Rispetto alle altre Chiese cristiane, particolare attenzione è stata rivolta ai rapporti con la Chiesa ortodossa russa, anche in vista della soluzione del problema della Chiesa unite. Grandi progressi sono stati compiuti pure nel dialogo con le altre due grandi religioni monoteiste: l’islamismo e l’ebraismo. Per quanto riguarda il primo, il riacutizzarsi del fondamentalismo negli ultimi anni (con le stragi compiute contro persone di religione cristiana in paesi come l’Algeria) ha reso più difficoltose le relazioni reciproche. Per quanto concerne l’ebraismo, dopo una fase nettamente filopalestinese, il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte della Santa Sede ha segnato il rinnovato impegno della Chiesa cattolica per la pace nella regione mediorientale.
Il crollo del muro di Berlino

Abbattimento di un settore del muro, in prossimità della porta di Brandeburgo
Grandi cambiamenti segnarono la storia della Germania dell’Est nel corso degli anni Ottanta. La vera svolta nella politica della Repubblica Democratica fu costituita dall’arrivo ai vertici del governo sovietico di un personaggio come Michail Gorbaciov. Quest’ultimo, infatti, oltre a favorire le riforme nel suo paese, si mostrò chiaramente favorevole alla liberalizzazione dei regimi uniti nel Patto di Varsavia.
A partire dall’estate del 1989 la fuga dalla Germania Est coinvolse migliaia e migliaia di cittadini, che scappavano attraverso l’Ungheria, facilitati dalla decisione del governo ungherese di rimuovere i controlli di polizia e le barriere di filo spinato ai confini con l’Austria. All’interno del paese si susseguirono inoltre ingenti manifestazioni di protesta contro il regime, che costrinsero alle dimissioni l’anziano segretario del Partito comunista Eric Honecker. A quest’atto si aggiunse la concessione da parte delle autorità governative dei visti d’uscita e dei permessi d’espatrio, unitamente all’avvio di una serie di riforme. Il processo che si era innescato non poteva essere arrestato, e il 9 novembre, sotto la pressione della folla che premeva alle uscite del muro, furono aperti i passaggi verso la parte Ovest di Berlino, nonché i confini alle frontiere del paese. Il 9 novembre segnò dunque la data simbolica del definitivo crollo del blocco sovietico: dopo la Repubblica Democratica Tedesca tutti gli altri paesi retti da regimi comunisti avviarono, infatti, processi di trasformazione politica e di democratizzazione.
Per quanto riguarda le due Germanie, il crollo del muro di Berlino segnò soltanto l’inizio di un processo irreversibile: quello della fine della Repubblica Democratica. Non era sufficiente la fine del partito unico, né lo scioglimento della Sed (Partito socialista unificato tedesco), che fino ad allora aveva detenuto il potere. La popolazione, spinta anche dalla difficile situazione economica in cui versava il paese, volle l’unificazione con la Repubblica Federale e ad essa si arrivò velocemente: il sistema monetario comune fu varato il 18 maggio 1990, e il 30 ottobre dello stesso anno si arrivò alla riunificazione politica ufficiale.
La fine del comunismo europeo

Vaclav Havel, l'ultimo presidente della Cecoslovacchia ed il primo presidente della Repubblica Ceca
Con la caduta del muro di Berlino, tutti gli altri paesi del blocco sovietico hanno visto aprirsi la possibilità di una democratizzazione e della realizzazione di una vera sovranità nazionale, venuta meno dopo la seconda guerra mondiale.
La Cecoslovacchia fu la prima a reagire. Una serie di manifestazioni popolari rivendicarono le libertà classiche delle società democratiche e, in particolare, si chiesero la libertà di associazione e la libertà di stampa. Uno dei leader di quest’ondata di protesta è stato, ancora una volta, Aleksander Dubcek, l’eroe della Primavera di Praga, nel 1968. La caduta del regime comunista avvenne in Cecoslovacchia in maniera particolarmente indolore, così da assumere il nome di “rivoluzione di velluto”. Già nel dicembre dello stesso 1989 fu eletto presidente della nuova Repubblica federale il noto drammaturgo Vaclav Havel, esponente di spicco fra i dissidenti cecoslovacchi e fondatore nel 1977 del movimento per i diritti civili “Charta 77”, cosa che gli era costata un periodo di reclusione nelle carceri cecoslovacche. Nel 1990, alle elezioni politiche, fu proprio la formazione del presidente Havel, denominata Forum civico, a risultare vincente. Si trattava di una formazione di centro-sinistra in cui militava anche Dubcek, il quale, in questa occasione, fu eletto presidente del Parlamento. Il passaggio dal regime comunista alla democrazia venne dunque avviato in maniera moderata e non violenta, ma due anni dopo, nel 1992, le elezioni sancirono una netta spaccatura fra i partiti all’interno del Parlamento: quello boemo-moravo e quello slovacco. Come si può facilmente intuire, i motivi nazionalistici spinsero verso questa divisione irreversibile, che si concluse il 1° gennaio 1993 quando la Repubblica federale si sciolse e vennero create al suo posto la Repubblica ceca e quella slovacca.
In Ungheria e Bulgaria la transizione verso la democrazia fu rapida e senza spargimenti di sangue. Ben più complesse e sanguinose furono la fine dei regimi comunisti di Polonia e, soprattutto, Romania.
La Polonia di Solidarnosc

Lech Walesa, presidente della Polonia dal 1990 al 1995 e Premio Nobel della pace nella 1983
La Polonia viveva a metà degli anni ‘70 una difficile situazione di ristagno economico. In conseguenza al rialzo dei prezzi dei generi di prima necessità (1976), ci fu un’ondata di scioperi che portò alla saldatura fra l’opposizione degli operai e quella degli intellettuali e della Chiesa cattolica. L’elezione dell’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, a pontefice accrebbe il prestigio e l’autorità della Chiesa polacca. Nel 1980, a causa di un nuovo aumento dei prezzi, si assistette ad un’imponente mobilitazione: leader degli scioperanti divenne l’operaio Lech Walesa. In agosto l’opposizione ottenne un’importante vittoria: furono accordati la formazione di un sindacato indipendente, il diritto di sciopero, miglioramenti nelle condizioni lavorative. In settembre le organizzazioni sindacali non comuniste si riunirono nel movimento di Solidarnosc (in polacco “solidarietà”), fondato a Danzica il 22 settembre del 1980. Il primo ministro Gierek si dimise, sostituito dal generale Jaruzelski. La mobilitazione operaia e studentesca fu elevatissima: Solidarnosc raggiunse 10 milioni di iscritti. Walesa era un fervente cattolico, legato alla curia polacca ed anche per questo motivo Solidarnosc ha avuto ed ha un’identità di chiaro orientamento cattolico.
Nel 1981, dopo che era stata indetta una giornata nazionale di protesta, il 13 dicembre Jaruzelski proclamò la legge marziale, istituì un governo di salvezza nazionale, arrestò i capi del sindacato e lo stesso Walesa, dichiarando di agire per evitare un intervento sovietico. Ne seguì una reazione di netta condanna da parte dell’Occidente. La legge marziale rimase in vigore fino all’84 e l’opposizione, ormai clandestina, trovò un forte appoggio nella Chiesa. Jaruzelski nel 1985 fu eletto capo del governo, carica ricoperta fino al 1990. Dopo il 1986, il generale avviò una cauta politica di liberalizzazione che portò al riconoscimento (cosa unica in tutti i paesi sovietici) del diritto di sciopero dei lavoratori e di una loro rappresentanza autonoma. Il processo di democratizzazione ricevette una decisa svolta nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti nell’Europa dell’Est; vennero indette libere elezioni e Solidarnosc risultò essere la forza politica dominante. In seguito a tale vittoria venne formato il primo governo non comunista sotto la guida di T. Mazowiecki. Si avviò così un netto cambiamento politico che ha portato l’anno seguente all’elezione di Walesa alla presidenza della Repubblica. Il generale Jaruzelski ha accettato la sconfitta elettorale e ha deciso in seguito di ritirarsi a vita privata.
Con l’elezione di Lech Walesa a presidente della Repubblica, nel 1990, si può considerare concluso il processo quasi decennale di cammino verso la democrazia della Polonia.
La caduta del regno di Ceausescu

Nicolae Ceausescu con i leader del Patto di Varsavia, 1987 (da sinistra): Husák della Cecoslovacchia, Živkov della Bulgaria, Honecker della Germania Est, Gorbačëv dell'URSS, Ceausescu, Jaruzelski della Polonia e Kádár dell'Ungheria
In Romania la dittatura di Nicolae Ceausescu aveva assunto uno spiccato carattere clientelare e familiare, dando luogo a vistosi fenomeni di corruzione. Il regime si caratterizzava per l’uso sistematico della repressione e per le continue violazioni dei diritti umani. Il paese viveva, negli anni ‘80, una situazione di forte isolamento internazionale, anche rispetto agli altri paesi dell’Est europeo. L’economia era sull’orlo del collasso e il livello di vita della popolazione bassissimo; si erano inoltre inasprite le tensioni etniche con la minoranza ungherese. Il 15 dicembre 1989 esplosero delle agitazioni in Transilvania che, nonostante la violenta repressione, si estesero fino a coinvolgere la capitale. Di fronte all’insubordinazione di alcuni settori dell’esercito e alla formazione di un Comitato di salvezza nazionale che dichiarò decaduto il governo, Ceausescu e la moglie fuggirono; nel paese si svolgeva intanto una violenta contrapposizione fra gli insorti e le forze rimaste fedeli al regime. Il dittatore e sua moglie, catturati il 25 dicembre, furono sottoposti ad un processo sommario e condannati a morte. La guida del paese fu assunta da un Fronte di salvezza nazionale, guidato da Ion Iliescu, proveniente dalle file del partito comunista. I fatti di Bucarest ebbero un’immediata risonanza internazionale. Si trattò di uno dei primi casi in cui la televisione non solo amplificò e riprodusse le informazioni in tutto il mondo, ma svolse un resoconto dall’interno, in “tempo reale”, degli avvenimenti, dando luogo ad una “spettacolarizzazione” della politica. Lo stesso processo ed esecuzione di Ceausescu furono riprodotti in presa diretta, impressionando notevolmente l’opinione pubblica.
La Germania di Kohl

Il Cancelliere Kohl al Consiglio europeo nel 1987, incontro con il vice cancelliere e ministro degli esteri Hans-Dietrich Genscher
Nel 1982 la Repubblica Federale Tedesca (RFT) vide il cambio di governo fra i socialdemocratici e i cristiano-democratici a causa dello spostamento dei liberali che decisero di cambiare il partner dell’alleanza; fu nettamente ridimensionato il ruolo dei socialdemocratici, che fino ad allora, sotto la leadership di Willy Brandt prima, di Helmut Schmidt poi (in alcuni periodi con l’appoggio dei liberali), avevano avuto la guida del governo. Le successive elezioni del decennio, infatti, furono vinte dal partito cristiano-democratico, guidato dal 1976 da Helmut Kohl.
I cristiano-democratici si sono impegnati nella direzione del governo conducendo una politica per certi versi parallela, anche se meno draconiana, a quella che nello stesso periodo portava avanti Margaret Thatcher alla guida dei conservatori inglesi. Si trattava di una politica economica di chiara impronta liberista ma in condizioni differenti rispetto all’Inghilterra, segnata da una crisi economica non indifferente. Al contrario, l’economia tedesca veleggiava con il vento in poppa grazie alla tradizionale concertazione tra sindacati e imprenditori, fattore decisivo per la ripresa economica sin dal dopo guerra; infine, il marco tedesco era diventato una delle monete più forti sul mercato mondiale. La Germania, insieme al Giappone, infatti, contendeva il primato economico mondiale agli Stati Uniti.
Ciò che ha portato alla sconfitta del Partito socialdemocratico non è stato uno scontento dovuto alla condizione socioeconomica del paese, quanto piuttosto la riluttanza del partito stesso all’installazione degli “euromissili” sul suolo tedesco, che invece veniva approvata e sostenuta dagli alleati liberali e dai cristiano-democratici. Questo fatto ha scatenato molte proteste da parte di un forte movimento pacifista e ecologista. Divenuto cancelliere, Kohl si mostrò più disponibile verso la politica europeista; anzi, assieme al presidente francese François Mitterrand, spinse con più convinzione di altri verso l’unificazione europea. Kohl, al tempo stesso, continuò, anche se con maggiore cautela, le relazioni con la Repubblica Democratica Tedesca (RDT); questo non gli impedì di afferrare l’occasione venutasi a creare nel 1989 e ad affrettare la riunificazione scontrandosi con le critiche di molti concittadini.
L’ultimo “monarca” francese: François Mitterrand

Mitterrand e Helmut Kohl nel 1987
Dalla presidenza di Giscard d’Estaing a quella di Chirac, la vita politica francese ha conosciuto notevoli rivolgimenti. Al centro di questa storia, emerse la figura del socialista Mitterrand, presidente della Repubblica per quattordici anni dal 1981 al 1995.
L’alleanza fra la destra gollista e quella liberal-repubblicana, non riuscì ad avere il sostegno del paese e l’Unione delle sinistre (socialisti e comunisti) vinse le elezioni del 1981 con un programma che prevedeva progetti di nazionalizzazione, riforme sociali e aumenti salariali. I timori iniziali per la presenza dei comunisti furono presto dissipati. Tuttavia, di fronte alla crisi dell’economia mondiale, che ancora si faceva sentire all’inizio degli anni ‘80, i governi nominati da Mitterrand furono costretti a rivedere il programma elettorale e ad adottare misure economiche di stampo liberista piuttosto che socialiste.
Un fattore destabilizzante della storia politica francese è stato sicuramente il Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, un partito xenofobo e razzista, affermatosi nel corso degli anni Ottanta. Il Fronte nazionale era stato fondato a Nizza nel 1972 e sin dai primi passi, si era differenziato rispetto alla destra democratica francese mostrando marcati tratti nazionalisti e xenofobi suscitati dalla notevole presenza di emigrati dai vari stati africani, una volta colonie francesi. Alla fine del decennio il Fronte Nazionale riscosse un forte successo nella banlieu parigina e in alcune città del Midi; fu tuttavia isolato sulla scena politica dagli altri partiti.
Nel 1988 Mitterrand si vide così riconfermato il mandato con il 54% dei voti, sconfiggendo il leader della destra Chirac. Tuttavia lo stesso Chirac era diventato, dal 1986, capo del governo, in seguito alla vittoria della destra nelle elezioni per l’Assemblea nazionale; questo particolare fenomeno determinò un regime di “coabitazione”, ovvero in presenza di un presidente della Repubblica di uno schieramento coesisteva un governo espressione dello schieramento avverso. Tuttavia le istituzioni della V Repubblica dettero prova di sapersi adattare e la vita politica francese continuò senza particolari sconvolgimenti.
Dalla CEE all’Unione Europea

L'emiciclo di Bruxelles
La Comunità Economica Europea è diventata, negli ultimi anni, una realtà sempre più importante. Nel giro di pochi anni dall’Europa dei 9 si passò all’Europa dei 15. Quella che oggi si chiama l’Unione Europea ha dovuto darsi una struttura rispondente a nuovi e più impegnativi compiti. Gli organismi della Comunità, interagenti con i singoli governi nazionali, devono guidare l’Unione verso la moneta unica prevista dal trattato di Maastricht.
Nel corso degli anni Ottanta il rinnovato impegno della Francia del presidente Mitterrand e della Germania guidata da Kohl fa sì che siano proprio questi paesi a trainare, pur non senza incertezze, gli altri verso l’obiettivo dell’unione europea e a farsi promotori dell’ampliamento del numero dei paesi membri. Nel 1981 entrò così a far parte della CEE la Grecia, e nel 1986 Spagna e Portogallo. Nel corso del 1994 si aggiungeranno anche Austria, Finlandia e Svezia mentre ancora una volta la Norvegia fu fermata dal risultato negativo di un referendum.
Molto significativi furono i progressi compiuti in campo monetario, sollecitati dalle vicende dell’economia internazionale. L’instabilità dei cambi tra le valute determinata da questa situazione, infatti, minacciò di rendere più incerte le relazioni commerciali tra i paesi membri della Comunità, e tra questi e il resto del mondo. Dopo il varo del “Sistema Monetario Europeo” (SME) nel ‘79, e la definizione di un’unità di conto europea, l’ECU (embrione di una futura moneta unica), un passo in avanti verso l’integrazione fu compiuto nel 1985, quando, dopo tre anni di proposte e discussioni, il Consiglio europeo di Lussemburgo approvò l’Atto Unico. Esso prevedeva la creazione, a partire dall’inizio del 1993, di un mercato unico, con la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Con ciò si creava il mercato più grande del mondo, composto da oltre 320 milioni di consumatori.
L’Europa socialista

Felipe Gonzalez (a destra), appena arrivato all'aereoporto Ypenburg per incontrare Ruud Lubbers, primo ministro olandese
In alcuni paesi europei iniziò, durante gli anni Ottanta, l’era dei partiti socialisti. La Spagna del dopo Franco, ad esempio, vide l’affermazione del Partito socialista di Felipe Gonzalez, che divenne la principale forza di opposizione. Nel 1981 un tentativo di golpe militare portò all’occupazione momentanea del Parlamento da parte di elementi dell’esercito ma il tutto fallì subito anche grazie all’energico richiamo di re Juan Carlos alle gerarchie militari. Le elezioni del 1982 videro l’affermazione dei socialisti e Gonzalez ottenne la carica di primo ministro. Questo cambio di rotta accelerò la modernizzazione del paese, nonostante il persistere di precarie condizioni economiche, visto l’altissimo tasso di disoccupazione del paese, con una percentuale di oltre il 20%.
Gli anni Ottanta videro, oltre al successo in Francia con Mitterrand, e in Italia con Craxi, l’affermazione dei socialisti anche Svezia, Norvegia, Portogallo, con Mario Soares alla presidenza, e in Grecia con Andreas Papandreu che ottenne nel 1981 la presidenza del governo. In Svezia il primo ministro socialista Olof Palme, uno dei leader di maggior prestigio dell’Internazionale Socialista, ritornato al governo dopo sei anni di governi conservatori, fu ucciso in una strada di Stoccolma in circostanze misteriose.
L’Italia del pentapartito

Craxi e Andreotti nel periodo di collaborazione al governo presieduto da Craxi
La grave crisi economica vissuta dall’Italia (sulla scia di quanto accadeva nel resto del mondo) a partire dal 1973, si è trascinata sino ai primi anni ‘80. A partire dal 1984 si registrò tuttavia una netta ripresa: l’inflazione iniziò a scendere e la produzione si attestò su un buon ritmo di crescita, superiore agli altri paesi europei. E’ per questo che, nel 1986, l’Italia superò la Gran Bretagna diventando di conseguenza la quinta potenza industriale del mondo.
Alla base di questi successi ci fu la riorganizzazione del sistema industriale, con il superamento del “fordismo”, l’emergere di una fitta rete di piccole e medie imprese molto competitive e la caduta della conflittualità sindacale. Sono anni in cui diminuirono le mobilitazioni sociali e in larghi settori della società si affermò la cosiddetta “cultura dell’impresa”, fondata su criteri meritocratici e valori di stampo individualistico.
Alla ripresa economica si intrecciò strettamente l’operato del governo guidato da Bettino Craxi, il primo socialista diventato presidente del Consiglio nell’Italia repubblicana. Nominato nel 1983, Craxi inaugurò uno stile di governo definito “decisionista”, in quanto poco attento alle mediazioni; intraprese una decisa lotta contro l’inflazione e un costante braccio di ferro con il Partito comunista. Nel 1987 la presidenza del Consiglio tornò nelle mani della Democrazia Cristiana, sempre nell’ambito di coalizioni di pentapartito (democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali). Si susseguirono una serie di governi di breve durata, paralizzati dai dissidi sempre più aspri tra i partiti della maggioranza. In questi anni la politica manifestò una crescente incapacità a trovare soluzioni per i principali problemi del paese (ad esempio, l’aumento del debito pubblico o il risanamento della finanza pubblica); parallelamente, la corruzione e il clientelismo assunsero vaste dimensioni fino a diventare parti integranti del “sistema Italia”.
Gli anni ‘80 sono anche anni di grandi stragi: lo scoppio in volo dell’aereo Itavia nei cieli di Ustica (i morti furono 81 il 27 giugno), la bomba alla stazione di Bologna (il 2 agosto ‘80 con 83 morti e 200 feriti), ma anche l’attentato dei terroristi arabi all’aeroporto di Fiumicino che provocò 13 morti il 27 dicembre 1985.
Oltre al terrorismo politico anche la criminalità organizzata miete vittime: la più illustre è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre 1982) ucciso dalla mafia siciliana.
Il liberismo economico thatcheriano

Margaret Thatcher e il Vice - Presidente George H.W. Bush il 17 giugno 1987
Nonostante i successi ottenuti, la politica adottata dai laburisti per gestire la crisi scontentò le classi medie e suscitò malcontento nella sinistra del partito, che non approvava il contenimento degli aumenti salariali e il vincolo posto all’iniziativa sindacale. Alle elezioni del 1979 vinsero di conseguenza i conservatori guidati da Margaret Thatcher, il cui programma costituiva una riproposta dei dettami del liberismo economico (“neoliberismo”). Il nuovo governo intendeva, infatti, offrire una soluzione al disagio dei ceti medi. Il primo obiettivo della Thatcher fu di sconfiggere il ruolo dei sindacati. La “lady di ferro” non si limitò tuttavia soltanto a questo e con altrettanto impegno perseguì la riduzione della spesa pubblica e la privatizzazione di molti servizi sociali.
Nei primi anni il governo conservatore non riuscì a mettere in pratica il proprio programma; la recessione internazionale, dalla quale l’Inghilterra era tutt’altro che immune, lo indusse anzi ad aumentare la spesa pubblica per rilanciare la domanda e ad aumentare le tasse per contenere il deficit dello stato. Di conseguenza, se la vittoria nel confronto con il sindacato siderurgico e, qualche anno dopo, quella riportata sul sindacato dei minatori, rappresentarono effettivamente il drastico ridimensionamento del radicamento delle organizzazioni operaie, insufficienti furono i risultati raggiunti rispetto agli altri obiettivi. Proprio nel momento in cui il governo guidato dalla Thatcher sembrava destinato a entrare in crisi a causa dei bassissimi consensi di cui godeva, arrivò la guerra contro l’Argentina.
Al successo militare riportato dalla Gran Bretagna si affiancò la ripresa economica che prese avvio tra il 1982 e il 1983. Il momento non poteva essere più favorevole per i conservatori che, infatti, alle elezioni del giugno ‘83 ottennero una schiacciante vittoria. In possesso ora di un’ampia maggioranza parlamentare poterono realizzare il programma propostosi nel 1979: riduzione delle imposte sulle imprese e sui redditi alti, privatizzazione delle proprietà statali, soppressione di molti dei vincoli posti a tutela dell’ambiente, dei lavoratori o dei consumatori (“deregolamentazione”). Alla fine del mandato i risultati di questa politica furono tutt’altro che univoci: alla crescita economica, all’aumento dei posti di lavoro e alla riduzione dell’inflazione si contrapposero delle ombre: si registrò un netto scadimento dell’efficienza dei servizi pubblici (sanità, sistema scolastico, università), il declino dell’agricoltura e, in molte regioni, la deindustrializzazione, cioè lo smantellamento o la chiusura delle fabbriche. Gli elettori dettero, in ogni caso, un giudizio sostanzialmente positivo ai risultati raggiunti, e i conservatori vinsero per la terza volta consecutiva le elezioni. A differenza di quattro anni prima, tuttavia, il paese apparve diviso su base geografica: all’alto consenso per la Thatcher, riportato nelle regioni meridionali, centro dello sviluppo economico, si contrapponeva il crescente disagio delle regioni in cui avveniva il processo di deindustrializzazione. Agli squilibri geografici si accompagnavano quelli sociali. Mentre i manager della grande industria, i piccoli imprenditori, i tecnici avevano tratto beneficio dalla politica neoliberista, i lavoratori dipendenti, in particolare gli operai, vennero fortemente svantaggiati: essi assistettero a una diminuzione dei propri salari, a causa della politica fiscale e della sconfitta dei sindacati, alla riduzione dell’assistenza pubblica e, a partire dagli ultimi anni del decennio, all’aumento della disoccupazione.
Falkland - Malvinas: l’Inghilterra alla prova della guerra

Port Stanley, prigionieri di guerra argentini
Le isole Falkland (Malvinas) avevano sempre costituito, sin da quando erano state occupate nel 1833 dagli inglesi, un oggetto di contrasto tra questi e l’Argentina: abitate da una popolazione anglosassone, si trovavano al largo delle coste della nazione sudamericana.
Il 2 aprile 1982 il governo argentino procedette all’occupazione delle isole, con l’obiettivo di dirottare verso l’esterno l’enorme malcontento popolare; motivi d’altro genere non sussistevano, dato lo scarso valore strategico e l’inesistente valore economico dell’arcipelago. Nonostante questo, il governo inglese reagì con durezza e decisione e, dopo aver rotto le relazioni diplomatiche con l’Argentina, inviò verso l’arcipelago una vera e propria flotta da guerra. Fallita la mediazione degli Stati Uniti, che si schierarono poi con gli inglesi, il conflitto si svolse tra maggio e giugno, e vide la netta prevalenza dell’esercito britannico che non ebbe eccessiva difficoltà a piegare la resistenza degli argentini.
Nel giro di poche settimane l’embargo attuato dalla Comunità Europea e dagli Stati Uniti nei confronti dell’Argentina fu tolto e, in settembre, i due paesi belligeranti revocarono simultaneamente le reciproche sanzioni finanziarie imposte durante la guerra. Intanto, i generali argentini, a capo di un regime dittatoriale e responsabili di gravi efferatezze nei confronti degli oppositori interni, furono travolti dalla disastrosa disfatta; nel paese sudamericano, in sostituzione della giunta militare, si aprì dunque un lento processo di democratizzazione. In Inghilterra, invece, la guerra suscitò una vasta ondata di nazionalismo e vide gran parte dell’opinione pubblica favorevole a un intervento duro. La netta e rapida vittoria consentì quindi alla Thatcher di guadagnare un enorme consenso e di superare le difficoltà incontrate sino a quel momento.
La crisi mediorientale

La "linea verde" di Beirut 1982
Il Medio Oriente costituisce da decenni la polveriera del mondo contemporaneo. Al centro del problema si colloca la questione palestinese, causa di innumerevoli conflitti. Con gli accordi di Camp David, l’Egitto aveva normalizzato i suoi rapporti con lo Stato d’Israele.
La svolta dell’Egitto non fu però seguita dagli altri paesi arabi, i quali unanimemente hanno condannato il “tradimento” egiziano. A partire dalla metà degli anni Ottanta la situazione iniziò tuttavia a modificarsi. Alcuni di questi stati (Giordania e Arabia Saudita), insieme alla dirigenza dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), assunsero un atteggiamento più morbido, mostrando una maggiore disponibilità a trattare con Israele. Erano, infatti, disposti a riconoscerne l’esistenza in cambio del suo ritiro dai territori occupati (Cisgiordania e striscia di Gaza), dove avrebbe dovuto sorgere uno Stato palestinese. Il nuovo governo israeliano, però, guidato dai conservatori, promosse insediamenti proprio in quei territori, facendo sfumare la possibilità di un accordo. E fu proprio nei territori occupati che la tensione si accentuò nel corso del 1987. Da un lato i palestinesi diedero vita a una lunga rivolta (Intifada), che vedeva coinvolta gran parte della popolazione; dall’altro, gli israeliani aumentarono e irrigidirono gli interventi repressivi.
La crisi israeliano-palestinese trovò un nuovo campo di battaglia negli anni Ottanta nel Libano, teatro di una violenta guerra civile. Nel 1978 Israele aveva bombardato i campi profughi palestinesi vicini a Beirut, la capitale del paese, e nel giugno del 1982 intervenne nel conflitto in maniera diretta. Le sue truppe entrarono nella parte meridionale del paese, per cacciare le basi dell’OLP lì insediatesi, scontrandosi con palestinesi e siriani e riuscendo poi a occupare Beirut Ovest. Il conflitto ha vissuto da quel momento una violenta escalation. Nel settembre del 1982 moriva in un attentato il presidente libanese Bechir Gemayel, cui subentrò il fratello Amin. A pochi giorni di distanza, si compì l’evento più drammatico della guerra: la strage di civili palestinesi nei campi di Sabra e Chatila a opera dei falangisti (il gruppo dominante nella comunità cristiana). Alla fine del mese gli israeliani lasciarono Beirut e ivi fece ritorno la forza multinazionale di pace. Iniziò così il lungo periodo dei negoziati, turbati da una serie di attentati del gruppo estremista sciita “Jihad islamica”. Nel 1990, dopo quindici anni dall’inizio delle ostilità, l’accordo tra i due potenti vicini, Siria e Israele, assicurò la fine della guerra civile, senza tuttavia riuscire a garantire l’autonomia politica libanese.
L’Intifada e la pace irraggiungibile

Manifesto dell'Intifada
L’Intifada (“sollevazione”, ma anche “risveglio”) fu un movimento di protesta esploso nel 1987 nei territori occupati dallo Stato di Israele, caratterizzato dalla partecipazione di gran parte della popolazione palestinese, soprattutto giovani e giovanissimi, armati di pietre e bottiglie incendiarie, a scontri quotidiani con i soldati israeliani.
L’episodio che innescò la protesta avvenne nella striscia di Gaza l’8 dicembre 1987, quando un camion di coloni ebrei investì un’auto a bordo della quale si trovavano lavoratori pendolari palestinesi. L’atto, che sembrò ai testimoni deliberato, scatenò immediatamente una dura rivolta; i soldati israeliani intervenuti per sedarla furono respinti dalla folla con lanci di pietre. Nei giorni successivi la protesta si diffuse nella striscia di Gaza e in Cisgiordania assumendo grande ampiezza. L’Intifada fu quindi un movimento spontaneo, capace di produrre una propria leadership, indipendente dalle strutture dell’OLP di Arafat, che, solo in un secondo momento, riuscì ad assumerne la guida. La protesta nasceva dall’esasperazione e dalla sfiducia in una soluzione diplomatica del conflitto; i palestinesi residenti nelle zone occupate vivevano inoltre una situazione economica e sociale molto difficile, con un tasso di disoccupazione pari al 30%. Gli scontri, nonostante i tentativi di repressione, continuarono anche negli anni successivi: alla fine del 1992 si contavano 943 vittime palestinesi e 116 israeliane. L’Intifada, che riscosse anche la simpatia di ampi settori dell’opinione pubblica occidentale, costituì una seria sfida alla legittimità della politica di occupazione israeliana e rappresentò un’eccezionale mezzo di propaganda e autopromozione per i palestinesi e, soprattutto, per l’OLP. Essa ricondusse il conflitto alle sue radici storiche e territoriali, preesistenti rispetto alla contrapposizione militare fra Israele e gli altri stati arabi confinanti.
La fine delle dittature sudamericane

Il cerimoniale che elesse Raul Alfonsins predsidente argentino, 1983
Negli anni Ottanta il Sud America conobbe alcuni importanti cambiamenti. Nel 1982 cadde il regime dittatoriale argentino, principalmente a causa della dura sconfitta subita nella guerra delle Falkland-Malvinas (ultimo tentativo del regime di riconquistare consenso tra la popolazione). Alle elezioni seguenti vinse Raoul Alfonsin, esponente del Partito radicale (una formazione di orientamento progressista), il quale tuttavia non riuscì a conseguire il risanamento economico del paese. Ad Alfonsin successe, nel 1989, Carlos Menem, peronista, riconfermato poi alle elezioni del 1995.
Anche la dittatura di Pinochet in Cile terminò nel 1988 dopo un quindicennio di violenza e repressione politica, di indebitamento e impoverimento economico. Deposta la dittatura attraverso un referendum, che tuttavia non rimosse Pinochet dalla carica di capo delle forze armate, fu eletto, con un incarico governativo, il democristiano Alylwin. Il Cile si avviava ad attraversare una difficile fase di transizione verso la democrazia.
Anche il Brasile, dal 1964 al 1985, fu governato per circa un ventennio da una dittatura di tipo militare, particolarmente dura nella repressione dell’opposizione fino alla metà degli anni Settanta, in coincidenza con lo sviluppo nel paese di movimenti guerriglieri di impostazione maoista e guevarista. A governare il Brasile furono dei generali, tra cui Figueiredo dal 1979 al 1985.
Un mondo in subbuglio: il Centro America

José Napoleón Duarte
La vittoria della rivoluzione sandinista in Nicaragua scatenò tensioni in tutta l’area del Centro America e lo scontro tra rivoluzione e controrivoluzione che ne seguì segnò tutta la prima metà degli anni Ottanta.
Nel 1979 in Nicaragua la coalizione guidata dal Fronte sandinista (movimento rivoluzionario d’ispirazione socialista caratterizzato da un’impostazione politica vicina alle posizioni cubane) diede vita ad un’insurrezione che portò alla caduta della lunga dittatura militare di Anastasio Somoza, aprendo una nuova fase di mobilitazione politica e militare nell’intera regione centroamericana. Il regime sandinista si collegò strettamente ai movimenti di guerriglia attivi nei paesi della zona, riorganizzò l’apparato statale e avviò forme di pianificazione socioeconomica secondo gli schemi marxisti, destando attenzione e preoccupazione nel panorama internazionale. Furono soprattutto gli USA ad ostacolare l’esperimento sandinista, promuovendo il boicottaggio economico del Nicaragua e, soprattutto, appoggiando la guerriglia dei “contras”, movimenti armati di destra oppositori del regime. Nel 1984, alle elezioni presidenziali, si affermò Daniel Ortega, candidato delle sinistre, in un contesto politico egemonizzato dai sandinisti, tra i quali tuttavia si registravano le prime scissioni politiche. Il regime tese a impostare negli anni successivi una politica interna e internazionale più moderata; segno del cambiamento di rotta sandinista fu la costituzione approvata nel 1987, in cui si eliminava ogni riferimento all’ideologia e alla dottrina marxista-leninista. Nel 1990, dopo un decennio di guerra civile, la vittoria elettorale di uno schieramento di centro-destra, capeggiato da Violeta Chamorro e appoggiato dagli USA, che alleggerirono quindi la loro pressione sul paese, contribuì a un abbassamento della tensione, che, tuttavia, rimase piuttosto alta a causa della persistenza di vari focolai di guerriglia, di una continua instabilità politica e di una situazione economica molto critica.
Anche in Salvador fu combattuta una dura e lunga guerra civile, conclusasi con un accordo di pace dopo aver fatto migliaia di vittime tra la popolazione civile. Nel 1979 un gruppo di militari si impadronì del potere con un colpo di stato, provocando un duro inasprimento della guerra civile, in un clima di tensione causato anche dal fallimento della riforma agraria avviata negli anni precedenti. Nel 1980 il vescovo Oscar Romero, impegnato nella difesa dei diritti umani nel paese e malvisto dai diversi gruppi di potere affaristico-militari, venne assassinato da esponenti militari mentre celebrava la messa nella cattedrale: l’episodio ebbe grande eco in campo internazionale.
Alla fine del 1980, Duarte venne chiamato a presiedere la giunta militare. Alle elezioni del 1984 sconfisse il candidato delle destre D’Aubuisson, mentre il Fronte guerrigliero Farabundo Martì, attraverso la sua ala legalitaria, iniziava le prime trattative per la realizzazione di un piano di pace nel paese. La situazione si aggravò nuovamente nel 1989, quando il leader delle forze conservatrici, Cristiani, divenne presidente della Repubblica, dopo elezioni boicottate dalla sinistra e dai guerriglieri. Nello stesso anno gli “squadroni della morte” uccisero sei sacerdoti gesuiti. I colloqui di pace continuarono con la partecipazione dell’ONU nel 1991-92, ma solo nel 1995 il presidente Armando Calderòn Sol dichiarò ufficialmente compiuto il processo di pacificazione del paese.
Anche Panama fu oggetto di una situazione di forte tensione durante gli anni Ottanta. Il controllo delle forze armate e del governo del paese era passato a Manuel Antonio Noriega Moreno che, giunto al potere, decise di rafforzare il regime poliziesco del paese. Nel 1987 furono resi pubblici i legami di Noriega con i narcotrafficanti, specialmente quelli colombiani e il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro sporco. Noriega costrinse Delvalle, il suo principale accusatore, a lasciare il paese. Gli Stati Uniti risposero a questa mossa con l’imposizione di sanzioni economiche. Il 16 marzo 1988 un fallito colpo di stato contro Noriega inasprì il regime e intensificò la strategia della tensione attuata dal dittatore nei confronti dei suoi oppositori. Gli Stati Uniti, preoccupati anche per il controllo del Canale di Panama, decisero, il 20 dicembre del 1989, un massiccio intervento militare, con 24.000 soldati, per prendere il controllo della situazione. Noriega, per sfuggire alla cattura, si rifugiò per dieci giorni nella sede della nunziatura apostolica. Venne infine catturato e condannato negli Stati Uniti per traffico di droga, appartenenza ad organizzazioni criminali e riciclaggio del denaro sporco. Dopo la sua cattura, la carica di presidente passò a Guillermo Endara, vincitore delle elezioni del 1989.
L’apogeo del Giappone

Il ponte dell'arcobaleno di Tokyo
Uno dei principali eventi compiutosi nell’ultimo venticinquennio del secolo, e che ha modificato fortemente gli equilibri raggiunti, è stata la poderosa crescita economica vissuta dal Giappone. Il Giappone diventò negli anni ‘70 la seconda potenza industriale mondiale dopo gli USA e, negli anni ‘80, il paese finanziariamente più forte. Alla base di questa crescita ci fu una politica economica fondata sulla limitatezza del mercato interno e una struttura industriale “bipolare”, formata da alcune grandi concentrazioni (i complessi industriali-finanziari noti come “zaibatsu”) e una rete di piccole e medie aziende. Ciò consentì di ottenere una rilevante presenza sul mercato internazionale, e quindi di bilanciare le importazioni di materie prime, assenti sul suolo nipponico, mantenendo forti attivi nella bilancia commerciale. Lo stato svolse un ruolo rilevante applicando barriere protezionistiche per difendere i settori più deboli (innanzi tutto, l’agricoltura), alimentando la ricerca scientifica e sostenendo le imprese dei settori tecnologicamente sviluppati. L’elemento più peculiare e caratteristico dello sviluppo giapponese fu tuttavia costituito dalle innovazioni apportate al modello produttivo. Alle rigidità del “fordismo” (produzione standardizzata di grandi quantità di merci identiche, catena di montaggio, parcellizzazione delle mansioni) il modello giapponese sostituì un procedimento più flessibile, in grado di produrre merci differenziate al fine di rispondere a un mercato più incerto e instabile. Con l’inizio della crisi mondiale e del parallelo esaurimento del “fordismo”, il “toyotismo” (così viene chiamato) iniziò a essere adottato, pur con qualche variazione, anche dagli altri paesi industrializzati.
Le particolarità del modello nipponico non si limitarono ai fattori economici: a questi si legarono gli aspetti politici e sociali, altrettanto determinanti nel favorire la crescita. Per quanto riguarda i primi, il dopoguerra è stato segnato da una grande stabilità politica assicurata dal dominio ininterrotto del Partito liberaldemocratico. La mancanza di un ricambio generò un altissimo livello di corruzione, da cui derivarono alcuni scandali che scossero il sistema politico nel corso degli anni Ottanta. A ciò si aggiunse la presenza di un sistema istituzionale non sufficientemente democratico, che non garantì pienamente alcune libertà, ad esempio quelle sindacali.
Per quanto concerne la situazione sociale, non venne meno la grande influenza esercitata dalla mentalità e dalla cultura tradizionale, da cui derivavano un forte spirito di disciplina, una notevole abitudine all’organizzazione e uno spiccato spirito di gruppo; da ciò si originò il cosiddetto “spirito d’impresa”, che portava i lavoratori a condividere le sorti dell’impresa in cui erano impiegati. Al tempo stesso, alle prese con il rapido sviluppo e con la modernizzazione, la società si dimostrò tutt’altro che immobile. Da un lato, ai valori tradizionali si affiancarono modelli culturali tipicamente occidentali; dall’altro, non mancarono importanti momenti di alta conflittualità sociale.
Tali considerazioni generali hanno portato alcuni osservatori internazionali ad accomunare le vicende politiche e sociali susseguitesi dopo il 1945 della storia del Giappone a quelle dell’Italia.
La Cina di Deng: Piazza Tien’anmen

Il rivoltoso sconosciuto di Piazza Tienanmen
Dopo la morte di Mao Tse-tung, nel 1976, e una breve fase di lotta per la successione ai vertici della nazione, negli anni Ottanta, la politica cinese si è indirizzata verso il mantenimento di un saldo controllo politico del partito unico, accanto alla reintroduzione di elementi di liberalizzazione economica. Era il cammino proposto dall’ala moderata del partito prima della “rivoluzione culturale”, e il nuovo corso fu inaugurato dagli stessi dirigenti, sconfitti quindici anni prima. Le università, roccaforti delle “guardie rosse” maoiste, furono riportate a un sistema meritocratico e selettivo, e si introdussero elementi di diversificazione salariale e di commercio privato dei prodotti agricoli.
Negli anni Ottanta, la nuova politica economica si dimostrò vincente. Le campagne uscirono dall’autoconsumo, accumulando eccedenze destinate al mercato, e la crescita del prodotto interno lordo cinese ha registrato, in quel decennio, la media più alta del mondo, pari al 9%, portando la nazione ai primi posti in termini assoluti di ricchezze. Un elemento fondamentale del successo del nuovo corso è stata la stabilizzazione demografica: da una media di sei figli per donna si è passati, nel 1985, a una media di 2,4, garantendo livelli di popolazione stazionari. Ciò ha consentito di mantenere gli indicatori della qualità della vita a livelli stabilmente buoni. I cambiamenti maggiori avvennero nelle città, dove l’afflusso di capitali stranieri e la crescita di imprese private, dotate di autonomia di gestione e incentivate dallo stato, hanno prodotto un’accelerazione della crescita industriale e commerciale, e una crescente stratificazione sociale, sebbene la fine delle precedenti politiche assistenziali abbia provocato anche un temporaneo aumento della disoccupazione.
Accanto a tali incontestabili successi, tuttavia, l’establishment cinese ha dovuto affrontare una componente di dissenso interna, che chiedeva l’introduzione di elementi di democrazia occidentale nel sistema politico. Inoltre, un movimento di protesta, forte soprattutto nelle università, è sfociato, nel 1989, in una manifestazione di massa nella piazza Tien’anmen a Pechino, repressa con l’invio di truppe corazzate, che provocò centinaia di morti (parecchie migliaia, secondo fonti occidentali). Il Partito comunista era diviso fra riformatori e riformisti. Il leader Deng Xiao Ping premeva per una modernizzazione economica che non mettesse in discussione il monopolio del partito. Tutto iniziò il 15 aprile 1989 quando morì l’ex segretario del PCC Hu Yaobang, rimosso nel 1987 per eccessiva “debolezza” nei confronti dei riformatori. I suoi funerali si trasformarono in una grande manifestazione degli studenti di Pechino, che lo avevano eletto a simbolo di rinnovamento. Le manifestazioni, proseguite per alcune settimane, videro gli studenti occupare in modo permanente la grande piazza della capitale: Tien’anmen. Ad ogni giorno il numero dei partecipanti aumentava, e parimenti una serie di richieste di forti riforme che mettevano in discussione il sistema politico cinese. Dopo alcune incertezze, il partito optò per una linea dura al fine di risolvere una questione divenuta pericolosa, e tutto il movimento sfociò nella tragedia (resa pubblica dalla presenza di alcune emittenti televisive) di piazza Tien’anmen.
L’introduzione della legge marziale, revocata nel 1990, e una serie di arresti e di condanne a morte di dissidenti hanno riportato la situazione apparentemente sotto controllo, ma le gravi violazioni dei diritti umani, e la repressione del buddismo in Tibet, costituiscono un motivo di attrito, più fittizio che reale, nelle relazioni con i partner commerciali occidentali.
In politica estera, gli anni che vanno dalla morte di Mao al 1989, vedono la piena normalizzazione dei rapporti con gli USA ed i paesi occidentali (anche se si mantiene alta la tensione con Taiwan, alleata degli USA), una forte ostilità nei confronti dell’URSS (almeno fino alla metà degli anni ottanta), e soprattutto, l’intervento militare punitivo contro il Vietnam, reo di aver esteso la sua egemonia diretta sul Laos e di aver invaso la Cambogia (febbraio 1979); il sanguinario regime cambogiano di Pol Pot era infatti alleato con la Cina. La Cina inflisse gravi perdite ai vietnamiti, ma non li indusse a ritirarsi dalla Cambogia. Dopo decenni in cui il mondo (e l’Indocina in particolare) aveva visto movimenti di guerriglia comunisti combattere contro occupanti stranieri o governi filoccidentali, lo scontro tra Cina e Vietnam apparve come un rovesciamento della situazione, con una guerra combattuta tra due stati comunisti.
Costume e Società
La tragedia ambientale: Chernobyl

Ingresso alla "zona di alienazione" attorno a Černobyl' e Pryp'jat'
La fine della guerra fredda ha diminuito la consapevolezza di vivere sotto la minaccia degli arsenali nucleari, che dispongono di una potenza sufficiente a radere al suolo il mondo intero. L’allentamento del segreto militare ha permesso di venire a conoscenza di alcuni casi passati, nei quali un errore umano o dei sistemi di allarme hanno condotto il mondo sull’orlo di una guerra nucleare involontaria. Un rischio di questa natura non dipende dalle condizioni politiche internazionali. L’impotenza delle popolazioni a intervenire su una tecnologia, difesa dai governi, ha fatto sì che la paura per il pericolo nucleare si sia riversata sui rischi connessi ai suoi usi pacifici, in particolare dopo l’incidente di Chernobyl. Molti iniziarono a interrogarsi con preoccupazione circa la sicurezza delle centrali nucleari, sulle quali numerosi paesi industrializzati avevano basato i propri programmi di sviluppo dopo la crisi petrolifera del 1973.
Il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, presso Kiev, in Ucraina, si verificò un incidente gravissimo. A seguito di un’esplosione in uno dei reattori si ebbe una fuoriuscita di materiale radioattivo: le sostanze gassose, quelle volatili e il pulviscolo più leggero furono trascinate dalle correnti atmosferiche in quota e percorsero migliaia di chilometri, raggiungendo, in un primo tempo, la penisola scandinava e poi, in rapida successione, l’Europa centrale, l’Italia e la Francia. L’esplosione e la ricaduta radioattiva, a causa del colpevole silenzio sovietico, vennero scoperte quasi per caso dalla rete di controllo svedese solamente quarantotto ore dopo l’accaduto; per mesi i valori radioattivi ambientali di diversi stati europei risultarono anomali. Alcuni prodotti alimentari, come il latte e le verdure, furono esclusi dal mercato in base alla loro provenienza d’origine. L’incidente provocò immediatamente circa trenta morti, e le persone colpite in modo letale furono cento. Ma i danni nel lungo periodo restano incalcolabili: le nascite di bambini malformati e l’incidenza delle malattie collegate all’esposizione alla radioattività nella zona dell’incidente sono, tuttora, in aumento.
La nube radioattiva che aleggiava sulla testa di circa trecento milioni di persone scatenò un’ondata emotiva fortissima risvegliando nell’opinione pubblica mondiale l’interesse per le problematiche ambientali ed energetiche.
L’ecologia politica

L'immagine iconica della bambina vittima del disastro di Bhopal (India), dove circa 500 mila persone furono esposte al gas isocianato di metile e 15 mila persero la vita
Verso la fine degli anni ‘70 l’ambientalismo compì un profondo processo di maturazione trasformandosi e dando vita a movimenti politici che trattavano i problemi ambientali, incentrati sul concetto di “limite” dello sviluppo, che investiva gli orientamenti e le scelte generali delle società e dei sistemi politici, ponendo in discussione il vorticoso ritmo di sviluppo industriale e l’enorme produzione di beni.
All’inizio degli anni ‘80, il movimento ambientalista aveva compiuto interamente la sua trasformazione; qualche tempo dopo, sull’onda emotiva suscitata dall’incidente di Chernobyl, raccolse il frutto di questo rinnovamento, conseguendo importanti successi elettorali in tutta Europa. Grazie all’“ecologia politica”, si è acquisita maggiore consapevolezza intorno alle cosiddette “diseconomie ambientali”, vale a dire gli effetti negativi contemporanei dell’inquinamento, dell’esplosione demografica e della scarsità delle risorse naturali. Tuttavia, ignorando gli allarmi lanciati, si è continuato a sfruttare indiscriminatamente l’ambiente, prelevandone elementi quasi mai rinnovabili, scaricandovi gli scarti e i residui di lavorazione, e andando incontro, sovente, a veri e propri disastri ambientali. Basti pensare alle ricorrenti esplosioni e fuoruscite di petrolio dalle piattaforme di estrazione, o ai frequenti naufragi delle petroliere.
Nel 1980 la World Conservation Strategy, un documento redatto per iniziativa dell’ONU, sottolineò come, mentre una minoranza della popolazione del pianeta sprecava inutilmente la maggior parte delle risorse della terra, più di un miliardo di persone fosse costretto a vivere sotto il livello di sussistenza, e, di questo miliardo, 40 milioni morisse letteralmente di fame ogni anno. La presa di coscienza da parte dei governi nazionali e degli organismi sopranazionali portò a degli incontri in cui al centro della discussione si dibatteva la questione del rapporto fra abitanti e risorse del pianeta, come quello di Città del Messico nel 1984, lo stesso anno di un altro disastro: la nube tossica a Bhopal (India) che fece circa 2.000 morti.
Alla fine del decennio si raggiunsero i primi accordi internazionali: quello di Montreal nel 1987 per la riduzione del 50% della produzione di Cfc; quello di Noordwijk, in Olanda, nel 1989, in cui i rappresentanti di settanta paesi si confrontarono sull’effetto serra e sulla necessità di ridurre del 20% le emissioni mondiali di anidride carbonica. Nello stesso anno, per la prima volta, il vertice dei sette paesi più industrializzati fu dedicato alle questioni ambientali.
Non vi è dubbio, quindi, che il problema della limitatezza delle risorse e la necessità di non sperperarle pone in discussione il vorticoso sviluppo industriale e l’enorme produzione di beni a cui parte dell’umanità si è abituata, e sollecita tutti a rivedere i propri modi di vita e modelli di sviluppo.
La deforestazione

Deforestazione in Amazzonia
Nel 1989 ad Altamira, in Brasile, si tenne il primo incontro dei popoli indigeni dello Xingu, nel corso del quale fu denunciato il dramma di intere tribù dell’Amazzonia cancellate dalla faccia della terra assieme a ettari e ettari di foresta vergine. Infatti, tra i problemi più urgenti causati dal “saccheggio” vi era quello delle foreste. Questo meraviglioso serbatoio di ossigeno, di acqua, di sostanze organiche, di specie animali e vegetali sta scomparendo. Una delle conseguenze più preoccupanti dell’attuale modello di sviluppo, sul piano degli equilibri climatici, è legato alla deforestazione. Il ritmo annuo di scomparsa delle aree a copertura boschiva ha raggiunto, oggi, il valore di circa 12 milioni di ettari, cui si aggiungono 10 milioni di ettari di superficie forestale gravemente danneggiata. Più della metà di questo processo di disboscamento è dovuto alla domanda di legna da ardere o utilizzata per produrre carbone. Seguono gli usi nell’edilizia, nell’industria mobiliera e in quella di carta e cartoni, e (in Amazzonia) l’allargamento delle superfici di pascolo per allevamenti bovini (che, ogni anno, causano la perdita di 3 milioni di ettari di foresta pluviale). In misura assai minore, la deforestazione è causata anche da metodi arcaici di coltivazione su aree precedentemente bruciate. Questi tagli indiscriminati si effettuano soprattutto nella fascia tropicale in Asia, America Latina, Africa.
Tutto ciò provoca un’estremizzazione dei fenomeni in corrispondenza della stagione umida e di quella secca, portando a inondazioni e siccità, che causano danni enormi alle coltivazioni e alle aree abitate. Tra pochi anni, è stato calcolato che in molte parti del mondo di questo ambiente resterà solo un ricordo, con effetti dirompenti sul clima, sulla situazione delle acque, sulla conservazione delle fasce costiere e sulla disponibilità di terre coltivabili. Proprio quest’ultimo dato allarma più di ogni altro gli scienziati (diversi milioni di chilometri quadrati sono oggi sotto la minaccia di imminente desertificazione), e ad esso si deve aggiungere, inoltre, che solo nei paesi industrializzati vengono ogni anno distrutti circa 3.000 chilometri quadrati di suolo fertile per destinarli all’urbanizzazione.
Quanto all’aumento di temperatura, esso è collegato alla deforestazione in due modi: da una parte, tramite il minore assorbimento di radiazione solare calda da parte della superficie deforestata; dall’altra, con l’aumento percentuale di anidride carbonica nell’atmosfera, ciò che probabilmente favorisce il riscaldamento del pianeta nel cosiddetto “effetto serra”.
Nuove forme di vacanza

Una spiaggia deserta caraibica
Malgrado le varie crisi e l’aumento della disoccupazione, il mondo occidentale ha conosciuto negli ultimi vent’anni una crescita del benessere per i suoi cittadini. Il consumismo, che del benessere è una conseguenza, ha imposto la continua creazione di nuovi bisogni.
Le vacanze, fenomeno non nuovo, hanno conosciuto un boom senza precedenti: durante i mesi estivi milioni di persone si spostano e si recano verso località di vacanza proporzionate alle proprie tasche. Il turismo di massa, cominciato (almeno nell’Europa occidentale) con il boom economico degli anni ‘50, continuò la sua progressione negli anni ‘80 diversificando l’offerta: località marine o di montagna, in luoghi d’arte o in paesi esotici. Un fenomeno che modificò stili di vita e creò una vera e propria “industria del turismo”, che avrebbe fatto la fortuna anche di luoghi altrimenti posti ai margini dell’economia internazionale. Per i più danarosi aprirono le frontiere dei Caraibi e dei più noti paradisi tropicali: il ceto medio dovette invece accontentarsi delle località balneari di casa propria.
Nacquero anche nuovi generi di vacanza. La crociera, che conciliava la dimensione del viaggio a quella del comfort organizzato, era un lusso che negli anni Ottanta potevano permettersi anche le famiglie dei cosiddetti “colletti bianchi”. Il villaggio turistico offriva un tipo di vacanza in cui tutti i momenti della giornata erano pianificati e organizzati dall’équipe dell’animazione; emersero così compagnie di operatori turistici di dimensione internazionale come Valtur e Club Mediterranée. Il safari, invece, il viaggio nella giungla africana o nelle foreste amazzoniche, riproduceva artificialmente (tutto era programmato in anticipo) l’ambientazione dell’avventura ottocentesca. Presero piede anche le vacanze invernali. Le festività natalizie spostavano milioni di persone verso le località di montagna in cui era possibile praticare gli sport sulla neve.
Da Foiano a Rio: il carnevale

Carnevale a Rio
L’origine magico-religiosa del carnevale, quale rito a metà strada fra una celebrazione e una processione, è molto antica: forse affonda le proprie radici nei riti medievali tipici del mondo rurale.
Nel 1866 in un piccolo paese della Valdichiana, Foiano, si tenne la prima sfilata dei carri mascherati con l’utilizzo di semplici carrozze, addobbate a festa e colme di prodotti alimentari, come il grano turco, le castagne secche e i lupini, che erano gettati da dame e cavalieri mascherati alla popolazione assiepata lungo le strade. Verso gli anni ‘20 i “carri matti”, trainati da cavalli e poi da autocarri, erano completamente trasformati assumendo le sembianze degli antichi castelli turriti mentre, a partire dagli anni ‘30, è cominciato l’uso di costruire (con fili di ferro e cartapesta) e rappresentare allegorie di fatti e persone in forma sempre più fantasiosa.
Oggi il carnevale è una festa senza confini che assume diverse caratteristiche assai varie fra di loro, fermo restando l’uso del travestimento e della rappresentazione tramite la sfilata. Rio de Janeiro in Brasile, il più famoso e il più grande a livello mondiale, rinomato per le abbaglianti coreografie e per le bellissime ballerine delle scuole di samba che si sfidano tra di loro; Viareggio dove sfilano i carri allegorici più grandi del mondo, pieni di complicati meccanismi idraulici che permettono evoluzioni e movimenti alle maschere; Venezia, dove invece tutto è silenzioso, piccolo e ambiguo, dietro le enigmatiche quanto suggestive e raffinatissime maschere indossate direttamente dalle persone. Inoltre non si può dimenticare l’inconfondibile ritmo, una sorta di ska rallentato, che avvolge il Carnevale di Notting Hill Gate, festa annuale afro-caraibica che si svolge ogni anno a Londra alla fine di agosto.
La società dell’apparrenza

Martin Cooper di Motorola con il DynaTAC, il primo modello di cellulare per le masse (1973)
Le regole del consumismo imponevano la creazione di nuovi bisogni. L’esempio più lampante veniva dalla moda: ogni anno cambiavano i colori, i tessuti, i tagli dei vestiti e diventava sempre più difficile sottrarsi al rinnovo del guardaroba. Esplose il mercato della pubblicità, specialmente quella televisiva: i produttori di qualunque merce si ingegnarono in nuove forme di marketing.
Nelle case entravano incredibili elettrodomestici. Scope e spremiagrumi funzionavano ormai anche ad energia elettrica. Diventarono alla portata di tutti videoregistratore e forno a microonde. Le automobili si arricchirono di nuovi accessori: chiusura centralizzata delle portiere, alzacristalli elettrico, autoradio con impianto hi-fi, aria condizionata; inoltre vi fu una particolare attenzione da parte dei produttori automobilistici per i giovani che trovarono in commercio auto piccole ma colme di accessori accattivanti come spoiler di varie dimensioni, cerchi in lega, pneumatici ribassati e motori potenti che consentivano notevoli prestazioni sportive.
Si affermò il culto del corpo: palestre, centri di estetica, cliniche anticalvizie proliferarono ovunque. Così venne la moda delle videocassette con stelle del cinema che reclamizzavano gli esercizi di fitness e aerobica. L’insieme di tutti questi accorgimenti prese il nome di “look”, espressione simbolo degli anni Ottanta.
Erano soprattutto i giovani ad essere interessati da questa tendenza. Innumerevoli gadget entrarono nella loro vita quotidiana. Walkman e compact disc mandarono in pensione nel giro di un decennio i vecchi dischi in vinile. Si diffusero i primi videogiochi, sia domestici sia raggruppati in apposite “sale giochi”. Enorme è stato l’impatto sociale e culturale del “fenomeno videogiochi” poiché influenzò sia la sfera pubblica, appunto la sala giochi che diveniva centro di aggregazione, sia la sfera privata e cioè la “consolle” da casa che, nel giro di pochi anni, trovò spazio come un normale elettrodomestico casalingo, soprattutto per le nuove generazioni.
La moda

Giorgio Armani
Non è azzardato parlare di rivoluzione del costume, per quanto riguarda gli ultimi decenni. Tabù considerati fino ad ieri inviolabili caddero. Le tendenze giovanili sono cambiate: dagli hippy, passando attraverso i punk, siamo arrivati alla cosiddetta “X generation”.
Il mondo della moda cambiò profondamente divenendo una vera e propria industria, parallelamente alla crescita del benessere nei paesi avanzati. Molto più che in passato i grandi stilisti, in particolare quelli italiani, balzano in primo piano e vengono celebrati dalle cronache internazionali. Le grandi firme della moda hanno costruito dei veri e propri imperi commerciali, grazie anche all’espansione sempre crescente del settore del prêt-à-porter. La moda cambiava ogni anno, facendo emergere in continuazione nuove tendenze, dal revival degli anni ‘40 si tornò a quello degli anni ‘70, e cosi via. I giovani stilisti si imposero con collezioni provocatorie e innovative.
Lo shock petrolifero e la conseguente crisi economica che colpì tutto l’Occidente a metà degli anni settanta influenzò anche il mondo della moda: il sarto d’élite, dunque, si trasformò, in questi anni, nello “stilista”; vale a dire in colui il quale non si limitava a lanciare un’idea, ma la produceva o la faceva produrre sulla base di intese imprenditoriali, seguendone la realizzazione e curandone il marketing.
Negli anni ‘80 il prodotto “firmato” divenne progressivamente uno status symbol e i suoi creatori si cimentarono anche nel “restyling” di prodotti non di abbigliamento. La smania di griffe fu tale da far nascere uno smisurato giro di falsi: nel 1986 si calcolava che il mercato delle copie fosse equivalente al 30% del mercato degli originali. Gli stilisti, in particolare quelli italiani, furono celebrati dalle cronache internazionali, famosa fu la copertina del settimanale americano “Time” dedicata allo stilista Giorgio Armani nel 1982, e non c’era quotidiano che non si dotasse di supplementi di vario tipo dedicati alla moda. Proprio per questo, tra l’altro, furono sempre più numerosi i nomi in vista della cultura, dello spettacolo e anche dell’industria che, per sfruttare la vasta eco che la moda riscuoteva tra i mass media, unirono la propria immagine a quella di firme conosciute. A portare un’ulteriore ventata di novità, nel panorama divenuto stagnante sul finire degli anni Ottanta, furono alcuni designer giapponesi (Kenzo, Miyake, Yamamoto, etc.) che iniziarono a utilizzare l’alta moda come un mezzo espressivo, alla stregua di altre forme d’arte.
Gli stilisti dalla creatività al marketing

Valentino a Cannes
Il successo degli stilisti del prêt-à-porter, iniziato sul finire del decennio precedente, aumentò ulteriormente negli anni ‘80 considerati il periodo d’oro per la moda pronta, che poteva contare anche sull’apporto delle cosiddette “seconde linee”, vale a dire di quei prodotti disegnati dagli stilisti più famosi senza apporvi la propria griffe, e, dunque, commercializzabili a prezzi più contenuti. Il giro di affari diventò, in questi anni, così consistente da spingere nel 1986 alcuni gruppi, come Benetton, Lovable e Cfm, a entrare in Borsa. Era il “casual” a fare la parte del leone; il pubblico, infatti, manifestava un alto gradimento verso capi di abbigliamento a contenuto vagamente ecologico.
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta il mondo del prêt-à-porter assistette a una profonda trasformazione. Una quota sempre più consistente della sua produzione cominciò a provenire da alcuni dei cosiddetti paesi in via di sviluppo (Corea, Hong Kong, Turchia, Taiwan, ecc.) dove fiorivano grandi holding internazionali. Si trattò di un’ondata di tessuti raffinati, in particolare seta, che rivoluzionò la moda pronta, offrendo ai consumatori prodotti “classici” a prezzi decisamente abbordabili. Non era più il casual, dunque, a fare da padrone, ma prodotti sempre più vicini alle proposte dell’alta moda, che divennero alla portata di larghe fasce di pubblico.
Il pret-à-porter

Jean-Paul Gaultier
Il 1978 vide la definitiva affermazione del prêt-à-porter e diede avvio ad una stagione nella quale l’alta moda e tutta l’industria dell’abbigliamento presero a ispirarsi a temi del passato, seguendo il gusto del pubblico che desiderava “rifluire” verso uno stile più curato.
Per primi tornarono in auge gli anni ‘40 e ‘50, con la loro compassata e rigorosa eleganza che prevedeva il ritorno di tutti quegli accessori considerati in precedenza anacronistici: in America il nuovo stile fu adottato dallo yuppy che si contornava di oggetti tutti con il proprio “marchio” adeguatamente in evidenza. Il successo dell’operazione, che incontrava un vasto consenso di pubblico, testimoniato dal notevole incremento di vendite del settore, aprì la strada alla progressiva rivisitazione di numerose altre “mode” del passato. Dopo gli anni ‘50, così, si proseguì con gli anni ‘60. Ed ecco riesplodere l’optical di quegli anni e la minigonna a oltranza; una minigonna, però, senza le implicazioni femministe di quella lanciata a Londra vent’anni prima da Mary Quant. La stagione della Sixties-mania (colorata, in perfetto stile “Pop Art”, con i colori “più colorati”) abbracciò quasi per intero la seconda metà degli anni ottanta, di anno in anno diversamente riproposta. Gli anni ‘60 furono “elasticizzati” grazie a un nuovo tessuto, lo “stretch” (una combinazione di lycra, cotone e lana), che consentì di realizzare abiti capaci di aderire perfettamente al corpo.
Nel 1991, poi, fu la volta degli anni ‘70: era tutto un fiorire di pantaloni a zampa d’elefante e a vita bassa dai colori sgargianti, di tuniche, di gilet ricamatissimi, di patchwork e zatteroni. In quel periodo nacque anche la moda “etnica”, ispirata in particolar modo ai paesi d’origine di alcuni stilisti asiatici trapiantati a Londra.
Sebbene affinasse sempre di più, e con successo, la propria capacità di estrarre dal cilindro vecchie idee rinverdendole con opportune modifiche, l’industria della moda, tuttavia, ad ogni nuovo revival testimoniò la sua progressiva rinuncia a sperimentare e a percorrere itinerari innovativi. E proprio in contrasto con questa tendenza iniziarono a sorgere, a partire soprattutto da Londra, nuovi movimenti che miravano a ricondurre la creazione di moda nella sua sfera più naturale, quella della fantasia.
I “nobili” pettegolezzi

La Principessa Diana balla con John Travolta nel salone della Casa Bianca
Gli ultimi decenni si sono affermati come l’era dell’immagine e della comunicazione. La vita dei personaggi del jet-set internazionale, dei divi del cinema o della musica, o dei rampolli delle antiche aristocrazie appassiona i lettori, sempre più numerosi, della stampa scandalistica. Quel mondo di lustrini e serate di gala, di amori facili e liti furibonde ha suscitato sempre più interesse. E’ inevitabile che l’informazione fosse allettata da un mercato che prometteva di raggiungere alte tirature. Le cronache mondane si ricavarono uno spazio sempre maggiore nei giornali, e spesso erano le pagine più lette e richieste.
Uno dei bersagli favoriti dei paparazzi era la famiglia Grimaldi. Le avventure dei figli di Ranieri e di Grace Kelly fecero del piccolo stato mediterraneo un principato chiacchierato. Ma è stata sicuramente la famiglia Windsor, e in particolare le vicende di Carlo e Diana d’Inghilterra, ad essere al centro dei media negli ultimi anni.
La monarchia inglese, guidata dal 1952 da Elisabetta II, si è ritrovava, suo malgrado, quasi quotidianamente sulle prime pagine della stampa: la regina, timida e riservata, è stata sin dall’inizio rigorosa nell’imporre alla propria famiglia (il principe consorte Filippo, e i figli Carlo, Anna, Andrea, Edoardo) il rispetto della tradizione monarchica. Come sovrano costituzionale non si intrometteva, se non per le poche questioni di sua pertinenza, nella vita politica del Regno Unito. Ma erano proprio i problemi familiari a turbare la casa regnante, nonostante il fastoso matrimonio del primogenito nel 1982. Elisabetta II soffrì l’esuberanza delle nuore Diana Spencer, moglie dell’erede al trono Carlo, e Sarah Ferguson, moglie del terzogenito Andrea. Il fallimento dei due matrimoni, che si accompagnava a scandali, rivelazioni e pettegolezzi di ogni sorta, inflissero un duro colpo all’immagine della famiglia reale.
Un principato sotto i riflettori. La dinastia Grimaldi

La principessa Carolina e Alberto di Monaco con Ronald e Nancy Reagan. 1983
La dinastia dei Grimaldi, di origine genovese, ha festeggiato nel 1997 i settecento anni di regno. Ma il principato di Monaco è celebre anche perché non vi si pagano tasse, e per questo è stato scelto come luogo di residenza da molti degli uomini più ricchi del pianeta. Facile capire che Montecarlo, la capitale del piccolo stato, sia il luogo della mondanità per eccellenza.
Sotto i riflettori ci sono soprattutto le vicende della famiglia regnante, sempre in bilico tra il fiabesco e il tragico. La prima storia d’amore ad appassionare fu quella tra il principe Ranieri e la popolare attrice cinematografica americana Grace Kelly, conosciuta nel 1955 dal principe durante le riprese del celebre film “Caccia al ladro”. I due si sposarono ed ebbero tre figli, Alberto, Caroline e Stephanie.
La principessa Grace morì tragicamente in un incidente stradale nel 1982. Furono allora le due figlie a tenere banco nelle cronache mondane. La maggiore, Caroline, sembrò aver ereditato il carisma che era stato della madre. Dopo un primo matrimonio fallito con il playboy Philippe Junot, sposò l’italiano Stefano Casiraghi. Anche questo matrimonio reale si interruppe bruscamente. Appassionato di off-shore, Casiraghi perse la vita durante una gara. Il contegno della principessa non le risparmiò le attenzione di fotografi e giornalisti. Ogni momento di svago diventò l’occasione per l’attribuzione di un nuovo amore.
Molto più prodiga di spunti per il pettegolezzo fu la sorella Stephanie. Ribelle e stravagante, mise più volte in discussione con i suoi comportamenti la rigida etichetta di casa Grimaldi. I suoi fidanzati, fra autentici e supposti, furono numerosissimi e di ogni estrazione sociale. Pure per lei le scelte matrimoniali si rivelarono infelici (sposò una sua guardia del corpo dalla quale presto divorziò). Tentò addirittura di entrare nel mondo dello spettacolo cimentandosi, senza grande successo, nella musica leggera. E’ restato, invece, in secondo piano la figura del principe Alberto. Scapolo d’oro destinato alla successione al trono, segna la continuità con il carattere sobrio ed essenziale del padre. Anche a lui però di tanto in tanto sono stati attribuiti piccanti flirt (ad esempio con la top model Naomi Campbell).
Mercanti di morte: la piaga della droga

L'oppio si ricava dal lattice che trasuda dalle capsule immature del papavero officinale.
Nel corso del decennio il fenomeno della droga ha continuato ad espandersi. I dibattiti e gli studi intorno a questo problema sono infiniti; sembra certo che le droghe siano diventate parte integrante delle contraddizioni della società contemporanea. A fronte degli effetti distruttivi generati dalla dipendenza fisica, psicologica e quindi economica creata dagli stupefacenti, alle tradizionali politiche repressive (spesso del tutto inefficaci), si sono progressivamente affiancate forme di intervento mirate al recupero dei tossicodipendenti e alla diminuzione della “domanda”, specie fra gli adolescenti. Sono state inoltre costantemente dibattute a livello politico e culturale le diverse ipotesi per liberalizzare o legalizzare alcune sostanze stupefacenti.
I progetti di riconversione delle piantagioni di papavero promossi in Asia fin dalla fine degli anni ‘70 dall’ONU (come nel caso del Pakistan nel ‘79) sono praticamente tutti falliti, tranne nel caso della Turchia. Altre statistiche del 1982 segnalavano la diffusione della marijuana negli USA presso circa venti milioni di consumatori abituali, e stimavano la presenza di circa quattro milioni di eroinomani e morfinomani. D’altro canto, in Asia la coltivazione del papavero e l’uso di oppiacei fanno parte della tradizione economica e culturale dei diversi stati da molti secoli. Mentre la zona della Mezzaluna d’Oro (Iran, Pakistan e Afghanistan) possiede un’antichissima tradizione di coltivazione del papavero, utilizzato negli ultimi decenni per la produzione di eroina, e l’area del cosiddetto “Triangolo d’Oro” (una zona montana che si estende al confine tra Laos, Birmania e Tailandia) è stata adibita alla coltivazione del papavero durante la seconda guerra mondiale, ad opera dei francesi.
Il mercato mondiale della droga si può suddividere, dal punto di vista della produzione e del consumo, in tre filoni fondamentali: produzione e consumo di eroina, di cocaina, di hascisc e marijuana.
L’eroina, ricavata dalla coltivazione del papavero, è maggiormente prodotta nelle zone del cosiddetto “Triangolo d’Oro” (Birmania, Laos, Tailandia) e della Mezzaluna d’Oro (Iran, Pakistan e Afghanistan), per essere poi piazzata sui mercati del narcotraffico di Stati Uniti ed Europa. Il consumo di eroina, tuttavia, si è diffuso in dimensioni rilevanti in Europa solo negli ultimi anni, mentre era presente negli USA fin dagli anni ‘60. Secondo stime dell’ONU la produzione e il consumo dell’eroina si sono estesi, a partire dalla metà degli anni ‘80, anche in alcune aree dell’America centromeridionale, in particolare in Colombia e Guatemala.
La produzione di cocaina, sostanza ricavata dalla foglia di coca, avviene principalmente nell’America centromeridionale, soprattutto in Perù (che detiene i due terzi della produzione mondiale), Colombia ed Ecuador. La cocaina è consumata in Europa e in USA in misura massiccia a partire dagli inizi del decennio.
Hashish e marijuana derivano dall’essiccazione della pianta di cannabis e producono sul corpo umano effetti ridotti rispetto a eroina e cocaina. Questi stupefacenti vengono prodotti praticamente su scala mondiale, con particolare intensità in Marocco, Pakistan, Libano, Messico, Giamaica, Colombia e Afghanistan.
Il controllo delle “vie della droga”, dai paesi produttori del Sud del mondo ai consumatori del Nord, è gestito da “cartelli” e organizzazioni criminali internazionali, in una stretta integrazione tra aree di produzione e di consumo. Il quadro varia notevolmente a seconda delle aree geografiche: dalla mafia italiana e italo-americana, alla mafia russa, dai clan asiatici, ai potentissimi cartelli colombiani. Il narcotraffico è, comunque, una delle basi fondamentali per la fioritura della criminalità internazionale.
Famiglia, sesso ed evoluzione del “buon costume”

La bandiera arcobaleno durante una manifestazione
A seguito dei cambiamenti legislativi, la famiglia si è trasformata radicalmente: se in Inghilterra e nel Galles nel 1938 si poteva registrare un divorzio ogni 58 matrimoni, a metà degli anni ‘80 ce n’era uno su 2,2 fra i nuovi. Lo stesso accadeva in Belgio, Francia e Olanda dove tra il 1970 e il 1985 i divorzi triplicarono. Era possibile convivere senza sposarsi: negli anni ‘50 lo faceva solo una donna inglese su cento, negli anni ‘80 erano ventuno. Queste tendenze non riguardavano soltanto l’area occidentale ma, in misure peculiari caso per caso, anche quella socialista, nonché l’America Latina. Anche le famiglie mononucleari, i single, aumentarono vistosamente.
Nel 1974 l’Associazione degli psichiatri americani abolì, dopo un referendum interno, l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali. L’Organizzazione mondiale della sanità ci arriverà soltanto nei primi anni ‘90, con quasi vent’anni di ritardo, contribuendo a sancire la libertà e la piena legittimità dei diversi orientamenti sessuali. Negli anni ‘80 il movimento internazionale e quelli nazionali (in Italia l’Arcigay si costituì a Palermo nel dicembre del 1980) si batterono con forza per il riconoscimento dei diritti civili dei gay; cominciò l’era delle grandi manifestazioni. In Inghilterra il 28 aprile 1988 la comunità omosessuale scese in piazza per protestare contro la “clausola 28”, una norma che vietava allo stato di finanziare iniziative a favore dell’immagine dei gay. L’anno successivo, un’altra tappa fondamentale: a settembre la Danimarca approvò, primo stato al mondo, una legge sui matrimoni fra persone dello stesso sesso. Oltre alla richiesta del riconoscimento di diritti e alla lotta contro la discriminazione, si moltiplicarono i luoghi di aggregazione e di elaborazione culturale (cinema, musica, teatro), volti a garantire una socialità e una presenza nella vita civile prima precluse alla minoranza omosessuale.
Ma gli anni ‘80 furono anche quelli della grande minaccia per gli omosessuali. L’Aids decimò la popolazione gay, che si trovò anche isolata e marginalizzata dai gruppi politici più reazionari e conservatori. Il mutamento di clima si avvertì solo con l’inizio dei novanta.
L’impegno della musica: il Live Aid

Freddie Mercury al Wembley Stadium, 1986
Negli anni ‘80, contraddistinti in molti ambiti dalla voglia di evasione dalla realtà rispetto al precedente decennio, continuò tuttavia lo spirito di denuncia e di impegno nel sociale verso le tematiche politiche da parte del mondo musicale, in particolare da parte delle rockstar. Un tragico fatto di cronaca riportò le vedette internazionali ad occuparsi in prima persona di un problema divenuto di dominio pubblico.
Nel “corno” d’Africa, tra l’Etiopia e l’Eritrea, lo svolgimento contemporaneo di due guerre, la “desertificazione” di parte del territorio e l’inefficienza e la corruzione dei governanti ebbero pesanti ricadute sulle condizioni della popolazione. Nel 1983 una gravissima carestia ridusse tutto il paese alla fame: milioni di etiopi, alla ricerca di cibo e acqua, diedero avvio a un immenso esodo, mentre il governo si opponeva alla distribuzione degli aiuti internazionali in Eritrea e nell’Ogaden. Nei paesi occidentali, intanto, partì una campagna per la raccolta di fondi in aiuto delle regioni colpite dalla carestia. Con questo obiettivo, per impulso soprattutto del cantante dei Boomtown Rats, Bob Geldof, allo stadio di Wembley, a Londra, fu organizzato nel luglio del 1985 un grande concerto rock, il Live Aid, della durata di ventiquattro ore e teletrasmesso in diretta in quasi tutto il mondo; per la verità, il concerto si svolgeva anche negli USA e ci fu chi, come Phil Collins, partecipò dal vivo ad entrambi gli eventi. Con lo stesso scopo qualche mese prima, i più famosi cantanti avevano inciso una canzone, Christmas time, per sensibilizzare l’opinione pubblica; allo stesso modo, le maggiori rockstar statunitensi incisero una canzone divenuta presto celebre, We are the world.
Fra new wave, dark, new romantic e neo-mod

Gli U2: The Edge (in primo piano) e gli altri membri della band
Se nel corso degli anni Settanta l’universo giovanile era stato attraversato, di volta in volta, da una tendenza ben precisa, il decennio successivo vede gli adolescenti frammentarsi contemporaneamente in tante diverse “famiglie” o mode. Esse, in ogni caso, hanno tutte una caratteristica comune: ad ispirare i teen-ager degli anni Ottanta, infatti, sono sempre le star della musica o del cinema, e le mode, che difficilmente sconfinano oltre il terreno estetico, sono tutte di durata effimera.
Si inizia con il passaggio dal punk alla new wave, che muove i suoi primi passi sull’onda dei successi musicali di gruppi come i Talking Heads. E’ il trionfo della cosiddetta estetica “trash”: capelli corti, magari con qualche spruzzata di gelatina, pantaloni a sigaretta, calzini corti, scarpe bianche o nere a punta e poi, immancabile, la cravatta rigorosamente scura e sottilissima. La principale caratteristica del “new waver” è assistere a tutti i concerti delle sue star preferite e indossare, agganciate in bella vista sulla camicia o sul bavero della giacca, le spillette che ne riproducono i simboli.
Dalla new wave, come da un albero, si ramificano tante altre mode, tra le quali tre spiccano sopra tutte. La prima è quella dark o new-gotic. Ad essa aderiscono ragazzi, generalmente di estrazione alto borghese, che, annoiati della vita, si appassionano alle poesie dei poeti “maledetti” e alla musica di quei gruppi che eseguono un tipo di rock fatto di liriche infuse di pessimismo e suoni ipnotici, talvolta tenebrosi (ad esempio il gruppo dei Cure). Di tutt’altro genere la seconda moda, il fenomeno new-romantic. La sua filosofia è condensata nelle parole della canzone To Cut a Long Story Short del gruppo britannico degli Spandau Ballet: “I am beautiful and clean / and very very young”. Il new-romantic, dunque, è il primo teen-ager del decennio ad asserire esplicitamente la superiorità dell’immagine su ogni altro aspetto, contribuendo al trionfo della parola “look”. Decisamente più inquieta, infine, è la terza moda, il filone mod che, sull’onda del successo del film Quadrophenia, conquista gli adolescenti dall’animo più burrascoso. Essi si identificano e simpatizzano con Jimmy, il mod frustrato, irritabile e sfortunato in amore, protagonista della pellicola. Il neo-mod si riconosce dalle giacche e dai pantaloni in foggia anni Sessanta, e dall’inseparabile mezzo di locomozione che usa, la mitica lambretta. La moda mod è la più longeva fra le costole della new wave; essa, infatti, ha continuato a sopravvivere fino ai primi anni novanta, quando all’onore delle cronache giunge il gruppo inglese dei Blur, con le sue sonorità chiaramente ispirate allo stile mod.
A metà degli anni Ottanta, la “nuova ondata” inizia a mostrare il fiato corto. Le innovazioni sonore di Synchronicity, l’album culto dei Police, lasciano il passo al pop elettronico e ballabile degli Spandau Ballet e dei Duran Duran, che, ben presto, grazie alle loro melodie “neoromantiche”, divengono i nuovi idoli degli adolescenti. Sull’onda del successo di queste band tornano in voga i grandi concerti-evento e gli spettacolari tour mondiali, a cui assistono centinaia di migliaia di fan.
Il pop melodico domina il panorama della musica anglosassone per tutta la seconda metà degli anni Ottanta, salvo la breve parentesi costituita dal fenomeno Boy George e la comparsa sulla scena del gruppo rock irlandese degli U2. Ma, col passare del tempo, anche la melodia new-romantic deve cedere lo scettro a un nuovo genere, la pop-dance. I primi a sperimentarla erano stati, già nel 1986 i Pet Shop Boys, ma la sua consacrazione arriva agli inizi degli anni novanta con i Take That, cinque giovanotti di Manchester, che oltre a proporre canzoncine orecchiabili e di forte presa, si esibiscono in passi di danza coreografati con estrema professionalità.
La scena musicale americana

Springsteen durante il concerto del 19 luglio 1988 a Berlino Est
La musica d’oltreoceano più ascoltata nella seconda metà degli anni Settanta, e per tutti i primi anni Ottanta, è stata senza dubbio la “disco”. Questo genere musicale domina pressoché incontrastato la scena sino al 1985, quando, grazie al successo dell’album Born in the USA di Bruce Springsteen, non solo torna in auge quella che può essere considerata la bandiera musicale americana, ma si avvia una vera e propria nuova stagione creativa. Il rock del “boss” e della sua band si afferma rapidamente in ogni parte del globo, come dimostrò la tournée lunga due anni che riempì ovunque gli stadi dove si esibiva.
Di là a poco il pubblico sarà affascinato dai richiami al jazz, alla musica colta contemporanea e alla musica classica, presenti nella produzione di un artista come Prince, o dalla forza, dall’inventiva e dal ritmo di un altro cantante come Michael Jackson che con l’album Thriller batte ogni record di vendita. A cavallo di discomusic e new wave inizia la stagione di grandi successi per Madonna, che diverrà ben presto un’autentica icona per milioni di giovani.
Sempre oltreoceano, il genere reggae continuava a mantenersi vivo anche dopo la scomparsa di Marley, che muore a soli 36 anni nel 1981, stroncato dal cancro, e di Peter Tosh, l’altro apostolo della musica rasta, che viene ucciso a Kingston nel settembre del 1987. Numerosi gruppi continuano a mantenere viva la tradizione reggae, pur nelle sue molteplici mutazioni sonore: il dub, il toasting e il raggamuffin.
Ma la vera novità proveniente dall’America è stato il rap.
Rumori di periferia: tra rap e hip hop

Public Enemy
A New York, nella seconda metà degli anni Settanta, un manipolo di ragazzi afroamericani di bassa estrazione sociale, non avendo i mezzi per poter entrare nelle discoteche, iniziò a recarsi nei vari parchi e centri sociali allestiti per i meno abbienti, dove qualche disc jockey provvedeva a sistemare due giradischi e un paio di casse audio. Sono i tempi di DJ (disk jockey) pionieri come gli ormai leggendari Kool Herc e Afrika Bambataa, i quali si industriano per miscelare insieme due o più dischi e creare in tal modo qualcosa di nuovo. A un certo punto qualcuno dei ragazzi presenti agli improvvisati “parties” inizia a rappare, ossia a parlare ritmicamente su una base: è così che nasce la nuova musica rap, che molti cominciano a chiamare anche “hip-hop”, dal disco che introduce il genere al mondo, Rapper’s Delight, inciso nel 1979 dal gruppo newyorchese Sugarhill Gang.
Inizialmente, il rap è considerato solo una trovata estemporanea. Bisogna aspettare il 1986 e l’arrivo sulla scena di una nuova nidiata di rappers newyorchesi perché il “nuovo verbo” possa prendere piede: quell’anno pochi riescono a resistere alla forza trascinante di Walk this way, un brano in cui i Run DMC rappano su una base “metal” suonata dai popolari Aerosmith. Col tempo si impongono anche il giovanissimo L. L. Cool J., i politicizzati Public Enemy e i bianchi Beastie Boys.
Il rap si porta appresso anche tutto un catalogo di vestiario nato tra i neri dei ghetti: cappellini da baseball, medaglioni con la forma dell’Africa, scarpe da ginnastica senza lacci. Alla sua base vi è tuttavia anche una serie di caratteristiche che danno luogo alla cosiddetta “cultura hip-hop”; la principale di esse è l’interesse per l’emancipazione dei neri d’America e di tutti gli altri paesi occidentali, di cui divengono espressione le pellicole del regista cinematografico Spike Lee. Alcuni rappers utilizzano i loro pezzi rap, sia per rivendicare i diritti dei neri di fronte allo sfruttamento dei bianchi, sia per descrivere con toni crudeli la violenza che ha luogo quotidianamente nei ghetti afroamericani.
Alla musica rap si affianca un nuovo modo di ballare fatto di coreografie acrobatiche, quelle della break dance, su una base di movimenti spezzati ed androidi.
Il riutilizzo dei materiali musicali preesistenti, che nel rap forniscono le basi d’accompagnamento al canto, grazie alle nuove tecnologie elettroniche viene sempre più perfezionato da disc-jockey e musicisti in grado di creare una nuova musica da tracce precedenti. Il fenomeno nasce a Chicago, chiamato “house”, da musica prodotta a casa, e si diffonde ovunque, trasformandosi in varie correnti, e determinando una profonda rivoluzione sonora. Il saccheggio dal passato, si attua anche con dei campionatori, computer e processori che permettono di usare e modificare minime cellule sonore già registrate fino ad offrire infinite possibilità di riutilizzazione. Tutto ciò delinea una nuova realtà della musica elettronica che arriva ai tempi obliqui, spezzati e velocissimi dell’attuale movimento chiamato drum’n’bass.
La musica globale

Peter Gabriel durante una data del Conspiracy Of Hope Tour, 1986
Uno studio di registrazione attrezzato con le tecnologie più moderne a Box, tra il verde ed i laghi del Wiltshire, è la sede della Realworld, l’etichetta fondata dalla rockstar Peter Gabriel, già leader del gruppo Genesis, ed ora impegnato in prima linea nella ricerca di una sinfonia globale. Il catalogo della Realworld documenta le imprese di artisti delle etnie più disparate per definire un comune sentire tra i popoli, quel sentimento chiamato world music a cui si collegano alcune delle realtà più significative della musica dalla seconda metà degli anni ‘80. La world music riflette la società multietnica ed assicura un posto di primi piano ad artisti non occidentali, in grado di comunicare con la stessa intensità dei divi del pop. Il sentimento sonoro globale mette in luce talenti quali il cantante pakistano Nusrat Fateh Ali Khan, l’algerino Khaled, il senegalese Youssou N’Dour, il giapponese Ryuchi Sakamoto, e dall’Egitto i Musicisti del Nilo. Ognuno di loro è l’alfiere di una tradizione antica ed è aperto ad un confronto creativo con i protagonisti di altre culture.
In questa dimensione di collaborazione sono molti i progetti che hanno avvicinato differenti sensibilità. Si pensi alle avventure del cantautore americano Paul Simon, documentate dai dischi Graceland, 1986, a cui ha collaborato il coro sudafricano Ladysmith Black Mambazo, ed il successivo The Rhythm Of The Saints, del ‘90, animato dai brasiliani Olodum. Anche i musicisti dell’avanguardia trovano stimolante l’incrocio di culture, come dimostrano le opere ed i dischi prodotti dal bassista e maitre a penser della nuova scena newyorchese Bill Laswell: la ricognizione indiana di Hear No Evil del 1988 ed il progetto brasiliano Bahia Black, del ‘92.
Una realizzazione del 1990, che racchiude lo spirito della world music è il progetto One World One Voice, un lungo collage sonoro, realizzato dalla televisione inglese BBC, che unisce in una catena sonora musicisti di ogni lato del pianeta, registrati nelle loro terre e montati insieme in un’inarrestabile sequenza di emozioni.
La musica italiana

Il cantautore Fabrizio De André
Nel corso degli anni ‘70 e ‘80 la musica italiana ha proposto una serie di nuovi cantanti che si caratterizzavano per essere contemporaneamente gli autori delle parole, dei testi e i componitori della musica. Nei loro album, inoltre, questi cantautori, influenzati dai folk-singer americani come Bob Dylan, riflettevano l’impegno dei giovani nella politica. I testi raccontavano storie scomode di condannati, di prostitute, di adolescenti che si ribellavano contro i genitori, contro la scuola, di perdenti. De Gregori, De Andre’, Guccini, Dalla, Venditti, Bennato erano gli esponenti di spicco di questa tendenza che è proseguita nel corso di tutti gli anni ‘80. Per costoro amore non faceva più rima con cuore. Tuttavia, anche il filone romantico melodico continuò ad avere folle di ascoltatori: i vari Cocciante, Baglioni, Morandi raccolsero numerosi successi.
Gli anni ‘80, simbolo dell’apparenza e del look, videro il prolungamento del successo di due grandissime voci “assenti”: Mina e Lucio Battisti. I due cantanti continuarono a produrre dischi senza mai apparire in televisione, sui giornali o alla radio; anzi, più rifiutavano interviste e partecipazioni dal vivo e più aumentava la voglia di ascoltarli da parte di giovani e meno giovani.
Nel corso del decennio vennero alla ribalta nuovi personaggi che s’imposero all’attenzione nazionale e, in qualche raro caso, anche a quella internazionale: Eros Ramazzotti è stato l’esponente principale del filone melodico ed è riuscito negli anni ‘90 a essere apprezzato in diversi stati stranieri diventando una vera e propria star della musica pop internazionale. Come cantautore, “arrabbiato” e “sballato”, rispetto ai precedenti, si è imposto Vasco Rossi: le sue performance dal vivo hanno coinvolto migliaia di fans. Le sue canzoni, a volte urlate, a volte sussurrate, hanno raccontato le avventure del disagio quotidiano dei giovani ormai disillusi da tutto e da tutti, rimasti senza eroi e incapaci di sognare.
Infine si devono ricordare Pino Daniele e Zucchero, capaci di mischiare la propria originaria impostazione musicale, legata alle tradizioni locali (napoletana ed emiliana), con le tonalità del blues, riuscendo a interpretare dei brani accattivanti ed originali.
Le Olimpiadi da un boicottaggio all’altro: Mosca e Los Angeles

Cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Seul, 1988
Il contenitore resta lo stesso ma il contenuto cambia rapidamente. Le Olimpiadi restano l’appuntamento più atteso dagli atleti e più seguito dagli sportivi. Il requisito del dilettantismo per essere ammessi ai giochi perde progressivamente di importanza: dapprima è aggirato, poi viene completamente meno. Ma ad influenzare lo svolgimento delle Olimpiadi sono anche i grandi eventi politici, la guerra fredda in testa a tutti. Nell’estate del 1980 il presidente sovietico Breznev inaugura a Mosca la XXII Olimpiade dell’era moderna. Ad aderire alla manifestazione ci sono solo ottanta paesi. Mancano, infatti, le rappresentanze dei principali paesi dell’Occidente, in seguito al boicottaggio deciso dagli Stati Uniti come ritorsione per l’invasione sovietica in Afghanistan.
A risentire maggiormente dell’avvenimento furono le gare di atletica, che non fecero ottenere risultati interessanti: tuttavia grande fu l’impresa di Pietro Mennea che vinse i 200 metri.
Una situazione speculare si ripropone nel 1984 quando ad ospitare i giochi è la californiana Los Angeles. L’URSS annuncia che i propri atleti non prenderanno parte alle competizioni. Il boicottaggio è sostenuto da Cuba e da tutti gli stati europei e asiatici a regime socialista. Gli unici a non aderire al boicottaggio furono la Romania, la Cina e la Jugoslavia.
Si tornò a una situazione di vera competitività grazie alle olimpiadi di Seoul del 1988 che, grazie anche alla perestrojka e alla mutata situazione internazionale, videro la partecipazione, dopo 12 anni, di tutte le grandi nazioni sportive del mondo.
Il “figlio del vento”: Carl Lewis

Lewis sui blocchi partenza dei 100 m piani, ai Mondiali di Helsinki 1983
Nell’atletica leggera il personaggio più rappresentativo degli ultimi decenni è stato sicuramente l’afroamericano Carl Lewis. Atleta polivalente, ha studiato alla Houston University (1979-82) dove si mise in luce nel salto in lungo e nella velocità (100 e 200 metri). Nel 1981 vinse la sua prima gara importante: la medaglia d’oro nel salto in lungo nella Coppa del mondo. Nel 1983 vinse tre medaglie d’oro ai Campionati del mondo di atletica. La sua consacrazione avvenne però l’anno successivo alle Olimpiadi di Los Angeles, quando riuscì ad emulare il record del suo connazionale Jesse Owens (stabilito nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino) vincendo quattro medaglie d’oro: 100 e 200 metri, staffetta 4x100 e salto in lungo. In quest’ultima specialità Lewis ha trionfato anche nel 1988 e nel 1992, conquistando l’oro. In totale ha vinto 9 medaglie d’oro olimpiche, oltre a diversi titoli mondiali e a numerosissimi premi e trofei nei meeting di ogni continente. Non c’è alcun dubbio che il “figlio del vento”, così era soprannominato, abbia scolpito una pagina indelebile nella storia dell’atletica leggera divenendone il simbolo stesso.
Legata indirettamente alla figura di Lewis è stata la vicenda del doping che ha sconvolto i giochi di Seul del 1988. L’atleta canadese Ben Johnson vinse la gara dei 100 metri stabilendo il nuovo record con il tempo di 9,79 proprio davanti a Lewis. Appena 48 ore dopo però, al controllo antidoping, Johnson fu trovato positivo agli anabolizzanti, ai quali era ricorso anche durante la preparazione: venne squalificato per due anni e Lewis fu proclamato vincitore. La vicenda sconvolse il mondo sportivo e pose degli inquietanti interrogativi sulla validità delle gare e sui rischi per la salute degli atleti.
Il calcio

Lo juventino Michel Platini, autore dell'1-0 decisivo nella finale. La partita venne ugualmente giocata, nonostante la strage, per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico
Anche il calcio ha finito per piegarsi alle regole del mercato. Le società dei paesi europei più ricchi riescono ad acquistare i più famosi calciatori del mondo. Maradona ha giocato prima in Spagna nel Barcellona, poi in Italia con il Napoli, con cui vince, diventando l’idolo della città, due scudetti, nel 1987 e nel 1990. Approdano in Europa anche la maggior parte dei titolari delle nazionali argentine e brasiliane. Gli stadi si riempiono garantendo ai club incassi miliardari. I campioni vengono acquistati a cifre enormi e percepiscono ingaggi di miliardi l’anno. Diventano testimonial negli spot pubblicitari, attirano gli sponsor. Grossi imprenditori investono, anche per motivi di immagine, nelle squadre più quotate: negli anni Ottanta Silvio Berlusconi rileva il Milan, Bernard Tapie, in Francia, diventa proprietario dell’Olimpique Marseille. Le coppe europee (la Coppa dei Campioni, Coppa delle coppe, Coppa UEFA), ad esempio, mobilitano un giro d’affari che cresce di anno in anno, soprattutto per i diritti televisivi.
Spesso il tifo calcistico degenera in violenza. Risse, scontri tra tifosi, incidenti, talvolta anche mortali, sono all’ordine del giorno. A Bruxelles, il 25 maggio 1985, allo stadio Heysel si disputa la finale della Coppa dei campioni che vede di fronte la Juventus e gli inglesi del Liverpool. Prima dell’inizio della partita gli hooligans attaccano i tifosi italiani. E’ una tragedia: trentanove persone perdono la vita e quattrocentocinquanta restano ferite. Le squadre inglesi vengono squalificate dalle competizioni europee per tre anni.
A livello sportivo il decennio vede il prevalere di due figure: quella di Platinì nella prima metà del decennio, che ha portato la Juventus e la Francia ad innumerevoli successi; e quella di Maradona nella seconda metà del decennio che porta l’Argentina alla vittoria nei mondiali del 1986 in Messico, consacrandosi come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.
Il Mundial del 1982

Il presidente Pertini gioca a scopone con Zoff, Causio e il commissario tecnico Bearzot sull'aereo del ritorno dalla Spagna, con la Coppa del Mondo appena vinta dagli azzurri.
L’Italia arrivò in Spagna inseguita da un nugolo di critiche per il cattivo gioco espresso nell’ultimo anno, precedente all’importante appuntamento: le critiche contro il gruppo dei giocatori di Bearzot aumentarono d’intensità dopo i primi tre incontri del primo girone. Dopo le prime gare gli azzurri attuarono in silenzio stampa, fatto mai accaduto in precedenza. Il cammino degli azzurri si sarebbe fatto ben più difficile poiché le avversarie del girone per accedere alle semifinali sarebbero state l’Argentina, campione in carica, e il Brasile, da molti accreditato insieme alla Germania Ovest come uno dei favoriti alla vittoria finale. L’Italia giocò un poker di partite che la portarono alla conquista del titolo: sconfitta l’Argentina dell’astro nascente Maradona per 2 reti a 1, gli azzurri batterono il forte Brasile di Zico, Falcao e Socrates, per 3 a 2 con una tripletta di “Pablito” Rossi, fino ad allora rimasto senza reti ma che non si sarebbe fermato più. La semifinale con la Polonia fu un rotondo 2 a 0, con una doppietta di Rossi; in finale, alla presenza dell’entusiasta presidente della Repubblica Pertini, gli azzurri sconfissero i “panzer” tedeschi con un sonoro 3 a 1. Il calcio italiano, pieno di tatticismi, basato su una difesa quasi impenetrabile e su un gioco d’attacco che prediligeva il contropiede, fantasioso e pericoloso, dimostrò anche un’invidiabile tenuta atletica: la sicurezza del quarantenne Zoff tra i pali, le spietate marcature di Gentile, le intelligenti chiusure di Scirea, i funambolismi di Conti e i suoi impareggiabili cross, i gol di rapina di Rossi furono determinanti per la conquista del trofeo. L’urlo liberatorio di Tardelli in occasione della seconda marcatura durante la finale è, e sarà, l’immagine e il simbolo della vittoria azzurra.
Il pianeta degli estraterrestri: la NBA

Kareem Abdul-Jabbar e sullo sfondo Magic Johnson, nel 1985
Gli anni Ottanta vedono il successo planetario del basket della NBA (National Basketball Association) la lega professionistica americana, che travalica i confini statunitensi per divenire popolare in tutto il mondo.
Questo successo deriva, oltre che da un’efficacissima strategia di marketing portata avanti dal “commissioner” della NBA, David Stern, anche, e soprattutto, dall’accesa rivalità che ha caratterizzato la lega durante tutto il decennio, tra i Los Angeles Lakers, vincitori di 5 titoli, guidati dal poliedrico Earving “Magic” Johnson, giocatore dall’incredibile palleggio e visione di gioco, e i Boston Celtics, vincitori di 3 titoli, guidati da Larry Bird, giocatore dal tiro infallibile, l’unico “bianco” in grado di tener testa allo strapotere dei giocatori afroamericani.
Il decennio ha visto la presenza di altre grandi stelle, come Julius Irving, il famoso “Doctor J” dei Philadelphia 76s e il giovane astro nascente Michael Jordan dei Chicago Bulls ma è certamente il dualismo Bird-Magic a far decollare gli ascolti e la popolarità dell’NBA.
Gli anni Ottanta videro anche la prima vera sconfitta (quella subita alle Olimpiadi di Monaco del ‘72 non può essere considerata tale) del basket americano a livello internazionale, con la squadra olimpica statunitense, composta da giovani universitari futuri giocatori della NBA, sonoramente sconfitta alle olimpiadi di Seoul del 1988 dalla nazionale sovietica, guidata da Arvydas Sabonis, giocatore che gli americani stessi avevano guarito da alcuni gravi infortuni. Quella sconfitta convinse gli americani ad inviare la “vera” squadra alle successive olimpiadi, fatto che ha ulteriormente accresciuto la popolarità di questo sport nel mondo.
Il tennis

Ivan Lendl
Il decennio si apre all’insegna di John McEnroe: all’età di diciotto anni divenne il più giovane giocatore ad aver raggiunto le semifinali al torneo inglese di Wimbledon (1977) partendo dalle qualificazioni. McEnroe, soprannominato “Mac”, iniziò allora una carriera piena di successi. Vinse quattro volte gli US Open (1979-81), tre volte Wimbledon (1981, 1983, 1984). Numero uno mondiale quasi ininterrottamente dal 1979 al 1984, guida la squadra americana più volte alla conquista della Coppa Davis della quale rimane in pratica l’ultima bandiera; in seguito ne diventerà il capitano. Il suo prorompente talento di giocatore (fatto di fantasia e di tocco, in un tennis che tendeva sempre più a premiare la forza fisica e la regolarità) è stato spesso oscurato dal carattere rissoso. Le intemperanze del “Superbrat” - altro soprannome di cui è stato fatto oggetto - hanno sempre attratto l’attenzione dei media e gli sono costate richiami e multe record. Tecnicamente è stato l’inventore di un nuovo modo di servire; mancino, egli compiva una particolare torsione del busto da una posizione iniziale di partenza in cui era di spalle alle rete, e con i piedi paralleli alla linea di fondo. Nel momento dell’impatto con la pallina si trovava dentro il campo tutto proteso verso la rete dove riusciva a compiere volée straordinarie. Sono rimaste memorabili le sue partite con lo svedese Bjorn Borg, fra cui due finali a Wimbledon, e con il ceco (poi naturalizzato statunitense) Ivan Lendl, di cui si ricorda sempre un’indimenticabile finale persa sulla “terra” del Roland Garros a Parigi quando era riuscito ad avere persino due match-point.
Proprio Ivan Lendl è l’altra figura di rilievo nel decennio: tra l’84 e il ‘90 vince ben 8 titoli del Grande Slam e per più di 3 anni resta il numero uno mondiale. Il suo gioco era basato sulla pura forza fisica unita a un’elevata capacità di concentrazione; il colpo migliore, e cioè il più temibile, era il diritto preciso e violento col quale il giocatore costruiva e chiudeva vittoriosi scambi da fondo campo. Spesso indietro nei primi set, Lendl sapeva rimontare e chiudere vittorioso al quinto, grazie ad un’ottima preparazione atletica.
Anche in campo femminile si verificò un dualismo simile Gli incontri fra Evert e Navratilova, cominciati già negli anni ‘70, divennero la finale per antonomasia dei tornei del Grande Slam: per ben 36 volte le due campionesse si aggiudicarono i prestigiosi tornei. Sul finire del decennio, una nuova giovane stella fece la sua comparsa centrando il Grande Slam all’età di soli 20 anni: Steffi Graf.
L’automobilismo

Ayrton Senna alla guida della sua Lotus nel 1986
Il nome che più di tutti spicca nell’automobilismo è quello di Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula Uno (nel 1988, 1990 e 1991). La sua carriera si è svolta sotto il segno di grandi rivalità (in particolare con il pilota francese Alain Prost) e di uno stile di guida spregiudicato e aggressivo, ma anche sensibile all’occasione come ricorda il soprannome “mago della pioggia” per la sua abilità a guidare su piste bagnate. Il pilota brasiliano, introverso di carattere ed estremamente corretto in pista, ha perduto la vita durante il Gran premio di Monza nel 1994. La sua morte ha provocato un’ondata di grande emozione in tutto il mondo, in particolare in Brasile. Alla sua figura sono stati dedicati monumenti, competizioni sportive e canzoni.
Un altro grande campione è stato Nelson Piquet: anch’egli conquistò tre titoli mondiali, e le sfide con Senna assumevano i toni di un derby che proseguivano fuori dalle piste, dato che anche Piquet era brasiliano e assai diverso di carattere; scanzonato, aperto e ironico verso qualunque interlocutore.
Per Alain Prost, detto “il professore” parlano le cifre: 4 titoli mondiali e 4 secondi posti hanno fatto di lui il pilota che ha conquistato più punti di tutti. Il francese ha guidato per alcuni anni anche la Ferrari non riuscendo, tuttavia, a riportare la casa del cavallino rampante ai vertici mondiali; la crisi era cominciata nei primi anni del decennio con la prematura morte durante un gran premio del pilota Gilles Villeneuve. Il digiuno di risultati, interrotto soltanto da sporadiche vittorie parziali proseguirà anche negli anni ‘90.
Arte, Cinema e Letteratura
La svolta degli anni ‘80: il ritorno alla figurazione

The Portland Building è un esempio di architettura postmoderna
Superata l’epoca in cui il rinnovamento delle poetiche si doveva realizzare attraverso l’innovazione dei mezzi, alla fine degli anni Settanta, in tutto l’Occidente, si assiste ad una sorta di rifacimento della tradizione che è chiamato Post-modern. Il panorama della ricerca artistica si frantuma in una serie di tendenze che si esprimono tutte attraverso il ritorno alla pittura e ad un passato sovente rivisitato con ironia, attraverso il revival e il remake. Centri propulsori della “rivincita della pittura” sono l’Italia e la Germania, attraverso le tendenze della transavanguardia e del neoespressionismo, seguiti a ruota dalla Francia, con la Figuration libre e dagli Stati Uniti con la Bad Painting. Gli artisti di questi movimenti mantengono un’apertura nei confronti delle problematiche avviate negli anni precedenti, ma rivendicano il valore della “manualità” dell’opera contro la supremazia del progetto sull’esecuzione proposto dall’arte concettuale; ci si trova di fronte, dunque, al recupero della componente del mestiere. Queste nuove tendenze, che rappresentano una svolta nell’arte, sono presentate, ed ufficializzate, alla Biennale di Venezia del 1980. Le esperienze concettuali e minimaliste tuttavia, proseguono, dietro le quinte, anche in questi anni, fino a riaffacciarsi con nuova forza nel decennio successivo.
La transavanguardia italiana

Enzo Cucchi, Senza titolo, 1986, collezione "Terrae Motus", Reggia di Caserta
Una delle prime espressioni di questo “ritorno all’ordine” è rappresentata da un gruppo di artisti italiani che, nel 1979, è riunito, dal critico Achille Bonito Oliva, sotto l’appellativo di transavanguardia. “Un atteggiamento nomade di reversibilità di tutti i linguaggi”, come egli precisa, definisce la loro ricerca finalizzata, paradossalmente, a rinnovare le basi dell’arte tramite un recupero del passato. Una rivendicazione della completa libertà dell’artista si manifesta, nelle loro opere, attraverso l’utilizzo di citazioni tratte dalle più diverse tradizioni culturali: vari sono i modelli di riferimento, così come disparate sono le tematiche espresse. Riproponendo la teoria dell’eclettismo stilistico senza pregiudizi, che era già stata formulata in architettura dalla corrente postmoderna, i transavanguardisti si ispirano ai movimenti artistici dell’inizio del secolo, in particolare alle avanguardie storiche; tramite l’uso di un linguaggio evocativo, spesso arcaizzante, si riallacciano all’espressionismo, così come a Picasso, a Chagall, e soprattutto al Novecento italiano e alla pittura degli anni Trenta - Savinio, De Chirico, Carrà, De Pisis, Sironi, Scipione, Viani. La transavanguardia riafferma il diritto dell’artista ad esprimere la propria “coscienza felice” recuperando la dimensione fantastica e popolare, la pittura arcaica, le leggende, la visionarietà poetica, l’interesse simbolico, il tutto attraverso il piacere dell’esecuzione dell’opera e di una ritrovata manualità. Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, e Nicola De Maria sono i principali artisti - riuniti alla galleria Mazzoli di Modena - ai quali Achille Bonito Oliva attribuisce la condivisione di una stessa poetica. Il gruppo s’impone immediatamente nel contesto artistico internazionale degli anni Ottanta – in particolare attraverso l’opera di Chia, di Clemente e di Cucchi – caratterizzato da una sensibilità analoga di ripresa della figurazione. Sandro Chia parte da esperienze concettualiste - accompagnava le sue opere con scritti e poesie -, e giunge solo alla fine degli anni Settanta ad elaborare una pittura di impianto monumentale, di carattere mistico, che si ispira al repertorio iconografico sacro e profano del periodo manierista. Espone al Kunsthalle di Basilea e alla Biennale di Venezia nel 1980 divenendo in breve tempo uno dei personaggi più importanti della transavanguardia, tanto che nel 1981 tiene la sua prima mostra personale a New York. Nel 1981 dipinge il Narciso e nel 1985 realizza il gruppo L’Europa e il mare per i giardini della Tuilleries di Parigi; dal 1982, infatti, si dedica anche alla scultura. Clemente esegue principalmente acquerelli (Suonno, 1982) ispirati alle tradizioni popolari, ma realizza anche piccole statue in terracotta. Cucchi propone, su vasti formati, una pittura – sovente di tema mitologico - caratterizzata da un’atmosfera cupa e da un forte senso religioso; un esempio è Più vicino agli dei composto nel 1983. Le sue opere, simili a visioni apocalittiche, sono ottenute grazie all’utilizzazione di colori scuri tendenti al nero con bagliori di rosso scintillante e di giallo abbagliante. I quadri della seconda metà degli anni Ottanta elaborano vedute ossessive di città cimiteri, dalle quali emergono gocce, crani e ovuli fecondati che ricordano le “pitture nere” di Goya. Nel 1986 il Solomon Guggenheim Museum di New York ospita una sua grande mostra antologica. Mimmo Paladino e Nicola De Maria, con una pittura dalle forme semplici, tratte anche dai disegni dei bambini, si ispirano al mondo primitivo e alle tradizioni popolari.
La transavanguardia, in quanto tale, ha vita breve; tuttavia, separatamente, ogni artista continua ad operare seguendo quella libertà di stile che il gruppo aveva rivendicato. Nel testo Transavanguardia internazionale del 1982, Bonito Oliva cerca di ampliare la sua definizione del gruppo per includere Lüpertz, Baselitz, Schnabel, e Basquiat, poiché riscontra una vasta influenza del movimento anche tra i neoespressionisti tedeschi ed americani.
Nuove esperienze pittoriche in Italia: gli anacronisti

Omar Galliani, Nuovì Fiori, Nuovi Santi, 2012 matita nera su tavola
In “Una mostra di sei pittori”, esposizione organizzata nel marzo del 1980, Maurizio Calvesi presenta al pubblico, nella loro prima uscita, gli anacronisti: Abate, Di Stasio, Marrone, Pirica e Pizzi Cannella; nel maggio seguente la mostra è riproposta alla Galleria De’ Foscherari di Bologna dove ai precedenti si aggiungono Lorenzo Bonechi, Omar Galliani e Ubaldo Bartolini, mentre nella sezione “Aperto 82” della Biennale veneziana, Calvesi avvicina a questi artisti anche i francesi Gerard Garouste e Jean Michele Alberola. La “pittura colta”, denominata anche citazionismo o anacronismo, è caratterizzata dal recupero delle tecniche, degli stili e dei temi del passato con valenze manieriste, neoclassiche e fantastico-letterarie. I rappresentanti di questa “tendenza” intendono contraddire la modernità intesa come concetto progressistico e, attraverso un recupero della pittura negata dai concettualisti, contrapporsi alla contemporanea transavanguardia. Tra i rappresentanti più significativi appare Carlo Maria Mariani, che, con uno stile iperrealista, recupera l’immagine pittorica come “pratica tecnica”. Nel 1975 la sua pittura si rivolge al passato con un procedimento analitico-concettuale attraverso un’indagine dei rapporti tra fotografia e pittura. In questo periodo partecipa ad una serie di mostre tra cui: la personale “Affinità elettive” tenuta a Milano nel 1977, e la mostra organizzata ad Anagni, nel 1984, “Anacronismo e ipermanierismo” curata da Maurizio Calvesi e Italo Tomassoni. Partendo da spunti teorici letterari, quali ad esempio Mengs e Winckelmann, l’artista costruisce un proprio percorso simbolico e narrativo; punto di riferimento costante diviene dunque il neoclassicismo, al quale attinge fino ad identificarsi con l’opus e a perdere ogni pulsione d’individualità. Di Mariani si ricordano: La mano guida l’intelletto del 1983 e Aprile del 1988. Lontano dallo spirito neoclassico di Mariani, Omar Galliani si rifà, invece, al manierismo emiliano, come traspare nell’opera Fendente (1984), dove sono evidenti i richiami al Correggio e al Parmigianino. Abate, ne I cieli della Luna (1984), si orienta verso espressioni simboliste, mentre Pirica e Di Stasio sono invece vicini all’imagerie rinascimentale-barocca. Bonechi si esprime principalmente attraverso uno spiritualismo mistico ed allegorico (Figura con l’angelo, 1982).
I “Nuovi Nuovi” e gli artisti romani

Luigi Ontani, Ecce homo
Nell’ambito del ritorno alla pittura negli anni Ottanta si pongono anche i “Nuovi Nuovi” riuniti da Renato Barilli nel 1980 alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna; la mostra “Dieci anni dopo. I nuovi nuovi” si riconnette idealmente all’esposizione di dieci anni prima, “Gennaio ‘70”, impostata su un clima tra “povero” e “concettuale”. Barilli, Francesca Alinova e Roberto Daolio intendono sottolineare la nascita di un nuovo corso dell’arte italiana, eclettico, immaginifico, eterogeneo nelle tecniche e nel contenuti e soprattutto distinto dalla transavanguardia. Enrico Barbera, Bruno Benuzzi, Antonio Faggiano, Luigi Mainolfi, Giuseppe Salvatori, Luciano Bartolini, Enzo Esposito, Giuseppe Maraniello, Salvo, Luigi Ontani sono i principali protagonisti di questa ipotesi di figuralità “postmoderna”. Libere citazioni dall’antico o di rovine, paesaggi elementarmente definiti, un cromatismo acceso, caratterizza lo stile di Salvo, al quale è affidato un ruolo di pioniere. Il mito inteso come viaggio tramite la reinterpretazione di moduli decorativi antichi (si ricorda Settentrione del 1981), cattura invece l’attenzione di Bartolini.
Luigi Ontani, partito dall’arte povera, tiene, nel 1970, la sua prima mostra personale al Centro San Fedele di Milano dove presenta oggetti pleonastici: calchi di gesso, sagome di cartone e oggetti in gommapiuma colorata rosa e celeste. Lo stesso anno si trasferisce a Roma dove inizia a tenere performance proponendo tableaux vivants: una galleria di personaggi che documenta con foto di grande formato con colori vivaci: Pulcinella, Superman, Dracula. Dopo importanti esposizioni personali all’estero (Amsterdam, Parigi, New York), nel 1978 partecipa alla Biennale di Venezia. La produzione di maschere costumi e accessori vari, indispensabile alla sua attività di performer, si arricchisce negli anni Novanta di apparati, di arredi e di elementi decorativi in vetro soffiato e porcellana. Questi oggetti si inquadrano nel progetto utopico per una Casa degli Ontani per la quale realizza tavoli, specchiere e applique.
Sempre nell’ambito del ritorno alla pittura in Italia, all’inizio degli anni Ottanta una sorta di sodalizio unisce un gruppo eterogeneo di artisti romani (Ceccobelli, Dessì, Bianchi, Pizzi Cannella, Nunzio, Tirelli) che, al contrario della transavanguardia, non recuperano la figurazione ma una pittura iconica o astratta, caratterizzata da brevi accenni di immagini, frammentarie, embrionali. Un colore morbido, lieve, ottenuto a mezzo di velature successive, contraddistingue i quadri di Domenico Bianchi, costruiti secondo ritmi e moduli geometrici. L’infinito, l’origine primordiale, l’universalità e il cosmo sono i temi delle sue opere, in cui il centro coincide con il soggetto stesso del quadro, accoglie cifre simboliche, segni elementari, come la croce o il cerchio, intagliati o graffiti sulla superficie pittorica sia essa a olio, a gesso o a cera. L’artista utilizza supporti diversi: da blocchi di cera, a pannelli di legno, a tavolette in cotto, a fibra di vetro, sfruttando le diverse caratteristiche della superficie con cui pone in relazione la pittura. La cera assume un ruolo decisivo nella sua ricerca artistica per la sua prerogativa di restituire la luce. Sostanza immateriale, libera energia, la luce alleggerisce la materia apportandole profondità e trasparenza, trasforma la superficie in spazio metafisico. Nel 1984, 1986 e 1993, con una sala personale, Bianchi partecipa alla Biennale di Venezia, mentre, nel 1989, il Museo d’arte contemporanea di Rivoli gli dedica una mostra.
Il neoespressionismo tedesco

Glaube, Hoffnung, Liebe - Fede, Speranza, Carità da Anselm Kieffer, 1984-86
Già presente negli anni Settanta, ma oscurato dall’arte concettuale, il neoespressionismo si afferma all’inizio degli anni Ottanta sulla scia del successo della transavanguardia italiana. La rivalutazione del linguaggio pittorico, ha consentito un maggiore apprezzamento di quegli artisti che lavoravano, già dagli anni Sessanta, con il medium pittorico, come Gerhard Richter e Sigmar Polke. Ispirandosi ad autori espressionisti, come Nolde, Marc, Kirchner, i “nuovi selvaggi” recuperano un tipo di pittura basata sulle pennellate evidenti, sui colori pastosi, densi, miscelati con rapidità. Il repertorio delle immagini risente della considerazione tragica della recente storia tedesca (Kiefer; Baselitz), del recupero di una figurazione arcaica, stilizzata e simbolica (Penck), della continua contaminazione di stili diversi (Lüpertz; Dokoupil). La galleria più importante nel lanciare il movimento è stata quella di Michael Werner che da Berlino Est si era trasferito a Colonia, centro dal quale si è irradiata la fortuna commerciale del gruppo. Nel 1980, alla Biennale di Venezia, questi artisti sono presentati all’attenzione internazionale, ma sono soprattutto Richter, Baselitz e Kiefer ad ottenere i maggiori riconoscimenti.
I “nuovi selvaggi”

Armalamor (1994) Biblioteca nazionale tedesca di Francoforte
Richter focalizza la sua attenzione, dal 1962, sul rapporto tra fotografia e pittura. Per far risaltare le potenzialità della pittura e l’ambiguità della fotografia, usa come modelli dei suoi quadri soggetti fotografici tratti da dépliant pubblicitari e da vecchi album di fotografie in bianco e nero (48 Ritratti di uomini celebri, 1971-1972). La diversità della sua produzione - i paesaggi a colori, la ripresa di temi classici e nature morte, i lavori con gli specchi, i grandi quadri astratti realizzati con grandi spatole, le serie recenti di quadri figurativi a colori sempre sfocati, i quadri espressivi astratti degli ultimi anni - è da lui stesso “teorizzata” e rivendicata: “Evito qualsiasi fissazione. Non so ciò che voglio. Sono incoerente, indifferente, passivo; amo l’indefinibile e l’illimitato, e l’incertezza continua”. L’artista ha partecipato alle maggiori manifestazioni artistiche del mondo ed espone in mostre personali nei maggiori musei internazionali (fra gli altri il Centre Georges Pompidou di Parigi, la Nationalgalerie di Berlino, il Museum of Contemporary Art di San Francisco).
Nel 1958 Baselitz si trasferisce a Berlino Ovest ed inizia ad interessarsi alle immagini realizzate da alienati mentali, conservate nella collezione Prinzhorn. Seguono i cicli di opere Idol (1964) Helden (1965) Fraktur (1966) e le sperimentazioni con incisioni su legno. Nel 1969 propone il primo dipinto dove il soggetto è rovesciato, soluzione che spiega semplicemente così: “Sei oppresso dai problemi sociali, finanziari, e di salute e improvvisamente ti accorgi che le basi delle tue opere precedenti sono state rimosse. Dovevo dipingere nuove immagini così le ho capovolte”. Nelle sue sculture appare più evidente che nella pittura l’influsso dell’espressionismo. Esse rivelano una forza primordiale: sculture di legno tagliate in modo grezzo e decorate con delle accentuazioni di colore (Testa scolpita, 1986).
La storia della Germania è invece uno dei temi principali della pittura di Kiefer, in particolare il recente passato, i dodici anni nazionalsocialisti. Lo stereotipo della germanicità ha creato fraintendimenti e dispute riguardo la sua opera già nel 1980 quando nelle recensioni alla Biennale fu accusato di ostentare temi nazionalisti; in realtà il suo lavoro è legato alle immagini del mito e della storia in una totale simbiosi. La sua pittura, lavorata a grandi colpi di spazzola, arricchita di paglia, di catrame o di foglie di piombo e sfregiata con gli slogan, rappresenta allusivamente edifici in rovina, campi abbandonati, colonne crollate. E’ una visione particolarmente cupa, una natura alternativamente percepita come esaltante e nefasta. Stelle cadenti è l’ultimo ciclo di lavoro di Kiefer: trenta lavori degli ultimi due anni (1997-1999), grandi dipinti, installazioni, sculture in piombo, libri. Tra questi Horus e Nachtschatten (l’ombra della notte) giganteschi scaffali contenenti enormi libri di piombo, che paiono destinati all’eternità. Dalle librerie fuoriescono girasoli e piante di pomodoro essiccate: un sapere pietrifico aggredito e invaso da una natura feroce anch’essa congelata. Il ciclo Stelle Cadenti è stato oggetto di una mostra presso la Galleria d’Arte moderna di Bologna nel 1998-1999.
Il graffitismo

Graffito di Jean Michel Basquiat
Negli anni Settanta in America i graffiti – eseguiti con bombolette spray - sono espressione della cultura underground dei quartieri malfamati del Bronx e dell’East Village. Disegni stile comics e Tags, sovente firmati con uno pseudonimo, decorano i treni e i muri delle metropolitane: sono per lo più espressioni di ragazzi giovanissimi, membri delle minoranze etniche cresciuti al ritmo della rap music e della break dance. Il lancio della corrente, che si inserisce all’interno della ripresa della figurazione pittorica degli anni Ottanta, avviene nel 1980 ad opera dello scultore Tom Otterness con la mostra dal titolo “Times Square Show”, alla quale partecipa Basquiat. Ben presto il graffitismo conquista, sotto lo sguardo benevolo di Andy Warhol, gli spazi delle più esclusive gallerie newyorchesi perdendo così l’aggressività espressa appieno sui muri delle periferie degradate; passa dalle strade alle gallerie di Soho. I graffitisti escono dalla clandestinità nel 1981 quando il critico e mercante d’arte Rene Ricard dedica a questo fenomeno newyorchese un articolo sulla prestigiosa rivista “Artforum”. Tra i tanti giovanissimi artisti (ricordiamo fra i tanti Kenny Sharf e Richard Hambleton) Keith Haring e Jean Michel Basquiat raggiungono il successo internazionale. Documenta VII di Kassel ne incorona, nel 1982, i tre più acclamati esponenti che sono Haring, Basquiat e George Lee Quinones. Una pittura dal linguaggio semplificato, ispirata al primitivismo ed erede dei fumetti e del fenomeno pop, caratterizza gli esponenti del graffitismo; figure caricaturali immerse in un insieme di scritte e segni, realizzate con colori molto vivaci rappresentano il comune denominatore.
Basquiat e Haring

Keith Haring, We Are The Youth (1987), Ellsworth Streets, Philadelphia
Col marchio “Samo” accompagnato da una corona stilizzata, pseudonimo di Jean Michel Basquiat, impresso sui muri delle metropolitane, egli diviene famoso già nel 1977. Seppure controversa la sua notorietà è immediata e irrompe sulla scena internazionale: lo stesso anno si inaugura la sua prima esposizione personale a New York e in Italia a Modena (a cura di Achille Bonito Oliva), mentre l’anno seguente partecipa a numerose collettive, a “Documenta 7”, e a Roma alla mostra “Avanguardia-Transavanguardia”. Dal 1984 lavora insieme a Warhol ad alcune tele che saranno esposte in una mostra-evento nel 1985. Si allontana, via via, dal graffitismo vero e proprio senza però rinunciare a riportare sulla tela l’espressione dei contenuti socialmente provocatori propri della vita della strada. Le sue tele sono ricche di citazioni dai media, di immagini grottesche e di riferimenti al jazz e al vudù che richiamano la cultura delle minoranze etniche cui lui stesso apparteneva. Nel 1988 muore per overdose a soli ventotto anni e una fine tragica colpisce similmente anche l’altro famoso rappresentante di questa tendenza artistica: Keith Haring, che muore di Aids nel 1990. Le sue pitture – caratterizzate da uno stile calligrafico, da un segno infantile e da immagini che, in un evidente horror vacui, si rifanno all’arte primitiva – possono essere interpretate, nella sua prima produzione, come un inno alla vita (famosi sono i “bambini radianti”, gli omuncoli contornati da un’aureola di raggi). La scoperta della sua malattia si riflette, successivamente, nella sua arte che assume dei toni tragici, rivelando un interesse per tematiche socialmente impegnate. Nel 1982 presenta il suo cartellone luminoso a Times Square che riflette, ad intervalli regolari, sue immagini elettroniche. Nel 1983 decora le pareti dei negozi Fiorucci a Milano. Oltre alle molte mostre personali tenute in Italia (Bologna, Napoli), Haring partecipa, nel 1984 a Bologna, alla mostra “New York Graffiti. Arte di frontiera”.
La Figuration libre

Robert Combas
In Francia all’inizio degli anni Ottanta, sulla scia del ritorno alla pittura, nasce il gruppo della Figuration libre. I riferimenti sono alla transavanguardia e al graffitismo americano con un’evidente influenza anche dell’Art Brut di Dubuffet. Il rinnovamento della pittura avviene attraverso il recupero delle immagini popolari della pubblicità, dei fumetti, delle decorazione dei flipper, delle immagini naïf della pittura. La prima mostra è realizzata nella galleria Lamarche-Vadel dove le pareti dello spazio, che stava per essere abbandonato, sono completamente dipinte dai principali rappresentanti del gruppo: Robert Combas, Remy Blanchard, Hervé Di Rosa. Ciò che rivendica il gruppo è secondo le parole di Combas “la libertà di fare ciò che si vuole”. Le affinità con i graffitisti americani saranno sottolineate dalla mostra tenuta nel 1984 all’Arc Musée d’Art Contemporain de La Ville de Paris dove sono messi a diretto confronto i francesi della Figuration libre e i principali graffitisti americani (Basquiat, Haring, Scharf).
Il neoespressionismo negli Stati Uniti

"Mana" Lisa
L’espressione inglese Bad Painting è il titolo di una mostra, di sola pittura, organizzata a New York nel 1978. Il titolo polemico vuole sottolineare la tendenza a contrapporsi alla linea ufficiale delle maggiori gallerie del quartiere di Soho che privilegiano artisti concettuali e minimali. Inoltre in maniera ironica “cattiva” si rifà alla pittura degli anni Cinquanta che era stata deprezzata perché considerata decorativa e poco significativa. Le composizioni presentate dalla Bad Painting sono generalmente squilibrate, formalmente eclettiche, sovente ispirate alla pornografia, e realizzate rapidamente attraverso l’uso di colori violenti e dissonanti. Nei primi anni Ottanta la Bad Painting diventa una vera e propria corrente che ingloba artisti che in pochi anni si affermano a livello internazionale come Julian Schnabel, David Salle, e Eric Fischl. Ben presto, le mostre “A New Spirit in Painting” (Londra 1981) e “Zeitgeist” (Berlino 1982), che raggruppano lavori americani ed europei, sottolineano il denominatore comune del ritorno alla figurazione tra la transavanguardia italiana, i neoespressionisti tedeschi e la Figuration libre francese e la nuova pittura americana.
David Salle ed Eric Fischl, legati al gallerista Leo Castelli, condividono gli studi accanto a John Baldessari. Salle, esperto nell’assemblage fotografico, realizza grandi tele sulle quali si sovrappongono immagini differenti su uno sfondo pittorico sostanzialmente realistico, mentre Fischl rappresenta in modo ironico e con stile realista, la buona società attraverso immagini che spesso si ispirano alla pornografia. Julian Schnabel è colui che tra loro raggiunge la maggiore notorietà: nel 1979 realizza la sua prima personale a New York, alla Mary Boone Gallery; nel 1980 partecipa alla Biennale di Venezia e nell’anno seguente alla mostra presso lo Stedelijk Museum ad Amsterdam. Al 1978 risalgono le Plate paintings realizzate ricoprendo la superficie del quadro con frammenti di piatti rotti su cui è dato il colore, che risentono delle ceramiche di Gaudì, artista conosciuto a Barcellona, dal quale è profondamente colpito. Nel corso degli anni Ottanta Schnabel elabora un linguaggio artistico ricco di riferimenti alla società e all’arte contemporanea. Su superfici di grande formato (tende, vecchie tele di sacco, teloni di camion, carte geografiche) inserisce scritte, simboli sacri ed erotici, attraverso l’utilizzo di un’enorme quantità di materiale e di differenti tecniche di rappresentazione. L’impressione di grande violenza che scaturisce dall’opera di Schnabel, non ha nulla di soggettivo, secondo la sua visione, ma scaturisce dall’aspetto stesso del mondo. Dal 1983 conosce Basquiat, al quale dedicherà un film nel 1996, e si cimenta, per un breve periodo, con la bomboletta spray e i graffiti.
L’high tech

Shard London Bridge (The Shard - la scheggia), Londra
Il dibattito culturale degli anni ‘70 ha messo definitivamente in crisi il paradigma moderno che, a partire dagli anni ‘20, in qualche misura aveva costituito il comune denominatore di esperienze quanto mai varie, ma accomunate dalla frequentazione di una lingua di diffusione internazionale. La moltiplicazione dei linguaggi e la frammentazione dei comportamenti, rendono assai difficile il tentativo di classificare entro quadri precisi la produzione dei protagonisti dell’architettura contemporanea. Tra le numerose tendenze architettoniche degli ultimi decenni del secolo l’high-tech è forse quella che meglio definisce gli anni ‘80. L’espressione, coniata da Buchanan nel 1983, non individua una corrente formalmente unitaria, bensì un approccio progettuale che si traduce nell’enfatica manifestazione del procedimento costruttivo. Le radici di questo atteggiamento affondano nelle esperienze produttiviste degli anni ‘60 e ‘70, dalle cupole geodetiche di Fuller alle pionieristiche tensostrutture di Frei. Il Centre Pompidou a Parigi di Renzo Piano e Richard Rogers (1971-77) può essere considerato il manifesto di questa cultura tecnologica. In questo edifico le strutture portanti e le infrastrutture impiantistiche e di collegamento verticale (scale, ascensori) sono spostate dall’interno all’esterno, per assumere, evidenziate maggiormente dall’uso del colore, i connotati espressivi dell’edificio. Nell’ambito di questo indirizzo architettonico vanno inseriti anche Norman Foster e Jean Nouvel. L’opera che consegna Foster alla fama internazionale è il grattacielo della Hong Kong & Shanghai Bank di Hong Kong (1979-80), considerato uno dei riferimenti principali dell’architettura high-tech: enormi pilastri in acciaio sorreggono le grandi travi reticolari cui sono sospesi i piani dell’edificio. La struttura portante è eloquentemente lasciata a vista, sia all’esterno che all’interno, dove i piani sovrapposti degli uffici si affacciano su un grandioso invaso centrale.
Nouvel si impone all’attenzione internazionale con la realizzazione dell’Institut du Monde Arabe a Parigi (1981-87): l’edificio è interamente schermato da un numero elevatissimo di pannelli quadrati che presentano trafori e intagli, memori delle raffinate decorazioni mediorientali. L’effetto di leggerezza e di trasparenza rimane come un comune denominatore della sua ricerca: nel progetto per la Torre infinita alla Défense (Parigi, 1988), la struttura, che dovrebbe raggiungere i 420 metri, è sottoposta ad un progressivo alleggerimento fino a divenire, nella parte più alta, quasi invisibile.
Il cinema americano

Scena del volo in bicicletta, classificata da Empire come la più magica mai realizzata[1] e tutt'oggi logo della Amblin Entertainment
Negli anni ‘80 il cinema americano - pur ricco di grandi artisti - punta sui kolossal o su prodotti sempre più standardizzati. I generi tendono ad essere più mischiati, tramontano i filoni storici (come il western), aumenta il livello di violenza nei film. Il cinema, però, più che in passato, riflette e anticipa, in alcuni casi, quello che sta succedendo nella società: evidenzia i fenomeni di costume. Pensiamo all’impatto di film come Kramer contro Kramer o Gente comune che riflettono le modificazioni della famiglia americana, oppure a un film come Thelma & Louise del 1991 che mostra una nuova presa di coscienza della donna. Per non parlare di tutti quei film che hanno descritto il mondo degli yuppy, realizzati nel corso degli anni ‘80. Accanto a film che mettono in discussione la corruzione dei pubblici poteri (della polizia, in primo luogo), ve n’è tutta una serie che esalta invece gli “eroi della strada” e le loro imprese, in un crescendo di violenza e spettacolarità che rasenta l’astrattezza e la fantasia pura. In realtà i filoni principali sembrano essere quello dei grandi film di fantascienza, quali L’Impero colpisce ancora, Il Ritorno dello Jedi e Blade runner; le commedie, si pensi a Il grande freddo e a Harry ti presento Sally; gli action movie, come ad esempio i fortunatissimi film di Sylvester Stallone con la serie di Rambo e di Rocky.
I film di Spielberg si muovono su più registri: la spettacolarità non è mai fine a sé stessa ma, fondandosi su un uso magistrale del mezzo cinematografico, sottende molti altri contenuti. Regista polivalente, è riuscito a coniugare il racconto fiabesco con il film di fantascienza, come nel caso di quello che è considerato il suo capolavoro, E.T. Ha alternato grandi film d’azione (la serie Indiana Jones) a film di maggiore impegno stilistico e civile (Il colore viola, L’Impero del sole). La sua casa di produzione (la Amblin) è senza ombra di dubbio la più importante di Hollywood: tra le sue realizzazioni ricordiamo la serie Ai confini della realtà o film come Ghostbusters e i Gremlins.
E’ emersa una generazione di nuovi divi, come Danny Aykroyd, Kim Basinger, Kevin Costner, Danny De Vito, Michael Douglas, Jodie Foster, Richard Gere, William Hurt, Eddie Murphy, Michelle Pfeiffer, Arnold Schwarzenegger, Kathleene Turner, Denzel Washington, più scanzonata e meno “impegnata” delle precedenti.
Il cinema francese

Il Cyrano de Bergerac valse a Gérard Depardieu il premio per la migliore interpretazione maschile. Fu candidato all'Oscar al miglior film straniero.
Nel periodo che va dagli anni ‘70 ad oggi, il cinema francese, con l’ultima stagione degli autori della Nouvelle Vague e una nuova generazioni di registi, recupera un suo pubblico a discapito di quello americano con film di grande successo come, ad esempio Il tempo delle mele.
L’essenziale dell’opera di Eric Rohmer è organizzata in cicli, come negli anni ‘60 e ‘70: Sei racconti morali, negli anni ‘80: Commedie e proverbi (Il bel matrimonio, Le notti della luna piena, Il raggio verde, Pauline alla spiaggia), negli anni ‘90: Racconti delle 4 stagioni (Racconto di primavera, Racconto d’inverno, Un ragazzo… tre ragazze). La tematica ricorrente di Rohmer è l’esplorazione dei giochi dell’amore e dei sentimenti, del caso e del destino della vita di una società borghese, adottando un’attitudine moralista, divertita e ironica. Negli anni ‘80 il regista torna ai principi della Nouvelle Vague da cui era partito, dove il caso nella messa in scena e nelle riprese occupa un posto importante, e dove l’improvvisazione occupa una larga parte.
Claude Chabrol ha una filmografia, quantitativamente, molto impressionante. Il suo sguardo sulla Francia e in particolare su quella dei paesi e delle campagne è certamente uno dei più riusciti. Negli anni ‘80, egli torna al genere nel quale aveva dato le migliori prove, il giallo; spesso ambientato in provincia (I fantasmi del cappellaio, Una morte di troppo, Un affare di donne), gli permette di procedere ad un’analisi, sociale e politica, feroce di questa borghesia, comunque raffigurata con humour graffiante.
Maurice Pialat filma i rapporti umani in situazioni estreme, di crisi, di conflitto - generazionale, religioso, di coppia - trattando i problemi dell’esclusione, della marginalità, della malattia (Ai nostri amori, Police, Sotto il sole di Satana).
Jean-Jacques Beineix esordisce, a sorpresa con un grande successo di pubblico, con un cinema al limite del manierismo e dall’estetismo indiscutibilmente gelido con Diva, confermandosi poi con il romanticismo cinico del cult-movie, per i giovani, Betty Blue.
Il cinema annovera poche donne tra i registi: si ricordano Agnès Varda “la nonna della Nouvelle Vague” come lei stessa ama chiamarsi (Senza tetto né legge), e soprattutto tra le più giovani, Coline Serreau che, seguendo una corrente femminista post ‘68, s’interroga sulla coppia e sulle relazioni nel mondo del lavoro con ironia e humour in Tre uomini e una culla e La crisi!.
Nuovi e meno nuovi divi del cinema francese sono al centro dell’attenzione internazionale. Tra gli altri, Isabelle Adjani, Fanny Ardant, Daniel Auteil, Emmanuelle Beart, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Gerard Depardieu, Christopher Lambert, Sophie Marceau, Michel Piccoli, Sandrine Bonnaire.
Il cinema italiano

Nanni Moretti interpreta il cinico ministro Cesare Botero in Il portaborse, film che gli vaalse il David di Donatello come migliore attore protagonista
Come in Francia, anche in Italia sono soprattutto i registi affermatisi nel periodo precedente agli anni Settanta a produrre i film di maggiore rilievo. Possiamo ricordare alcuni nomi. Innanzi tutto i “grandi vecchi”: Federico Fellini con E la nave va e Ginger e Fred, e Michelangelo Antonioni con Identificazione di una donna.
Negli anni Settanta e Ottanta il panorama del cinema italiano, benché si facciano sentire gli effetti della crisi (calo di pubblico per le pellicole italiane, chiusura delle sale ecc.), appare quanto mai vario e ricco: da Sergio Leone (C’era una volta in America) a Ermanno Olmi (Lunga vita alla signora!; La leggenda del santo bevitore), da Marco Ferreri (Storie di ordinaria follia) ai fratelli Taviani (La notte di S. Lorenzo; Kaos), a Ettore Scola (La terrazza). Il cinema italiano coglie inoltre molti riconoscimenti internazionali (la Palma d’oro a Olmi e ai Taviani, gli Oscar a L’Ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci e quello, come miglior film straniero, a Nuovo cinema Paradiso di Tornatore).
E’ il tradizionale filone della commedia all’italiana che perdere colpi, malgrado i film di autori quali Mario Monicelli (Il marchese del Grillo). Scompare nei primi anni del decennio il cinema medio che lascia il posto a opere dove prevale la volgarità o la ripetizione di moduli narrativi di tipo televisivo, e interpretate da attori affermatisi in TV. Tuttavia, dalla seconda metà degli anni Ottanta, è apparsa una nuova leva di registi, molto compatta dal punto di vista generazionale (Francesca Archibugi, Marco Martone, Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Marco Risi, Gabriele Salvatores), che ha realizzato molti buoni film, ma che non in tutte le occasioni è riuscita ad uscire da un’ottica minimalista sulla realtà. Negli stessi anni, inoltre, sono emersi nuovi comici di talento come Carlo Verdone, Massimo Troisi e Roberto Benigni, che si sono imposti con riusciti e divertenti film, riproponendo la tradizione del cinema comico italiano.
Il cinema italiano ha sempre avuto tra i suoi punti di forza lo stretto rapporto con la storia della società italiana. Negli anni Settanta aveva riflettuto la forte ondata di politicizzazione che stava investendo il paese: di fronte alle mutazioni politiche ed economiche degli anni Ottanta, questo rapporto sembra, per molti aspetti, perduto. Fanno eccezione nuovi talenti come Gianni Amelio (Colpire al cuore, un film molto coraggioso che affronta il tema del terrorismo; Porte aperte) e Nanni Moretti con La messa è finita, Bianca e Palombella Rossa che lo fanno affermare come uno dei registi più talentuosi del nostro cinema, conosciuto e apprezzato anche all’estero. Nei suoi film, con uno stile frammentario (come la realtà dopo la fine della grandi visioni del mondo), continua l’analisi delle disillusioni di una generazione, quella dei ventenni del ‘68 ora cresciuta, che dopo le utopie e le ansie di rinnovamento è costretta a confrontarsi e a piegarsi verso una realtà sempre più inafferrabile ed estranea.
Il cinema d’autore europeo

Pedro Almodóvar alla Mostra del cinema di Venezia del 1988
Gli anni Ottanta vedono l’affermarsi in Europa di alcuni grandi registi. Come Nanni Moretti rappresenta il cinema italiano d’autore, si può affermare che Pedro Almodovar rappresenta il cinema spagnolo: nettamente avanguardista e anticonformista. Dagli anni ‘80, attraverso la raffigurazione dei melodrammi moderni, Almodovar mette in scena le nuove libertà della società spagnola del dopo Franco: droga, adulterio, perversioni sessuali, omosessualità. I temi della trasgressione sono affrontati senza provocazione, la legge del desiderio e delle pulsioni regna, l’omosessualità per esempio, onnipresente nella filmografia di Almodovar, si mostra con naturalezza, evidenza e anche sensualità. Un altro tema ricorrente è la violenza dei sentimenti alimentata da una sessualità intensa. Il cinema di Almodovar è barocco e colorato. Dai suoi esordi, il cineasta fa delle proposte estetiche nuove. Molto legato e influenzato dalla pop art e dalla pubblicità, Almodovar attribuisce un ruolo preponderante a colori, decori, accessori dei vestiti e degli abiti di scena; infatti per ognuno dei suoi film ha fatto ricorso alla partecipazione di specialisti in pittura, allestimenti scenici e ad artisti. Fra i suoi film si ricordano La legge del desiderio, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Legami!.
Dalla Germania si afferma la figura di Wim Wenders. Profondamente influenzato dal cinema e dalla cultura americana, il suo cinema, soprattutto nei primi anni, affronta i temi della solitudine, della desolazione, del viaggio alla ricerca di più profondi significati esistenziali. In questo quadro rientrano opere come Nel corso del tempo (1977), L’amico americano (1977). Successivamente il suo sguardo si fa meno pessimista. Ha realizzato film anche a Hollywood: Hammet - Indagine a Chinatown, (1983), e uno dei migliori tra i suoi, in cui ha raccontato questa difficile esperienza Lo stato delle cose (1982). Coglie i suoi maggiori successi, anche di pubblico, con Paris Texas (1984) e Il cielo sopra Berlino (1987).
Nato a Parigi ma formatosi in Svizzera, dove risiede, Jean-Luc Godard rappresenta l’evoluzione migliore del regista-autore cinéphile che fece la sua comparsa con i registi francesi della Nouvelle Vague, negli anni Sessanta, da cui di fatto si staccò presto, soprattutto a causa della visione sobriamente politica dell’arte in generale e della sperimentazione del mezzo cinema in particolare. Il cinema di Godard denuncia con piglio coraggioso e modernista un’arte spesso asservita alle leggi del commercio: molti suoi lavori sono riflessioni sul cinema o rappresentazioni di esso (Passion, 1982, Grandezza e decadenza di una piccola azienda di cinema, 1986, o Incontro con Woody Allen, un documentario-intervista del 1986). Egli percorre le vie più innovative ed espressive delle possibilità del linguaggio cinematografico: le scomposizioni della narrazione, il rapporto “creativo” con il tempo (che il cinema può restituirci -miracolosamente- senza la sua inesorabile consequenzialità), la non linearità, inoltre la contaminazione dei linguaggi espressivi usati costituiscono di volta in volta film-opera d’arte, leggibili a più livelli, ricchi di citazioni, didascalie, che sovrappongono i sensi e stimolano la comprensione dello spettatore attraverso l’immagine. Più volte osteggiato da produttori e finanziatori, Godard ha sempre ricercato le vie della collaborazione e dell’autoproduzione.
Dall’Inghilterra emerge il talento visionario di Peter Greenaway che, prima di diventare un noto regista, ha modo di lavorare come montatore al Central Office Information presso il prestigioso British Film Institute. L’enorme materiale documentario visionato va a costituire “la materia” delle forme dell’espressione dell’artista. Così ogni lavoro di Greenway diventa un’ipotesi interpretativa di una realtà riorganizzata dall’artista, piegata ai suoi motivi e alle sue istanze estetiche. Dai primi cortometraggi (Water, 1975, un montaggio di riprese di acqua realizzate nei laghi di una regione inglese) ai film-documentario (The Falls, 1980, inchiesta esoterico-scentifica su una strana malattia genetico-onomastica; Four American composero, realizzata per Channel 4 nel 1983,) fino al recente capolavoro I racconti del cuscino (The pillow Book), 1996, i punti focali della sua poetica sono chiari: concezione grafico-pittorica della composizione dell’inquadratura, un sistema formale preciso, estrema attenzione alla commistione di immagine e musica, di suono e parola scritta, insomma una decostruzione del cinema che lo porta a una ricostruzione che utilizza l’immagine come vocabolo da riorganizzare secondo interpretazioni linguistiche disparate, talvolta concettuali, talvolta un po’ intellettualistiche. Da qui l’interesse per i numeri, la serialità, (Giochi nell’acqua, 1988), gli enigmi (I misteri del Giardino di Compton House) i lati oscuri e organicamente morbosi, come il cannibalismo affiancato alla composizione iconografica in Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante, 1989, o il fatto significativo che in ogni suo film ci sia un episodio di vomito.
I best seller
Stephen King
Negli anni Ottanta si affermarono in America alcuni autori la cui popolarità travalicò i confini statunitensi, riuscendo a vendere milioni di copie in tutto il mondo. Stephen King rientra a buon diritto in questa categoria, essendo riuscito a vendere oltre 100 milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo. Maestro del thriller e dell’orrore, tra i suoi maggiori successi vanno ricordati Shining, It, Misery e la Metà oscura. Quasi tutti i suoi libri sono divenuti anche dei successi sul grande schermo. Il fantastico è stato fonte di grande ispirazione anche per un altro popolarissimo scrittore americano, Michael Crichton che ha riscosso un enorme successo con La vita elettronica e, soprattutto, con Jurassic Park. Anche Tom Clancy è riuscito a mietere grandi successi commerciali. Acceso militarista, ha scritto Caccia a Ottobre Rosso, Pericolo chiaro e imminente e Giochi di guerra. Un altro romanziere americano, Tom Wolfe, ha scalato le vette delle classifiche con libri come La stoffa giusta, Il falò delle vanità e La nuova America. Poco convenzionali ma con un vasto seguito di pubblico sono stati i romanzi di John Irving come Il mondo secondo Garp e Hotel New Hampshire.
In Inghilterra, grande successo internazionale hanno avuto i romanzi di spionaggio di John Le Carré, assai precisi e puntuali nel tratteggiare i meccanismi della politica internazionale, grazie anche alle esperienze dirette dell’autore. Il suo personaggio principale, la spia George Smiley, piccolo di statura, robusto e con gli occhiali, è stato il protagonista di romanzi come La talpa, Tutti gli uomini di Smiley, La tamburina e La casa Russia.
Lo scrittore condannato: Rushdie

Salman Rushdie
Quando nel 1989 Salman Rushdie, lo scrittore inglese di origine indiana, dà alle stampe il romanzo I versetti satanici è un autore già noto, per I figli della mezzanotte (1981), ispirato alla storia dell’India nel ventesimo secolo. Ma il nuovo romanzo ha tra i suoi personaggi la figura di Maometto e il riferimento “blasfemo” scatena l’ira del leader dell’Iran, l’ayatollah Khomeini, che chiede “giustizia”, pronunciando una condanna (fatwa) contro Rushdie. Invita i credenti a punire lui e coloro che hanno reso possibile la pubblicazione di una tale opera (l’editore del libro) e promette una ricompensa di tre milioni di dollari per chi eseguirà la sentenza emanata contro lo scrittore. Alcune persone legate alla pubblicazione del libro subiscono da allora attentati ed intimidazioni e Rushdie, è costretto a non apparire più in pubblico, a tenere segreti la sua residenza e i suoi spostamenti, ad essere costantemente scortato da uomini del servizio segreto britannico.
Lo sdegno per la condanna a morte, emanata addirittura da un governo che si identifica con una gerarchia religiosa, è unanime almeno in Occidente, e il caso Rushdie innesca un grande dibattito sulla libertà della cultura e sul ruolo della letteratura, quando essa invade altri campi e può offendere il sentimento religioso dei credenti o le altre culture. La conclusione cui arriva questa discussione è che non sia possibile prevaricare la libertà di espressione e di parola dell’individuo, tanto più rispetto a un caso come quello dei Versetti satanici: un’opera letteraria e non un pamphlet politico antislamico. Nei paesi dove prendono piede movimenti islamici estremisti (come in Algeria ed in Egitto), l’assassinio di molti intellettuali (giornalisti, scrittori, ecc.) induce ad inquadrare la vicenda che vede coinvolto Rushdie in un quadro più generale, nel tentativo di combattere il ritorno di inaccettabili forme di fanatismo e intolleranza. La notizia che il governo iraniano avrebbe ritirato la fatwa sullo scrittore britannico, in seguito all’elezione del moderato Khatami alla presidenza dell’Iran, è stata smentita da alcuni autorevoli esponenti della gerarchia islamica iraniana. Agli occhi di molti estremisti, Rushdie appare ancora oggi un eretico traditore della sua religione.
La letteratura italiana

Umberto Eco
Gli anni Ottanta in Italia, vedono la scomparsa di alcuni dei principali autori che avevano contraddistinto la letteratura italiana fin dal secondo dopoguerra. Sono, infatti, deceduti Italo Calvino, Elsa Morante e Primo Levi, che si era suicidato poco dopo avere dato alle stampe I sommersi e i salvati, amara riflessione sul rapporto storico con la sua esperienza di vittima della persecuzione e del genocidio perpetrati dai nazisti. Leonardo Sciascia è morto nel 1989, dopo essere stato, negli ultimi anni, molto attivo con interventi aspramente polemici sul tema della mafia.
Nel corso del decennio non si sono affermate tendenze dominanti o particolarmente rappresentative. Vanno ricordate alcune esperienze importanti, come le riflessioni sul mondo industriale de Le mosche del capitale di Paolo Volponi, libro dedicato ad Adriano Olivetti, l’imprenditore italiano più atipico del secondo dopoguerra, assai attento al valore costruttivo dell’utopia. Singole opere vanno ricordate, come Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalini, il cui stile assai personale è ricco di spunti barocchi ed espressionistici, oltre al vero e proprio caso letterario rappresentato da Umberto Eco e il suo Il nome della rosa.
Nel nome di Eco

Sean Connery e Christian Slater nel film "Il nome della rosa" di Annaud
Quando nel 1980 appare il libro di Umberto Eco, Il nome della rosa, nessuno, nemmeno lo stesso autore, si aspetta l’enorme popolarità che incontra il romanzo. Vincitore del premio Strega (1981), Il nome della rosa nel giro di pochi mesi diventa un best-seller in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Per la prima volta da anni un’opera letteraria italiana ottiene un grande successo di vendite ovunque, tanto che dal libro è stato tratto anche un film, realizzato da Jean Jacques Annaud e interpretato da Sean Connery e Murray Abraham (1986).
Nato come divertissement, Il nome della rosa è costruito con grande originalità sulla base di un ricco apparato filologico e culturale, frutto degli studi “seri” dell’autore. Ambientato nell’Europa del Trecento, racconta di due monaci francescani, Guglielmo di Baskerville e il suo aiutante, il novizio Adso, che, giunti in un convento benedettino francese (dove francescani benedettini e delegati pontifici devono discutere importanti questioni teologiche), si trovano ad indagare su alcuni inesplicabili delitti. Tutta la vicenda ruota attorno alla misteriosa biblioteca del convento, in cui sono conservati testi dell’antichità che un diabolico frate vuole tenere nascosti perché pericolosi per la fede cattolica.
Umberto Eco è una figura eclettica del panorama culturale italiano degli ultimi anni. Semiologo, professore presso l’Università di Bologna (presso la quale ha promosso la fondazione del DAMS), ha pubblicato opere di saggistica (come, ad esempio, il noto Apocalittici e integrati, del 1964) e romanzi; oltre a Il nome della rosa, infatti, ha scritto Il pendolo di Foucault (1989), L’isola del giorno prima (1994) e l’ultima fatica Baudolino (2000).
Scienza e Tecnologia
Gli Shuttle

Lancio dello Space Shuttle Atlantis per la missione STS-120
La prima missione della navicella spaziale americana Shuttle, nel 1981, ha aperto una nuova pagina nella storia delle esplorazioni spaziali. Negli anni ‘80, i progressi nel volo spaziale furono in primo luogo legati alle iniziative degli Stati Uniti. In progetto fino dai primi anni Settanta, lo Space Shuttle (navetta spaziale) venne realizzato alla fine di quel decennio. Si tratta di un sistema di trasporto spaziale fondato sul reimpiego del velivolo lanciato in orbita, che, spinto nello spazio con l’ausilio di razzi, può rientrare poi sulla terra con un volo planato come un normale aeroplano. In origine le navette Shuttle erano state pensate come traghetti spaziali verso una grande stazione orbitante che non è stata realizzata. Le missioni degli Shuttle servono invece per mettere in orbita stazioni di lavoro e satelliti. La prima missione (navetta Columbia) si svolse nell’aprile del 1981 e durò due giorni, sei ore e ventuno minuti. Già due anni dopo la Columbia era in grado di mettere in orbita due satelliti per telecomunicazioni. Le successive missioni (navetta Challenger) si svolsero senza problemi fino a tutto il 1985 e permisero di compiere molte altre operazioni nello spazio (anche a fini strettamente commerciali), come il posizionamento del primo laboratorio dell’Agenzia spaziale europea, lo Spacelab (1983). Sotto gli occhi di tutto il mondo, che seguiva l’avvenimento in diretta televisiva, il 28 gennaio 1986 la navetta Challenger esplose 73 secondi dopo il lancio, provocando la morte dei sette membri dell’equipaggio. Il disastro, dovuto a cause tecniche, ebbe come conseguenza un ripensamento del programma spaziale della NASA. Le missioni degli Shuttle (navetta Discovery) ripresero solo nel 1988.
Alla ricerca di altre forme di vita nell’universo

Very Large Array (VLA) a Socorro (Nuovo Messico, USA.
Mai, come negli ultimi anni, l’incontro con altre civiltà esistenti nell’Universo ha sollecitato l’immaginario collettivo, come dimostrano i tanti film, (si pensi a ET di Steven Spielberg, solo per fare un esempio), o i tanti gruppi che cercano o dichiarano di aver stabilito contatti con altri abitatori dello spazio. Dopo lo sbarco dei primi astronauti sulla luna nel 1969, sembra che la prospettiva di esplorare lo spazio divenga una realtà. Vengono ipotizzati scenari fantasmagorici (costruzione di città spaziali in breve tempo, ecc.). In realtà, anche se vengono compiuti molti passi avanti (grazie alle missioni della navetta spaziale Shuttle, alle stazioni orbitanti e ai satelliti), lo sviluppo dei programmi spaziali procede gradualmente, anche con bruschi stop (come quello determinato dall’esplosione dello Shuttle nel 1986). Gli studi di fisica e astronomia, in virtù soprattutto delle sonde spaziali, dei nuovi telescopi potentissimi (come Hubble) e delle nuove tecniche informatiche di elaborazione dei dati, ci hanno permesso di saperne molto di più sull’universo e sui suoi misteri. In tutti i paesi si sono moltiplicati i presunti avvistamenti di visitatori spaziali e sono sorte moltissime associazioni, o vere e proprie sette, dedite alla ricerca del contatto con gli U.F.O. (oggetti volanti non identificati). E’ nata tutta una mitologia sui segreti che USA e URSS manterrebbero a questo proposito, come anche sull’origine extraterrestre della civiltà umana. La cosiddetta “ufologia”, inoltre, aspira, senza molte chance, a diventare una vera e propria branca della scienza. La scienza ufficiale è scettica di fronte a questi fenomeni, ma, a fronte della sempre maggiore conoscenza dell’universo (e dei miliardi di pianeti che conterrebbe), ha ammesso in via teorica, secondo il calcolo delle probabilità, la possibilità che in altri pianeti sia potuto avvenire lo stesso processo che ha portato la vita sulla terra. Ha ammesso quindi che possano esistere altre forme di vita. Per ora, comunque, i messaggi inviati nello spazio non hanno avuto risposta.
Le tecnologie spaziali
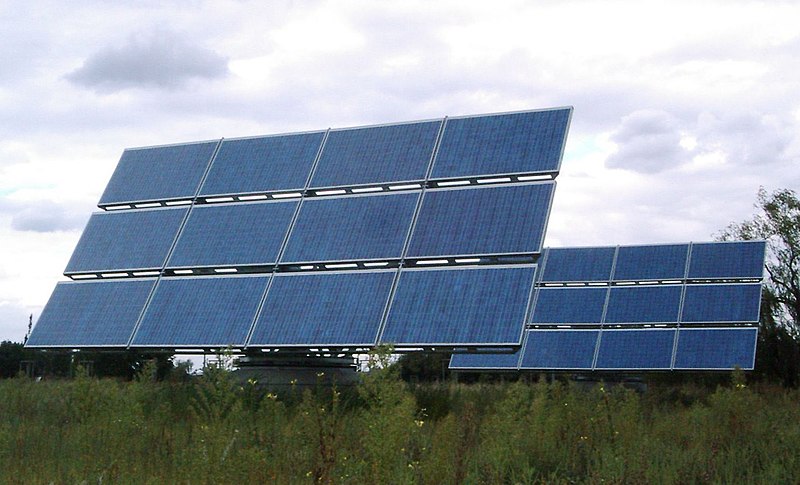
Due pannelli formati ognuno da 12 moduli fotovoltaici montati su supporti a inseguimento solare
L’accelerazione del progresso tecnologico della seconda metà del secolo è stata particolarmente evidente nel campo della missilistica e dell’astronautica. Tali settori, indissolubilmente legati alle ricerche nel campo degli armamenti, hanno costituito un esempio tipico del modello di sviluppo tecnologico postbellico. Quest’ultimo è stato trainato principalmente dalla concentrazione di enormi investimenti pubblici, motivati da esigenze militari, in imprese tecnologiche di punta, che sfruttano gli avanzamenti dell’intero sistema industriale e provocano, a loro volta, vasti effetti di ricaduta tecnologica sull’economia civile. Nel caso della tecnologia spaziale, questi effetti hanno coperto uno spettro vastissimo, compreso tra le trasmissioni televisive satellitari e l’introduzione di nuove diagnostiche mediche. Lo sviluppo della missilistica e dell’astronautica ha prodotto notevoli effetti di ricaduta tecnologica, in settori estremamente distanti. Una delle conseguenze più vaste fu quella dell’affinamento della “scienza dell’affidabilità”, che aveva mosso i primi passi subito prima della guerra in campo aeronautico. L’estrema complessità dei sistemi astronautici, e soprattutto dei nuovi congegni elettronici, rese, infatti, necessario sviluppare modelli matematici e strategie di collaudo, senza le quali le imprese spaziali non sarebbero state possibili, o avrebbero avuto costi materiali e umani molto più alti. Accanto a questo beneficio di ricaduta generale, vi furono effetti più specifici, quali l’introduzione dell’integrazione su larga scala dei componenti elettronici, che rese possibile la miniaturizzazione, lo sviluppo di apparecchiature mediche di monitoraggio delle condizioni psicofisiche dei pazienti, originariamente nate per controllare a distanza le condizioni degli astronauti, i pannelli per l’uso dell’energia solare, utilizzati dai veicoli spaziali e dai satelliti e ora disponibili a terra. A tali effetti indiretti della corsa nello spazio si sono più di recente aggiunti i frutti di una ricerca mirata, realizzata attraverso esperimenti condotti a bordo di navicelle orbitanti, e con apparecchiature scientifiche portate in orbita tramite razzo vettore o, dopo il 1981, dalle navette spaziali statunitensi. Uno degli esempi più importanti è stato il trasporto e la messa in opera del telescopio spaziale “Hubble” da parte della navetta spaziale Discovery nel 1990.
La Mir

La stazione spaziale russa MIR
L’Unione Sovietica ha continuato a sviluppare la propria avventura spaziale, partita dagli anni Settanta, puntando soprattutto sulle stazioni spaziali, dalle Salijut (la prima missione è del 1971) fino alla Mir (1986), nella quale i cosmonauti Titov e Manarov stabilirono il record di permanenza nello spazio (336 giorni). Nel 1983 i sovietici, con la missione Soyuz T-9, effettuarono la prima costruzione nello spazio agganciandosi con la stazione Salijut 7; nel 1986 fu messa in orbita la Mir, una stazione con ben sei porte d’attracco: la vita permanente nello spazio diventò sempre più una realtà. La Mir è collegata con la base a terra dal vettore spaziale “Soyuz” TM che funziona come un traghetto spaziale. Fin dall’inizio si sono verificati problemi nelle manovre di attracco e di sganciamento; nel 1988 a causa di alcuni problemi, poi risolti, la Mir rischiò di essere abbandonata a causa della mancanza di aria provocata dal cattivo funzionamento di alcuni strumenti e dagli errori compiuti dal personale di bordo. La stazione ha effettuato anche delle osservazioni astronomiche, ricerche sui raggi X e su quelli ultravioletti, grazie all’aggancio di un modulo astrofisico. Negli anni ‘90 la Mir ha ospitato anche degli astronauti statunitensi nell’ambito del progetto e della realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale, (ISS); quest’ultima dovrebbe sostituirla quando la Mir cesserà di funzionare.
Il deterrente nucleare

Centrale nucleare di Cofrentes (Spagna)
L’uso del nucleare si è sviluppato, come è noto, in relazione alle necessità belliche nel corso della seconda guerra mondiale. Il bombardamento atomico delle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, nel 1945, ha simboleggiato l’ingresso in una nuova era della storia dell’uomo: l’era nucleare, appunto. Da allora l’utilizzazione di questo tipo di energia, fondata sulla fissione nucleare, è stata introdotta anche in ambito civile. Di fronte al pericolo dell’esaurimento, in un futuro non lontanissimo, di altre risorse energetiche (come il petrolio) è sembrato che l’atomo potesse sostituirsi ad esse. E’ solo a partire dagli anni ‘70 che consistenti minoranze di ambientalisti e di scienziati hanno cominciato a denunciare i rischi connessi all’atomo. L’incidente nella centrale nucleare americana di Three Mile Island e, soprattutto, quello nella centrale sovietica di Chernobyl in Ucraina (con la vastissima contaminazione dell’area circostante e la nube radioattiva in movimento nei cieli d’Europa) hanno allarmato l’opinione pubblica mondiale che da allora è divenuta molto più sensibile verso questi temi. La produzione di energia nucleare tramite la fusione dell’atomo (possibilità solo teorica, dato che sarebbero necessarie temperature così alte per ottenerla da richiedere una tecnologia dai costi imprevedibili) è stata una delle strade battute per ovviare a questa situazione. La fusione fredda, cioè ottenuta chimicamente, che due scienziati americani dell’Università di Salt Lake City hanno annunciato di aver raggiunto nel 1989, è ancora oggetto di controversie e non ha quindi trovato applicazioni produttivo-tecnologiche. Rimane il problema, di fronte allo sviluppo economico di un numero sempre maggiore di nazioni del mondo, della continua crescita della domanda energetica. Essa non può essere attualmente soddisfatta se non con il nucleare o con altri modi di produrre energia dannosi o rischiosi per l’ambiente. Per questo si cerca di sfruttare nuove fonti di energia (“rinnovabili”), come il sole o l’acqua, con risultati, però, fino ad ora non ancora pienamente soddisfacenti.
Il nucleare “civile”
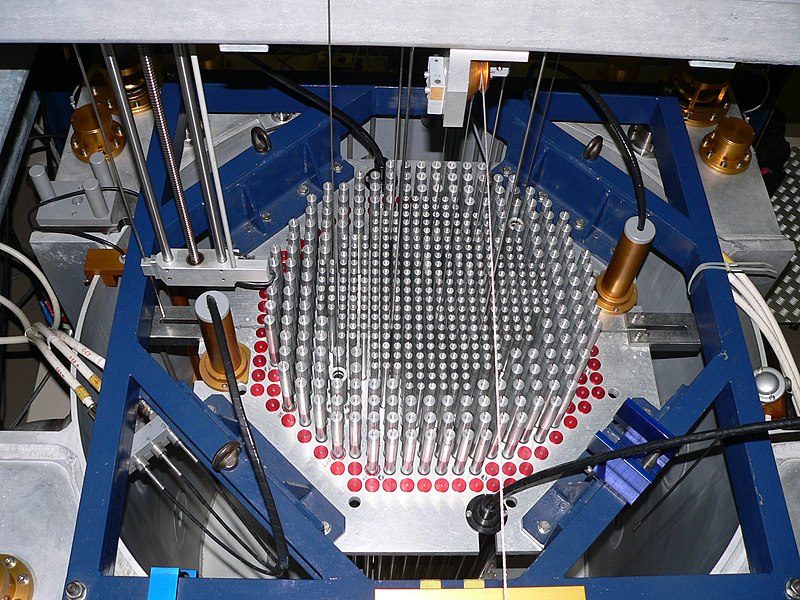
Il nocciolo del minireattore di ricerca CROCUS, Svizzera
L’uso del nucleare si è sviluppato, come è noto, in relazione alle necessità belliche nel corso della seconda guerra mondiale. Il bombardamento atomico delle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, nel 1945, ha simboleggiato l’ingresso in una nuova era della storia dell’uomo: l’era nucleare, appunto. Da allora l’utilizzazione di questo tipo di energia, fondata sulla fissione nucleare, è stata introdotta anche in ambito civile. Di fronte al pericolo dell’esaurimento, in un futuro non lontanissimo, di altre risorse energetiche (come il petrolio) è sembrato che l’atomo potesse sostituirsi ad esse. E’ solo a partire dagli anni ‘70 che consistenti minoranze di ambientalisti e di scienziati hanno cominciato a denunciare i rischi connessi all’atomo. L’incidente nella centrale nucleare americana di Three Mile Island e, soprattutto, quello nella centrale sovietica di Chernobyl in Ucraina (con la vastissima contaminazione dell’area circostante e la nube radioattiva in movimento nei cieli d’Europa) hanno allarmato l’opinione pubblica mondiale che da allora è divenuta molto più sensibile verso questi temi. La produzione di energia nucleare tramite la fusione dell’atomo (possibilità solo teorica, dato che sarebbero necessarie temperature così alte per ottenerla da richiedere una tecnologia dai costi imprevedibili) è stata una delle strade battute per ovviare a questa situazione. La fusione fredda, cioè ottenuta chimicamente, che due scienziati americani dell’Università di Salt Lake City hanno annunciato di aver raggiunto nel 1989, è ancora oggetto di controversie e non ha quindi trovato applicazioni produttivo-tecnologiche. Rimane il problema, di fronte allo sviluppo economico di un numero sempre maggiore di nazioni del mondo, della continua crescita della domanda energetica. Essa non può essere attualmente soddisfatta se non con il nucleare o con altri modi di produrre energia dannosi o rischiosi per l’ambiente. Per questo si cerca di sfruttare nuove fonti di energia (“rinnovabili”), come il sole o l’acqua, con risultati, però, fino ad ora non ancora pienamente soddisfacenti.
Alta velocità ferroviaria

China Railways CRH3
Nei primissimi anni ‘80 il Giappone e la Francia misero in circolazione una nuova generazione di treni, dotati di un’avanzata tecnologia che permetteva loro di raggiungere alte velocità. Va specificato che l’utilizzo di questi particolari convogli ferroviari è conseguente a due fattori: la presenza di una moderna rete di infrastrutture ferroviarie - come in Giappone - e, soprattutto, alla conformazione del territorio - come nel caso della Francia - e, dunque, al percorso tracciato dai binari. Il modello più famoso è senz’altro il Train à Grande Vitesse (TGV o in italiano “treno ad alta velocità”, TAV) transalpino: entrato in servizio sulla linea Parigi-Lione, il treno percorreva gli oltre 500 chilometri di distanza, di percorso dolcemente ondulato ma quasi sempre rettilineo, privo di passaggi a livello e gallerie, in 2 ore all’incredibile media di 250 km/h. Estremamente sicuro, confortevole, con corse così frequenti che sembrava fosse una metropolitana extra urbana, il TGV ha fatto dimezzare il traffico aereo tra le due città e nel corso del decennio seguente ha cominciato a correre su altre linee ferroviarie permettendo comodi spostamenti con qualsiasi condizione di tempo. Verso la fine del decennio anche altri paesi europei hanno sviluppato e commercializzato treni super veloci: in Italia, ad esempio, è stato attivato il cosiddetto “Pendolino”, un treno che riesce a inclinarsi di fianco al momento delle curve disegnate dal tracciato, mantenendo un’alta velocità anche nei percorsi più “movimentati”. La presenza di infrastrutture obsolete e superate ne hanno però limitato il pieno sviluppo; il treno pur potendo arrivare, e mantenere, a una velocità standard di oltre 250 km/h non può nella realtà quasi mai raggiungerla. Negli anni ‘90 sono state decise e messe in cantiere faraoniche opere, talvolta con grave detrimento di alcuni paesaggi naturalistici bellissimi, per costruire ex novo, o talora modificare, linee ferroviarie adatte al suo utilizzo.
L’Eurotunnel

Terminal del tunnel dal lato inglese
Fin dai tempi di Napoleone, l’uomo aveva pensato di unire l’Inghilterra alla Francia: nel 1986 i due paesi sottoscrivono un accordo che prevede la creazione di un consorzio per la costruzione e la gestione del tunnel sotto la Manica: i protagonisti firmatari di tale consorzio, Eurotunnel, sono il presidente socialista Mitterrand e il primo ministro Thatcher, una convinta liberista. Infatti, i due stati affrontarono delle lunghe trattative per la ripartizione dei costi dell’opera che si preannunciavano assai alti: alla fine dei lavori, iniziati nel 1988, il costo della costruzione è stato valutato circa 25.000 miliardi di lire. Il tunnel è lungo ben 50 chilometri, di cui 37 sotto il mare; rispetto al fondale marino il tunnel scorre a circa 50 metri sotto terra. A questa immensa opera partecipano circa 12.000 lavoratori: la costruzione finale prevede tre tunnel, due ferroviari e cioè uno per ogni senso di marcia, ed il terzo per i servizi. Grazie ad esso, oggi è possibile viaggiare comodamente tra le due capitali in sole tre ore, che potrebbero diminuire ulteriormente quando l’Inghilterra costruirà linee ferroviarie ad alta velocità, oggi non presenti sull’isola. Infatti il treno, della serie dei TGV francesi, compie il percorso francese a forte velocità mentre rallenta vistosamente una volta raggiunta l’Inghilterra. Tale opzione ha incontrato il successo dei cittadini di entrambe le sponde della Manica: il cliente apprezza il fatto di ritrovarsi dall’altra parte in così poco tempo e in presenza di qualunque condizione atmosferica. L’inaugurazione è avvenuta nel 1994.
L’ultima peste: l’AIDS
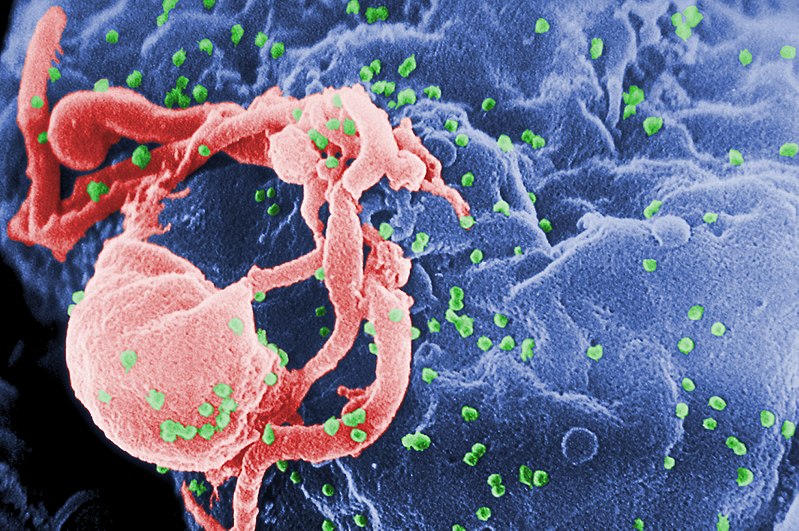
Il virus dell'AIDS visto al microscopio a scansione
Il 5 giugno 1981 il dottor Michael Gottlieb riferisce al Center of Disease Control di Los Angeles di cinque casi di morte di omosessuali per una rara polmonite. Gottlieb attribuisce le morti ad una immunodeficienza acquisita che avrebbe consentito l’insorgere di infezioni letali. L’allarme fa il giro del mondo, perché viene subito messa in relazione a casi analoghi altrove. In soli tre mesi negli Stati Uniti vengono segnalati altri 159 casi che riguardano omosessuali, tossicodipendenti ed emofiliaci. Si comprende subito che la nuova malattia colpisce attraverso le trasfusioni di sangue o i rapporti sessuali, anche tra persone di sesso diverso. La sindrome, inizialmente chiamata Gay Related Immunodeficiency, viene ribattezzata, dal ricercatore Bruce Voeller, Aquired Immuno Deficiency Syndrome, mentre nei paesi di lingua francofona è conosciuta come SIDA.
Si mettono al lavoro due équipe mediche: quella statunitense del dottor Robert Gallo e quella parigina dell’Istituto Pasteur, presieduta dal virologo Luc Montagnier. Il virus responsabile del contagio, l’HIV (Human Immunodeficiency Virus), viene isolato nel 1984. Negli ultimi tre anni aveva colpito negli Stati Uniti 4.920 persone, 2.218 delle quali erano morte. Il 75% dei malati che lo avevano contratto prima del 1992, aveva perso la vita. L’allarme nel mondo è enorme: anche se isolato, il virus non lo si può sconfiggere né prevenire con un vaccino. A rischio sono praticamente tutti i comportamenti sessuali non protetti dal profilattico, nonché tutti gli scambi di sangue. Iniziano vibranti campagne di prevenzione e informazione che vanno dalla distribuzione gratuita di siringhe per i tossicodipendenti a quella di preservativi. L’epidemia si diffonde a macchia d’olio; l’Aids viene definito “la peste del ventesimo secolo”. Una volta contratto il virus, il soggetto interessato viene considerato sieropositivo. Non manifesta alcun sintomo e questa situazione può durare fino ad un numero imprecisato di anni. Lo stato conclamato della malattia si manifesta in un secondo momento e porta immediatamente alla morte attraverso il manifestarsi delle più diverse patologie. Di Aids muore nel 1985 il celebre attore Rock Hudson: è la prima vittima “eccellente” e il segno che il virus colpisce a 360 gradi. La ricerca va avanti incessantemente ma i risultati non sono ancora tali da rassicurare l’opinione pubblica. Il farmaco che offre i risultati migliori è l’Azt, che non agisce tuttavia sul virus, potendone solo rallentare gli effetti.
Un’antica piaga

Gruppo di discussione sul pericolo dell'AIDS, Angola
I costi sociali dell’esplosione demografica si sono manifestati in misura crescente a partire dagli anni Settanta, quando una serie di carestie provocate dalla siccità particolarmente grave, seguita allo sfruttamento eccessivo delle terre coltivabili, ha avuto conseguenze tragiche in molti paesi poveri, soprattutto in Africa. Ma, anche senza il verificarsi di eventi fuori dell’ordinario, le condizioni alimentari di gran parte della popolazione mondiale sono, comunque, estremamente difficili. Agli inizi degli anni Ottanta, si calcolava che un miliardo di persone vivesse in condizioni di povertà assoluta, e disponesse di una quantità di cibo insufficiente a condurre un’esistenza attiva. La malnutrizione e le difficili condizioni di vita provocano la morte di circa quindici milioni di persone ogni anno, per lo più bambini, e le condizioni vanno peggiorando: tra 1980 e 1992, il reddito pro capite dei paesi dell’Africa subsahariana è passato da 570 a 350 dollari americani, e tali statistiche, oltre tutto, riflettono solo aggregati teorici, non una disponibilità reale. Le condizioni di malnutrizione riflettono tanto la crescita demografica quanto l’asservimento di larghe aree coltivate alla produzione di derrate destinate all’esportazione, causando l’espulsione di popolazione verso i centri urbani, dove essa conduce un’esistenza di assoluta miseria. Il peggioramento delle condizioni di vita, legato alla sovrappopolazione, ha anche portato alla diffusione endemica di gravi malattie come la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), che ha raggiunto in Africa le dimensioni di un vero e proprio flagello. Nei paesi occidentali, la diffusione della sindrome è stata arginata dall’adozione di misure di prevenzione e i malati sono sottoposti a cure che, ultimamente, hanno ottenuto notevole successo nel ritardare l’evoluzione della malattia. Nei paesi poveri, invece, il costo dei farmaci impedisce qualsiasi profilassi, e le condizioni di vita facilitano il contagio. Dei 30 milioni di malati di AIDS del 1998, la stragrande maggioranza abitano nei paesi in via di sviluppo e quasi tutti, allo stato attuale, sono destinati a morire. In Botswana e Zimbabwe, risulta colpito da virus HIV (che provoca l’AIDS) un terzo della popolazione adulta, in Sudafrica e Namibia il 25%. Nelle aree urbane, le percentuali salgono drammaticamente: il 70% delle donne, sottoposte ad analisi nelle città dell’Africa subsahariana, è risultato sieropositivo.
La PCR

Il prototipo di termociclatore contenente il software applicativo integrato nell'hardware (1986)
Nel 1983 Kary Mullis scopre la tecnica della PCR, Polymerase Chain Reaction o Reazione a Catena della Polimerasi. PCR è una tecnica che consente di ottenere miliardi di copie di specifiche sequenze di DNA a partire da una molecola stampo. Con questa tecnica il DNA viene sottoposto a ripetuti cicli di amplificazione, durante i quali il prodotto ottenuto in un ciclo può funzionare da stampo per il ciclo successivo. Partendo quindi da 2 molecole se ne ottengono 4, da 4 a 8, da 8 a 16 e così via. La scoperta di questa tecnica è stata assolutamente rivoluzionaria per la ricerca, infatti, uno dei problemi più rilevanti, sia per la diagnostica clinica, sia per gli studi molecolari è sempre stata la necessità di disporre di quantità sufficienti di DNA per realizzare tutte le analisi necessarie; con questa tecnica invece una goccia di sangue è sufficiente per ottenere un’amplificazione da cui formulare una diagnosi. Pertanto la PCR è ormai entrata nella pratica di routine di tutti i laboratori. Le applicazioni più importanti della PCR riguardano sia la diagnosi prenatale, sia la diagnosi postnatale, di molte malattie genetiche: tra queste la fibrosi cistica, la malattia di Gaucher, l’emofilia, il retinoplastoma. Va ricordato inoltre il suo uso in medicina legale, ad esempio per individuare e identificare i responsabili di azioni delittuose o per le attribuzioni di paternità. Inoltre, nell’ambito degli studi di evoluzione molecolare, l’uso della PCR è utile perché consente di amplificare il DNA di piante e animali recuperati da resine o da porzioni mummificate, in sostanza dei reperti fossili; per fare un esempio chiaro si ricordi la fantastica ricostruzione di tali procedimenti rappresentata nel film Jurassic Park. Kary Mullis, proprio per l’invenzione di questa tecnica, è stato insignito del premio Nobel per la chimica nel 1993.
La rivoluzione informatica

Primo modello di Macintosh
L’ultimo scorcio del ‘900 sarà probabilmente ricordato come l’epoca della “rivoluzione informatica”. Il mutamento ha cambiato non soltanto il mondo del lavoro e quello della comunicazione, ma anche la vita delle persone: il computer è entrato quasi in ogni casa. Il mercato - in continua espansione - è dominato da veri e propri colossi (IBM, Microsoft); le innovazioni sono continue. Nuovi scenari si aprono nella prospettiva dell’“integrazione totale”. In un tempo non troppo lontano buona parte delle attività umane saranno gestite dai calcolatori elettronici. La rivoluzione informatica influenza fortemente il mondo del lavoro. I computer sono capaci di sostituire da soli il lavoro di molti uomini. D’altro canto si richiede a chi presiede i processi industriali di saper dare istruzioni ai calcolatori. Vengono richieste nuove competenze, e chi riesce a diventarne padrone è fortemente agevolato nella carriera. Sono i giovani ad avvantaggiarsi di queste continue innovazioni, grazie alla duttilità e facilità di apprendimento delle regole dell’informatica. Anche l’architettura dei computer si evolve rapidamente. La richiesta di software più complessi, che in parte viene dal mercato e in parte è indotta dalle case produttrici, richiede processori sempre più veloci e macchine sempre più potenti. La memoria dei computer raddoppia ogni diciotto mesi. Le evoluzioni impongono anche il cambio dei linguaggi di programmazione (che vanno dal Basic, inventato nel 1965 dagli americani Kurtz e Kemeny, agli attuali compilatori) e dei sistemi operativi (in quindici anni si è passati da MsDos alle più recenti versioni di Windows). Negli ultimissimi anni perde di importanza quello che si riesce a realizzare con il proprio computer e ne acquista la capacità di sfruttare le risorse che la rete mondiale mette a disposizione degli utenti.
La vera svolta nella storia del computer è il passaggio, avvenuto all’inizio degli anni Ottanta, dal mainframe (l’elaboratore centrale, solitamente di grosse dimensioni, che gestisce le informazioni che gli vengono immesse dai diversi terminali) al personal computer (PC). Si tratta di un calcolatore che per conto proprio riesce a compiere le operazioni di cui l’utente necessita. I personal computer subiscono un incredibile abbattimento dei costi che ne agevola la diffusione. Ad esserne conquistati sono in un primo momento solo gli ambienti di lavoro. Uffici, giornali, imprese, gestiscono attraverso i personal la contabilità, il magazzino, la corrispondenza. L’esplosione delle vendite dei personal è facilitata dalla semplificazione dei software, che grazie all’utilizzo di sistemi operativi ad interfaccia grafica (il più diffuso è Windows) diventano intuitivi e facili da manovrare. Con un computer e il programma giusto si può fare progettazione civile, grafica pubblicitaria, calcolo matematico, impaginazione di giornali e lavoro tipografico. Il computer approda anche nelle abitazioni private. Per i ragazzi diventa uno strumento di gioco, grazie all’infinito numero di videogame disponibili, e di studio (nel mercato si diffondono numerosi programmi didattici). Gli adulti lo usano invece per la scrittura di testi (servendosi dei programmi di word processing) o per svolgere a casa parte del proprio lavoro. I computer dell’ultima generazione sono in grado fra l’altro di captare immagini e leggere suoni (anche dai normali compact disc), nonché di collegarsi attraverso i modem con Internet. Sono cioè macchine multimediali. Il sogno del fondatore della Microsoft, Bill Gates, di vedere “un computer su ogni scrivania” può oggi dirsi realizzato.
La “finestra” sul mondo

Bill Gates a una conferenza Microsoft
Internet, la rete delle reti, vede la luce nel 1983, quando il protocollo TCP/IP (il codice che consente a tutti i computer, anche se dotati di programmi diversi, di comunicare fra loro), brevettato nel 1973 da Vinton Cerf del Dipartimento di ricerca avanzata dell’Università di California, e la rete Arpanet divengono di pubblico dominio. Arpanet è un insieme di piccole reti locali di computer (Lan) collegate tra loro attraverso reti di telecomunicazione (Wan); fino a questa data era rimasto uno strumento essenzialmente militare, volto a salvaguardare le funzioni di comando del sistema di difesa statunitense da un eventuale attacco nucleare sovietico. La sua origine risale alla metà degli anni Sessanta, quando, in seguito alla crisi di Cuba e alla crescente tensione fra USA e URSS, l’Agenzia per i progetti avanzati del Dipartimento di difesa degli Stati Uniti (Arpa) decise che l’unico modo sicuro per garantire l’attività di un centro di comando militare anche dopo un attacco atomico era non prevederne alcuno. Per questo venne ideata Arpanet, una rete di “centri di comando” tutti con lo stesso status e dotati dell’autorità necessaria a originare, trasmettere e ricevere messaggi.
Il 1983 è un anno decisivo per lo sviluppo della rete anche perché vede la nascita del primo PC (Personal Computer) Macintosh della Apple. Questo computer, infatti, ribalta il rapporto uomo-macchina: invece di chiedere all’uomo di entrare nella logica di funzionamento della macchina, è la macchina che si adatta al modo di ragionare dell’uomo. Finalmente l’informatica perde la sua sacralità per diventare uno strumento facile da usare, ed entra, oltre che in tutti gli uffici, anche in molte case. E’ sull’onda di questa rivoluzione che il largo pubblico inizia a familiarizzare con il concetto di rete, ossia con la possibilità di connettersi, tramite il proprio PC, ad un computer remoto al fine di utilizzarne i programmi o le basi dati.
A partire dal 1988, il numero di macchine con collegamento TCP/IP è andato raddoppiando ogni anno, finché si è assistito a una vera e propria esplosione quando è stato introdotto il World Wide Web, un sistema che consente, grazie a un’interfaccia utente molto semplice da usare, di unire e trasmettere in rete testi, immagini e suoni. Attualmente Internet cresce al ritmo travolgente del 20% mensile; se nel 1971 Arpanet contava appena quattro nodi, oggi i nodi sono decine di migliaia.
Internet ha trasformato progressivamente il mondo della comunicazione, acquistando sempre più un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’economia e della società. Attraverso la rete, ad esempio, si possono inviare messaggi, condividere informazioni e lavorare in gruppo su progetti a migliaia di chilometri di distanza.
Il Pensiero
La crisi del marxismo e del concetto di progresso
Nell’ultimo quarto di secolo si è consumato il superamento delle grandi ideologie che hanno segnato la storia del Novecento. In primo luogo, si è verificata la crisi del marxismo, con le definitive delusioni provocate dai regimi comunisti costruiti in Europa e in Asia, e le loro tragedie (come l’Olocausto cambogiano); fenomeno apparso ancora più macroscopico con il cataclisma seguito alla caduta del Muro di Berlino nel 1989. L’ideologia marxista perde il suo appeal in ambito intellettuale e tra le giovani generazioni.
Allo stesso tempo è entrata in crisi l’idea di progresso, l’ideologia dello sviluppo come appropriazione indefinita delle risorse della terra da parte dell’uomo, espressione dell’industrialismo. La presa di coscienza della limitatezza di queste risorse, i sempre più evidenti e gravi danni all’ambiente, la nascita di movimenti ambientalisti e (anche come conseguenza di ciò) la sempre maggiore sensibilità dell’opinione pubblica su questi temi, hanno messo in crisi la razionalità occidentale, così come si era definita nei secoli precedenti.
La crisi dell’idea di moderno non ha come riflesso solo un ritorno verso forme di irrazionalismo, ma provoca soprattutto una nuova riconsiderazione della tematica dell’individuo. Il soggetto è sempre più indifeso, non potendo fare affidamento su visioni filosofiche strutturate e onnicomprensive, ma è allo stesso tempo più libero per la stessa ragione, può sfruttare al meglio le possibilità che la nuova condizione postindustriale gli offre. Per questo si sviluppa molto la riflessione sulla dimensione etica, come nel caso di E. Levinas. La crisi dei grandi sistemi metafisici produce quindi la nascita di filoni di pensiero “deboli”, parziali.
In Europa avviene una profonda riscoperta di filosofi come Nietzsche, Benjamin, Heidegger e, soprattutto, Wittgenstein. Per molti aspetti la filosofia tende a diventare storia ed esegesi della filosofia passata, piuttosto che elaborazione di un nuovo pensiero. Sono gli anni in cui (ad esempio in Italia) si afferma il cosiddetto “pensiero debole”. Più in generale si assiste al trionfo del cosiddetto “pensiero postmoderno”.
Tra i settori più vivaci vi sono quelli che entrano più direttamente in contatto con l’ambito scientifico e con la rivoluzione tecnologica in corso nella società: la logica, in primo luogo, con il suo stretto rapporto con le scienze esatte (fisica, matematica).
La critica post-moderna
Le correnti filosofiche che fino ad ora abbiamo affrontato, post-strutturalismo, post-modernismo ed ermeneutica, formarono, alla fine del Ventesimo secolo, un complesso incrocio di tendenze. Il termine tendenza vuole sottolineare l’impossibilità di stabilire una vera e propria corrente filosofica appartenente a questi ultimi anni; tuttavia, si può rintracciare una tematica comune nel difficile rapporto tra etica, politica e ontologia, e cioè la “crisi della ragione” o piuttosto, la fine della modernità.
Il termine post-moderno è entrata nella discussione filosofica grazie al testo di Jean Francois Lyotard La condizione post-moderna (1979). La teoria della post-modernità viene presentata come una versione acritica e aprogettuale del post-strutturalismo. La filosofia, che un tempo era da considerarsi come uno strumento capace di articolare giustizia e verità, è spogliata di questa capacità, sostituita dall’idea di una pluralità di mondi non più descrivibili.
Il mondo diversificato e smembrato viene a contrapporsi a quella visione di un universo ordinato in strutture, ormai decadute, che decreta la fine della storia. Il pensiero post-moderno è caratterizzato dalla mancanza di un progetto teorico, rimane solo l’interpretazione, o meglio la lettura, di una certa situazione storica. Dopo la caduta delle ideologie filosofiche, che per tutto il Novecento hanno previsto nel loro programma un impegno politico-emancipativo, l’etica rimane l’unico punto critico della teoria post-moderna.
Sin dagli anni ‘70 negli ambienti culturali francesi, e non solo, si è tentato di riflettere sulla condizione della filosofia, anche sotto la minaccia di toglierla definitivamente dalle scuole superiori, e questo ha portato a riconsiderare la filosofia come uno strumento conoscitivo fondamentale nella ricerca della verità.
Il contrattualismo
Il contrattualismo, nato negli anni Settanta, si afferma definitivamente negli anni Ottanta come una corrente di svolta rispetto all’indagine sull’etica discussa fino ad allora.
Abbandonata la pretesa di definire la natura della morale, il contrattualismo vede la necessità di applicare la filosofia morale ad altre discipline, per esempio la politica o l’economia. Nonostante che il contrattualismo ritenga artificiale il carattere della morale, essa trova, nella discussione sugli obblighi e doveri, il suo campo di indagine.
Nel testo di John Finnis La legge naturale e i diritti naturali (1980) l’etica trova il suo fondamento nella legge naturale che garantisce all’uomo i beni umani, cioè tutto quello che è importante per la vita di un individuo, dove il fine della razionalità pratica è proprio quello di raggiungere e conservare i diritti umani di ognuno di noi. La trattazione dei diritti umani è stato uno dei temi più dibattuti in questi ultimi anni, poiché si ritiene compito dell’etica l’individuazione e la difesa dei diritti reali delle persone al fine di garantire per tutti una qualità di vita accettabile.
Gli anni Ottanta, inoltre, hanno visto una ripresa del concetto aristotelico della filosofia pratica. La pretesa aristotelica di una sola concezione della vita buona è stata abbandonata per lasciare spazio all’idea che un comportamento virtuoso si può avere anche quando siamo chiamati a svolgere una sola prestazione. L’etica filosofica deve abbandonare la pretesa di egemonia su tutta la vita umana e favorire i processi che portano ciascun individuo a fare nella propria vita qualcosa di significativo.
La bioetica
La bioetica è la disciplina che si occupa dei problemi morali e normativi in vari campi scientifici, dall’ingegneria genetica ai problemi ambientali; ma le scoperte scientifiche di questi ultimi anni vedono la sua applicazione soprattutto in ambito medico. La possibilità che possiede oggi l’uomo di intervenire sui meccanismi stessi della vita, postula la necessità di una riflessione che orienti la ricerca scientifica e la produzione legislativa dei governi su questa delicata materia.
Agli inizi degli anni Settanta le prime importanti discussioni in campo bioetico furono l’interruzione di gravidanza, riconosciuto come mezzo legittimo per tutelare la salute della donna, e il trapianto di organi. Il termine bioetica fu introdotto per la prima volta da Van R. Potter nel testo Bioetica: un ponte verso il futuro (1971) in riferimento ad una nuova etica fondata sul rispetto dei valori umani al fine di migliorare la qualità della vita. Potter, da medico, aveva preso in considerazione il fatto che molti pazienti, grazie alle nuove tecniche mediche, godessero di un prolungamento della vita a sfavore però della qualità della vita stessa.
Tra gli anni Settanta e Ottanta, organi giudiziari, sia inglesi che statunitensi, hanno autorizzato l’interruzione dell’assistenza medica a pazienti tenuti in vita grazie all’uso di macchine, senza le quali non avrebbero alcuna possibilità di recupero. Oggi giorno, infatti, le argomentazioni in questa materia si occupano soprattutto di eutanasia, fecondazione artificiale, e di interventi di modificazione genetica su esseri animali e vegetali.
Il tema della manipolazione della specie umana è un altro tema scottante, da quando è stato reso possibile conoscere il patrimonio genetico della persone; tuttavia, condizioni più inquietanti si sono affacciate sull’orizzonte scientifico quando si è parlato di possibilità “correttiva” del patrimonio genetico di una persona o di una specie.
Nel testo Principio di responsabilità (1979) il filosofo tedesco Hans Jonas ha lanciato un monito contro le modificazioni genetiche che possono trasformare, in maniera radicale e con effetti di lunga durata, il patrimonio genetico dei discendenti; egli faceva appello ad un nuovo principio di responsabilità che mettesse un freno al campo di indagine quando non si conoscessero le conseguenze degli interventi.
Le preoccupazioni sulle manipolazioni genetiche riguardavano la minaccia che esse venissero utilizzate come discriminanti e diventare uno strumento di distribuzione ineguale delle risorse.
La filosofia al femminile
La novità più importante di questi anni è senza dubbio l’entrata delle donne nelle discussioni a carattere filosofico della figura femminile in rapporto con la storia e la cultura, ma soprattutto la revisione totale del ruolo della donna nei rapporti con l’uomo con una precisa rivendicazione dell’alterità femminile.
La posizione della donna nella società moderna fu molto dibattuta sin dagli anni Cinquanta, ma è dalla fine degli anni Settanta che tale dibattito ha assunto posizioni più precise. Dalle discussioni, sono emerse nuove teorie sulla differenza sessuale: l’essere femminile non è percepito come “passività” rispetto all’uomo ma come un’alterità specifica e autonoma.
Luce Irigaray è sicuramente la pensatrice di maggiore rilievo internazionale; ma anche in Italia c’è stato un gruppo di donne, lontano dai partiti politici e dalle associazioni femminili, che ha voluto aprire il dibattito su questo tema creando, a Verona, il gruppo Diotima (dal nome del personaggio assente di cui Socrate riferisce i discorsi nel Simposio di Platone) di cui fanno parte Luisa Muraro e Adriana Caravero.
Il problema del linguaggio e della sua non neutralità è stato il punto di partenza di queste indagini; al contrario, il punto di arrivo è caratterizzato dalla necessità di liberare il linguaggio dal retaggio maschilista tradizionale. Oltre a tali associazioni culturali di carattere laico, non mancano però movimenti femminili di carattere religioso che hanno dato vita, sin dalla fine degli anni Sessanta, alla cosiddetta “teologia della donna”. Questa teologia al femminile, nata negli USA per poi svilupparsi in Germania e nel Nord Europa, in polemica contro ogni tipo di ideologia fatta dai maschi e nell’ottica maschile, denuncia gli aspetti maschili contenuti nella Bibbia ma, allo stesso tempo, propone il testo sacro come uno strumento di emancipazione femminile.
Luce Irigaray e il gruppo Diotima
Nata nel 1930, Luce Irigaray muove i primi passi (in senso filosofico) dalla lettura, ironica e decostruttiva, delle opere freudiane dedicate alla figura femminile, da cui svilupperà poi una rilettura dell’intera tradizione filosofica scorgendo in essa un occultamento del femminile. Da Platone ai filosofi contemporanei la studiosa nota un’incapacità di comprendere “l’altro”, inteso come il femminile, e pone l’accento sul silenzio che si era avuto per anni sulla questione della differenza sessuale. Questo ha dato l’avvio, anche per altre pensatrici, ad una riflessione sull’idea della differenza sessuale, portando alla neutralizzazione del pensiero maschile al fine di aprire la strada ad un “altro pensiero” quello, appunto, femminile.
In Italia un gruppo di pensatrici, sulla base della riflessioni della studiosa francese, hanno fondato nel 1983 una comunità filosofica tutta al femminile chiamata Diotima.
Alla base non c’è l’uguaglianza tra i sessi ma una specifica rivendicazione della differenza dell’essere femminile. Il liberarsi dal predominio maschile rimane l’obiettivo centrale del gruppo ma interessante e originale è la proposta fatta per arrivare allo scopo: solo grazie all’aiuto di altre donne, più capaci o in una migliore posizione nel mondo del lavoro, si può aiutare la donna ad inserirsi nella società maschile.
Infine, queste riflessioni hanno coinvolto anche la figura materna che viene riconsiderata nel rapporto con la figlia: infatti, si ritiene che la figura materna non abbia avuto un modo appropriato di esprimersi.
Thomas Kuhn
La principale alternativa offerta dalla nuova filosofia della scienza è quella delineata da Thomas Kuhn in La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962). Kuhn ha classificato le fasi della ricerca in due categorie: i periodi di scienza normale, caratterizzati dal dominio di un paradigma condiviso, e i periodi di scienza rivoluzionaria nei quali il paradigma della ricerca viene cambiato. Una comunità scientifica si trova in una fase di scienza normale quando c’è un paradigma condiviso, anche solo in modo tacito, dalla comunità stessa, cioè c’è un modello al quale gli scienziati di quella comunità tentano di adeguare le loro ricerche, che determina i loro metodi e la formulazione dei problemi di cui si occupano. Nelle fasi normali la scienza consiste essenzialmente nel tentativo di risolvere dei “rompicapo”, cioè dei problemi per i quali il paradigma vigente fornisce gli strumenti di soluzione. La scienza normale può entrare in crisi quando vengono scoperte delle anomalie nei fenomeni studiati, ovvero quando i risultati della ricerca sono differenti dalle aspettative implicate dal paradigma. La crisi della comunità scientifica, infine, diventa scienza rivoluzionaria quando viene introdotto un nuovo paradigma, che entra in conflitto con il vecchio modo di condurre la ricerca e creando scompiglio, ma è capace di spiegare i fenomeni che risultavano “anomali” per il vecchio paradigma.
La filosofia del linguaggio: Noam Chomsky
Chomsky ha cominciato la sua produzione letteraria negli anni Cinquanta diventando uno dei più grandi studiosi di linguistica. Infatti, sin dagli anni Sessanta si è occupato del tema della nascita del linguaggio ritenendo che esso appartenga alla sfera del pensiero e che sia una della caratteristiche più importanti della nostra specie, in quanto appartiene solo all’uomo. Contrario alla tesi che ritiene il linguaggio un fenomeno sociale riducendolo a semplice abilità pratica, Chomsky risponde che il linguaggio è una facoltà innata nell’uomo, cioè esso non si può apprendere, ma cresce dentro di noi come se fosse una competenza naturale della nostra mente.
In un testo del 1988, Linguaggio e problemi della conoscenza, egli approfondisce questa tesi allargando il campo di indagine dalla pedagogia alla psicologia. Il bambino non apprende una lingua ma la matura in un modo già predeterminato, sottolineando con ciò l’importanza dell’ambiente ritenuto da Chomsky decisivo per arricchire o impoverire parte del patrimonio genetico.
Questi studi hanno influenzato diversi ambiti disciplinari creando nuovi settori di ricerca: dagli studi storiografici incentrati sull’analisi fattoriale dei discorsi di uomini, movimenti e partiti politici, alla sociologia da cui si è sviluppata la sociolinguistica.
Società e comunicazione
Axel Honneth è uno degli ultimi esponenti della scuola di Francoforte. Assistente di Habermas tra il 1983 e il 1990, partendo dal concetto habermasiano dell’agire comunicativo, critica la visione che nella modernità ci sia stato un doppio processo di razionalizzazione, uno guidato da uno scopo strategico e ben definito che ha egemonizzato la sfera economico-politica, e l’altro, invece, teso a costituire il mondo della vita quotidiana. Honneth crede che questa sia un’immagine troppo rigida della società, dato che nei processi comunicativi esistono sempre dei fattori irrazionali come, per esempio, il conflitto sociale. Tra ragione strategica e ragione comunicativa c’è un’inadeguatezza di fondo poiché nei conflitti sociali quello che è importante non è l’evolversi di una o l’altra razionalità ma gli interessi dei singoli gruppi. Alla radice della lotta sociale, dunque, c’è una affermazione di “sé”, individuale o collettivo.
La fine della filosofia della scienza: Richard Rorty
La reazione al post-modernismo europeo di stampo nichilista proviene dalla scuola neo-pragmatica americana rappresentata da Rorty. Nato a New York nel 1930, già dalla seconda metà degli anni Settanta, Rorty suggerisce un neopragmatismo basato sull’abbandono della filosofia come scienza rigorosa, come unico mezzo di legittimazione della conoscenza. La “democrazia” deve vincere sulla filosofia, essa, infatti, deve abbandonare la pretesa di raggiungimento della verità e dell’assolutezza poiché questo è un atteggiamento anticivile e antidemocratico.
Nel libro Conseguenze del pragmatismo (1982) l’autore sostiene che la filosofia non ha più bisogno del linguaggio scientifico; Rorty crede in una filosofia storico-letteraria, cioè in una filosofia vista come un genere di scrittura, con un particolare stile espressivo e rivolta ad un certo tipo di pubblico, che abbia lo scopo di aprire il dialogo con la società, poiché la collettività si trova a vivere in una condizione post-filosofica, non più animata dalla ricerca della verità ma piuttosto della felicità. Il filosofo, per Rorty, è una figura ironica che esalta la spontaneità contro la ricettività, cosciente della precarietà e della parzialità delle sue scelte.
La teoria critica statunitense: Richard Bernstein
Un altro importante sostenitore delle teorie di Habermas è Richard Bernstein: formatosi all’Università di Chicago, e collega di Rorty, egli non condivide pienamente le teorie di quest’ultimo.
Nel testo Beyond Objectivism and Relativism (1983) Bernstein si occupa delle questioni morali, discusse tra relativisti (Rorty) e oggettivisti, dove rileva che il conflitto tra le due parti è sempre esistito nella storia della filosofia ma che ancora non ha trovato soluzione.
Tuttavia, Bernstein intende ricordare che il conflitto tra le due parti, in realtà, ha tentato di trovare la sua soluzione nella dialettica hegeliana.
La disputa tra le due correnti può avere uno sbocco nell’ambito etico-politico, dopo però aver tentato di sciogliere il pregiudizio che ritiene i problemi della conoscenza scientifica più importanti di quelli posti dalla filosofia morale. Bernstein tenta una mediazione armonizzante tra la “distruzione” della razionalità europea e la sua difesa; egli crede che sia possibile una soluzione tra le due correnti allargando il dialogo in una configurazione più complessa, attraverso una dialettica, anche tra concezioni discordanti.
Michel Foucault
All’interno della filosofia di Foucault (1926-1984) strutturalismo e poststrutturalismo non sono ben distinti. Oltre a queste due correnti, nel suo pensiero, convergono anche il positivismo francese e il pensiero di Nietzsche, sebbene l’ambito della sua ricerca sia soprattutto la filosofia della storia.
Secondo Foucault, nella storia non c’è un progressivo rischiaramento della ragione e lo sviluppo delle scienze non coincide con l’emancipazione umana, ma al contrario porta nuove forme di assoggettamento. Il sorgere delle scienze umane è un chiaro segno che la natura umana è divenuta problematica; il mondo moderno infatti non è diventato più umano ma, al contrario, ha decretato la “morte” dell’uomo. Esiste, per Foucault, una grossa problematicità morale e pratica; l’ultima fase della sua riflessione, infatti, intorno ai primi anni Ottanta, è rivolta alla ricerca di nuove forme di morale che possano superare i dubbi in cui è caduta la razionalità moderna.
La filosofia in Italia
Agli inizi degli anni Ottanta il libro dal titolo Il pensiero debole (1983) di Gianni Vattimo ha suscitato molte contestazioni.
Il “pensiero debole” di Vattimo rinuncia ad una filosofia che ha come scopo la fondazione di modelli assoluti e universali. Compito della filosofia è senz’altro quello di dedicarsi alla “totalità” ma senza la pretesa di essere uno strumento completamente esaustivo della realtà.
Le critiche più aspre al “pensiero debole” di Vattimo e ai post-modernisti provengono, in gran parte, dall’area laica torinese, in particolare da Carlo Augusto Viano, e dall’area fiorentina di Paolo Rossi, entrambi contrari ad una nuova ondata di tradizionalismo filosofico, che attraversa l’Italia e l’Europa, rappresentata dai teorici affini alle ipotesi di Vattimo e ai postmodernisti. La situazione della filosofia in Italia in questi ultimi anni, sostiene Viano, non è molto edificante poiché non esistono correnti originali, che si rifacciano alla nostra cultura filosofica, ma solo influenze dalle scuole filosofiche francesi o tedesche. Tuttavia, la critica di Paolo Rossi è ancora più radicale: egli sostiene, da storico della filosofia, che il mito della razionalità, dominante per secoli in Europa (distrutto dalle filosofie del Novecento), in realtà è solo un mito costruito dai filosofi senza basi storiche fondate.
Remo Bodei ha una posizione piuttosto equilibrata nei confronti del post-modernismo: egli rifiuta un atteggiamento difensivo nei confronti della società industriale poiché la società è in continuo movimento e la filosofia ha il compito di adeguarsi volta per volta ai processi di sviluppo, il ruolo della filosofia è dunque destinato a mutare.
In difesa delle tesi dei post-modernisti interviene alle critiche anche Massimo Cacciari: il punto di partenza della sua filosofia è l’ipotesi di “pensiero negativo” che coglie la crisi dei fondamenti della tecnica sottolineando, purtroppo, che non ci sono soluzioni alla crisi del sistema classico della razionalità.