La Seconda Guerra Mondiale
La guerra di Spagna
1936: una sollevazione militare in un paese arretrato

Francisco Franco a Reus
Nel 1936 la Spagna era un paese ancora arretrato, con una struttura economica che risentiva del suo passato coloniale. L’umiliazione della guerra con gli Stati Uniti del 1898, che aveva posto fine alla sua grandezza imperiale, aveva lasciato in eredità sia il coagularsi dei contrasti interni sia uno stato di isolamento internazionale. Nel 1931 era nata la Repubblica, propugnata e sostenuta dal movimento popolare e democratico, che premeva per la promulgazione di riforme quali la laicizzazione dello stato, ancora pervaso da elementi ed influenze clericali, una vasta riforma agraria e una generale modernizzazione della vita politica e delle strutture sociali del paese. Nemiche giurate del nuovo corso verso la democrazia erano le forze conservatrici e tradizionaliste quali gran parte dei vertici militari, la chiesa cattolica e i grandi proprietari terrieri. Nel 1936 la vittoria elettorale del Fronte Popolare, una coalizione che raggruppava le forze di sinistra ed i liberali favorevoli al sistema repubblicano, portò allo scontro aperto: la sollevazione militare di una parte dell’esercito, iniziata in Marocco, mirava a ristabilire l’ordine e ad instaurare un regime di estrazione fascista, basato sul consenso della chiesa, dei grandi proprietari terrieri e dell’esercito.
I differenti coinvolgimenti delle potenze europee

Franchisti uccisi dalla Guardia Civile e dai civili madrileni, durante l'assedio di Montaña: fu il primo massacro per mano dei Repubblicani: a causa della brutale resistenza di Madrid al colpo di stato franchista, le truppe militari stazionate al centro della Spagna non riuscirono mai a sollevarsi
La sollevazione militare spagnola capeggiata da generali come Francisco Franco e Emilio Mola trovò un valido appoggio nelle forze conservatrici all’interno del paese (in particolare nella chiesa cattolica, che vedeva nella repubblica un nemico dei propri privilegi) e soprattutto nei regimi fascisti in Germania e in Italia. Si trattò di una guerra dai forti contenuti ideologici: si scontrarono non soltanto due schieramenti politici e militari, ma anche due sistemi di pensiero, il fascismo e l’antifascismo, in uno conflitto che attirò su di sé l’attenzione del mondo intero e che coinvolse, pur in forme differenti, le principali nazioni europee.
Hitler e Mussolini si impegnarono direttamente nel conflitto: gli insorti ricevettero l’ausilio di un contingente italiano ben armato e addestrato, mentre la Germania inviò in Spagna la legione Condor, con lo scopo anche di sperimentare il potenziale delle moderne tecniche di combattimento. Essa dette prova della propria efficienza radendo al suolo con due terribili bombardamenti aerei le cittadine basche di Guernica e Durango.
Inghilterra e Francia furono invece molto più titubanti verso lo schieramento repubblicano: ebbe la meglio infatti la forte pressione esercitata all’interno di questi due paesi dalle forze conservatrici, propense ad interpretare i regimi fascisti alla stregua di tradizionali partiti di destra senza scorgerne il potenziale aggressivo ed imperialistico. Esse temevano infatti che una vittoria della repubblica spagnola avrebbe aperto il varco ad una stagione di sommovimenti sociali e politici in tutta Europa. Fu così che il sostegno da parte delle democrazie occidentali fu tiepido e in sostanza irrilevante, restando limitato all’ambito diplomatico e all’invio di materiali di impiego civile. Dall’Unione Sovietica vennero invece aiuti più consistenti alla causa repubblicana, anche se non paragonabili a quelli della Germania e dell’Italia. Il migliaio di tecnici, le poche centinaia di pezzi di artiglieria, carri armati e aerei, oltre alle forniture di munizioni e carburante, comportarono un prezzo molto elevato. Infatti il controllo sempre più stretto sul governo spagnolo esercitato dai dirigenti di osservanza sovietica, fece esplodere contrasti interni al fronte repubblicano che portarono, nel maggio del 1937, allo scontro armato e alla liquidazione degli anarchici e del POUM, partito di ispirazione trotzkista.
Le Brigate Internazionali

Truppe pollate della Brigata Internazionale
A differenza dei governi delle democrazie occidentali, il mondo politico, intellettuale e larghi strati delle società europea e americana diedero vita a una mobilitazione spontanea senza precedenti. Nacquero gruppi eterogenei, per niente addestrati e pratici di strategia militare, ma animati da un fervore e da una passione straordinari: le Brigate Internazionali. Emigrati politici italiani e tedeschi colsero allora l’occasione di combattere apertamente il fascismo nella speranza di poter continuare la lotta nei paesi d’origine: l’intellighenzia democratica riuscì a farsi guida di un movimento di opinione internazionale che scorgeva nitidamente il pericolo fascista e le nefaste conseguenze che avrebbe recato con sé. Si trattò di un’esperienza che, pur sconfitta, fondò il ruolo politico del mondo intellettuale, che si sarebbe rivelato prezioso per i movimenti di resistenza in tutta Europa. Rimasero patrimonio della tradizione democratica i contributi di scrittori e poeti come Hemingway, Orwell, Brecht, Auden, Alberti, Garcia Lorca e Neruda.
Un conflitto impari

Truppe repubblicane si arrendono a Somosierra, 1936
Nel 1937 le mire dei nazionalisti si rivolsero alla Spagna del Nord. Le regioni basche infatti non solo erano rimaste fedeli alla Repubblica, e mantenevano una posizione filobritannica e filofrancese, ma erano zone di rilevanza commerciale e produttiva, che, se conquistate, avrebbero costituito una notevole risorsa per gli insorti. Le truppe del generale Franco entrarono quasi senza incontrare resistenza a Bilbao il 19 luglio; la fortificazione della città, chiamata “anello d’acciaio”, cedette non a causa dei tradimenti, come fu detto, ma per l’inesperienza militare. Le truppe repubblicane erano nel frattempo concentrate intorno a Madrid, che rimaneva il fronte più importante, minacciate dalla presenza dei nazionalisti a Brunete, a poche miglia dalla città. Nel mese di luglio si svolse una delle battaglie più sanguinose del conflitto, che si risolse tuttavia con un nulla di fatto: oltre a resistere in questa zona, il fronte nazionalista conquistava il nord basco. Nell’agosto del 1937 i repubblicani conquistarono due città dell’Aragona, Quinto e Belchite: il risultato, dalla valenza più politica che militare, richiese comunque un dispendio di energie tale da logorare il fronte repubblicano, che affrontò a partire dal dicembre 1937 la battaglia della capitale già molto provato. L’unico modo per sopravanzare i nazionalisti era un attacco a sorpresa: fu così che, mentre i franchisti preparavano l’offensiva per il 18, i loro avversari si mossero alcuni giorni prima. Inizialmente la strategia dette buoni risultati, ma alla lunga le forze dei ribelli si riorganizzarono. Alla fine di febbraio, Franco aveva in mano la vittoria, mentre la repubblica aveva lasciato sul campo 14.000 uomini.
Per il resto del 1938 le sorti della guerra furono favorevoli al fronte nazionalista, che uscì vittorioso a Lérida e a Viñaroz: la vittoria finale sembrava distante poche settimane o addirittura pochi giorni. Ma il fronte repubblicano, guidato dal nuovo primo ministro Juan Negrin, succeduto al socialista Largo Caballero, non cedette.
Nel mese di luglio ebbe inizio la lunga battaglia (circa 90 giorni) sulle rive dell’Ebro: le truppe repubblicane riportarono alcuni successi nelle fasi iniziali, ma alla lunga dovettero soccombere, lasciando campo libero ai ribelli. Il 23 dicembre Franco sferrò l’ultimo attacco in Catalogna: 350.000 vennero riversati contro la linea tra Lerida e Tolosa. Nei mesi seguenti i nazionalisti continuarono la loro avanzata, per celebrare la vittoria definitiva a Madrid il 1 aprile 1939.
1939: la capitolazione della Repubblica e la vittoria di Franco

Rovine di Guernica
Nella seconda parte del 1938 le sorti della guerra furono favorevoli al fronte nazionalista, che uscì vittorioso a Lérida e a Viñaroz: la vittoria finale sembrava distante poche settimane o addirittura pochi giorni. Ma il fronte repubblicano, guidato da nuovo primo ministro Juan Negrin, succeduto al socialista Largo Caballero, non cedette.
Nel mese di luglio ebbe inizio la lunga battaglia (circa 90 giorni) sulle rive dell’Ebro: le truppe repubblicane riportarono alcuni successi nelle fasi iniziali, ma alla lunga dovettero soccombere, lasciando campo libero ai ribelli. Il 23 dicembre Franco sferrò l’ultimo attacco in Catalogna: 350.000 uomini vennero riversati contro la linea tra Lérida e Tolosa. Nei mesi seguenti i nazionalisti continuarono la loro avanzata, per celebrare la vittoria definitiva a Madrid il 1 aprile 1939.
Con l’entrata trionfale del generale Francisco Franco nella capitale spagnola si chiudeva uno dei capitoli più tristi della storia europea: un paese con istituzioni democratiche era stato isolato, nonostante le richieste di aiuto, proprio da quelle nazioni che più dovevano aver interesse alla lotta contro i regimi fascisti o autoritari. A causare la débacle della repubblica spagnola furono le stesse errate convinzioni attendiste inglesi e francesi che in seguito permisero ad Hitler di mettere a ferro e fuoco l’Europa. Il fantasma del comunismo - tanto agitato in tutto il continente ma lungi dal materializzarsi - fu il paravento dietro al quale presero forma rigurgiti nazionalistici ed imperialisti e repressione delle spinte democratiche e riformatrici. In Spagna la breve parentesi dei governi repubblicani cedette il passo a un trentennio di regime parafascista di stampo clericale.
Verso la guerra: l’aggressività nazista
Il sostegno al regime del popolo tedesco

Truppe delle SS al raduno di Norimberga del 1935
Il regime nazista, come quello fascista italiano e in parte quello staliniano in Russia, si basavano sul principio del controllo totale della società.
La violenza istituzionalizzata e la repressione di ogni forma di dissenso caratterizzarono i nuovi regimi totalitari mentre un’importanza straordinaria venne attribuita all’organizzazione del consenso e alla propaganda.
La polizia ufficiale venne subito affiancata dalla polizia segreta (la Gestapo) e dalle milizie di partito (le SS), organizzando nuove forme di repressione degli oppositori politici con l’istituzione di leggi e tribunali speciali e la creazione di campi di concentramento. Così facendo il regime nazista si assicurava il soffocamento di ogni voce contraria alla sua politica, attuando allo stesso tempo un’eccezionale ed efficace forma di controllo sociale basato sull’intimidazione e sul modellamento delle coscienze.
Il regime nazista grazie al genio comunicativo di Joseph Goebbels, ministro della Propaganda, sviluppò delle tecniche per il mantenimento del consenso di inaudita efficacia, risultando in grado di mobilitare le masse e ottenerne l’appoggio incondizionato, anche quando, quasi alla fine della seconda guerra mondiale, gli eventi incominciarono a precipitare irrimediabilmente.
Per la prima volta venne fatto un uso intensivo dei mezzi di comunicazione di massa (radio, stampa, cinema); furono sfruttati i canali privilegiati della comunicazione sociale (la scuola e il mondo della cultura); si sperimentarono nuove forme di controllo sociale legate all’inquadramento delle masse, fin dall’infanzia, in organizzazioni di partito, come la gioventù hitleriana. Venne infine data grande importanza a forme di riconoscimento pubblico collettivo, quali le divise e i distintivi, le cerimonie e adunate di massa (impressionanti quelle documentate nei cortometraggi della regista tedesca Riefensthal). Il popolo veniva così ad identificarsi in maniera totale con il progetto politico del partito e i giovani vennero presto conquistati dalla creazione e diffusione ad hoc di miti e di parole d’ordine che avevano carattere decisamente utopistico, ma erano efficaci nella cattura del consenso.
Ombre sull’Europa: l’Anschluss

Adolf Hitler fa il suo ingresso a Vienna, nel marzo del 1938, a seguito dell'Anschluss.
Dopo il fallito tentativo di annessione dell’Austria del 1934 Hitler si era mosso con maggiore circospezione, ma con immutata risolutezza. La sua strategia prevedeva di inglobare la destra clerico-fascista austriaca, facendo leva sul partito nazista locale. Venne utilizzato, come oramai troppo spesso e troppo strumentalmente, lo spettro di un’egemonia comunista, pericolo che in questo caso non esisteva, visto che il regime dittatoriale e reazionario del cancelliere Schuschnigg aveva messo al bando il partito comunista. Nel febbraio del 1938 egli si rivolse a Hitler nel tentativo di sedare le agitazioni suscitate dai nazisti di Seyss-Inquart e premette affinché quest’ultimo entrasse nel governo. Hitler vi entrò prima in qualità di ministro degli interni, in seguito di cancelliere. Appena insediatosi, Hitler chiese l’intervento tedesco e l’Austria divenne una parte del Reich con il nome di Ostmark, la provincia di Levante. Il 10 aprile un plebiscito sanzionava l’Anschluss, ovvero la fine dell’indipendenza austriaca.
La conferenza di Monaco: le illusioni di Chamberlain e lo scetticismo di Churchill

I firmatari dell'accordo: da sinistra, Chamberlain, Daladier, Hitler e Mussolini; a destra, Ciano. Sullo sfondo si nota Joachim von Ribbentrop, il ministro degli affari esteri tedesco.
Se Hitler fu in grado di portare a compimento il disegno di annessione dei territori etnicamente germanici nel centro europa, ciò fu dovuto in buona parte alla cosiddetta “politica dell’appeasement”, che la Gran Bretagna mise paradossalmente in atto con l’intento di neutralizzare l’aggressività nazista. All’indomani dell’Anschluss il primo ministro Neville Chamberlain era ancora dell’avviso che soddisfare le mire espansionistiche della Germania avrebbe facilitato una politica di pace e di stabilizzazione. Di fronte alla campagna pangermanistica varata da Berlino riguardo alla questione dei Sudeti -regione della Cecoslovacchia a maggioranza tedesca che Hitler intendeva ricongiungere al Reich- Chamberlain promosse una conferenza che si tenne a Monaco nel settembre del 1938, con la presenza mediatrice di Mussolini ma con l’esclusione dei cechi e dei sovietici. Nonostante il significato propagandistico conferito da parte inglese all’iniziativa diplomatica, il risultato fu fallimentare. Il primo di ottobre le truppe tedesche penetrarono nei Sudeti e nel marzo successivo occuparono Praga, stabilendo un protettorato sulla Boemia e la Moravia, mentre la Slovacchia diventava indipendente, ma in posizione subordinata alla Germania. L’espansionismo hitleriano mostrava il prorpio volto, che apparve ormai chiaro anche alla miope strategia britannica.
L’impreparazione di Gran Bretagna e Francia

Petain era il primo sostenitore di un'ammodernamento dell'organizzazione delle truppe carriste
Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, le due principali nazioni democratiche europee si trovavano militarmente in una situazione contraddittoria. La Gran Bretagna era forte della flotta più vasta e potente del mondo, padrona delle acque del Mediterraneo e preponderante in Estremo Oriente. L’aviazione inglese, grazie all’uso del radar e al valore dei propri piloti, sarebbe riuscita a respingere gli attacchi della Luftwaffe nella battaglia d’Inghilterra. La Gran Bretagna lamentava tuttavia un’esercito di terra relativamente poco numeroso e soprattutto sparpagliato su fronti diversi (in patria, in nord-Africa e nelle Indie Occidentali).
La Francia disponeva invece di un apparato militare che paradossalmente, nel 1939, era più numeroso e meglio attrezzato di quello tedesco: ad esempio, la dotazione francese di carri armati era superiore in qualità e numero. La differenza rilevante rispetto alla Germania consisteva nella diversa utilizzazione di questi mezzi. I tedeschi raggruppavano i carri armati in apposite unità, le divisioni corazzate, capaci di agire autonomamente e di assicurare una rapida penetrazione in profondità nel fronte avversario con manovre di accerchiamento che tagliavano fuori i difensori.
Francesi e inglesi invece usavano i carri armati come supporto della fanteria, secondo la tecnica della I guerra mondiale. D’altronde i comandi militari erano sempre in mano a esponenti della scuola militare tradizionale, come Pétain, Weygand e Gamelin, laddove specialisti di strategia come l’inglese Basil Liddell Hart, o giovani ufficiali come Charles de Gaulle sostenevano fin dalla metà degli anni Trenta la necessità di un rinnovamento che facesse leva sulle divisioni corazzate.
Primo obiettivo: la Polonia

Colonna di Panzer III tedeschi avanza velocemente verso est
Mentre ancora la questione cecoslovacca era alle sue ultime battute, una nuova occasione di contrasto si prospettava alle democrazie occidentali a causa della politica aggressiva di Hitler. Gli obiettivi erano le città polacche di Danzica e Memel, di popolazione tedesca, poste in territorio polacco e lituano. Memel venne occupata il 23 marzo, mentre più spinosa fu la situzione di Danzica. Essa godeva dello status di città libera, ed era collegata attraverso un corridoio territoriale alla Polonia, che le garantiva lo sbocco sul Mar Baltico. Tale configurazione spezzava la continuità territoriale dello stato tedesco, lasciandone fuori la Prussia orientale. Tuttavia, come spiegò chiaramente Hitler ai suoi ufficiali: “Danzica non è affatto il vero motivo della disputa, si tratta di estendere il nostro spazio vitale ad Oriente”.
Il patto di non aggressione

Firma del trattato da parte di Molotov alla presenza di Ribbentrop e Stalin
L’atteggiamento delle potenze occidentali che alla Conferenza di Monaco (settembre 1938) avevano capitolato dinanzi alle richieste hitleriane di annettere forzatamente parte della Cecoslovacchia, non fece che accrescere la diffidenza dell’URSS. L’Unione Sovietica del resto era già stata esclusa dalle trattative diplomatiche nei confronti di Francia e Inghilterra. I dirigenti sovietici vedevano nell’unione delle forze occidentali con quelle sovietiche l’unica possibilità di arginare l’espansionismo tedesco verso Est.
Questa stessa considerazione indusse i francesi e gli inglesi nella primavera del 1939 ad avviare una serie di discussioni finalizzate alla possibile intesa con l’Unione Sovietica. Tuttavia la scarsa serietà e lo scarso impegno nell’imbastire i rapporti diplomatici con l’URSS portarono all’interruzione dei negoziati il 21 agosto.
I dirigenti sovietici, verificata la difficoltà d’intesa con le potenze occidentali per frenare l’aggressione di Hitler a Est, decisero allora di allearsi direttamente con il Reich così da non rimanere isolati in caso di conflitto. Il 23 agosto 1939 il ministro degli Esteri tedesco von Ribbentrop e quello sovietico Molotov firmarono un “patto di non aggressione” sulla base del quale le due potenze si impegnavano a non attaccarsi e, nel caso una di esse fosse attaccata da una terza potenza, l’altra non avrebbe dovuto in alcun modo intervenire a suo sfavore. Inoltre entrambe non dovevano aderire ad alcuno schieramento di potenze che minacciasse, direttamente o indirettamente, una delle due.
Hitler riuscì così a ottenere di fatto l’isolamento dell’URSS dalle altre potenze democratiche, nel caso in cui esse avessero deciso di intervenire nell’ormai progettato e prossimo attacco tedesco alla Polonia. L’Unione sovietica, da parte sua, si impadronì di alcune zone nell’Europa orientale, guadagnando tempo per mettere a punto la propria preparazione militare.
La consapevolezza dell’imminente scontro era assente soltanto nelle coalizioni dei governi democratici occidentali.
Il tramonto dell’ordine di Versailles

Il generale tedesco Johannes Blaskowitz (di spalle) riceve la resa della città di Varsavia dal generale polacco Tadeusz Kutrzeba
L’avvento al potere del partito nazista, che in breve tempo spazzò via il fragile patrimonio di istituzioni democratiche della repubblica di Weimar, dette il via ad un processo di progressivo scardinamento dell’ordine europeo nato dalla pace di Versailles e di svuotamento del principale organo internazionale preposto alla risoluzione pacifica delle controversie, ossia la Società delle Nazioni. L’uscita da quest’ultima della Germania e il sostanziale fallimento della Conferenza internazionale di Ginevra sul disarmo, nel 1933, rappresentarono i primi segnali della volontà imperialistica di Hitler. Le sue affermazioni, invero assai esplicite, relative all’instaurazione del Nuovo Ordine europeo, non vennero recepite in tutta la loro gravità dalle altre nazioni europee. Infatti le proccupazioni destate, sia in Francia che in Gran Bretagna, dalla rivoluzione bolscevica e dalla nascita del sistema sovietico fecero perdere di vista l’entità del pericolo rappresentato dalla Germania nazista e, in misura minore, dal fascismo italiano. Sia in Gran Bretagna che in Francia, anche se per diversi motivi, si riteneva da più parti di poter “utilizzare” Hitler e Mussolini al fine di contenere sussulti rivoluzionari nei rispettivi paesi. Inoltre, soprattutto in Francia, le forze conservatrici vedevano sotto una cattiva luce una possibile alleanza in chiave antifascista con l’Unione Sovietica. Fu così che in più occasioni (come nella questione austriaca e in quella di Sudeti, nonché nei confronti dell’invasione italiana dell’Etiopia) si scelse la linea di minor resistenza. Si tentò cioè di neutralizzare le aspirazioni imperialistiche dei regimi fascisti attraverso una serie di concessioni che avrebbero garantito, secondo la politica dell’appeasement teorizzata dal primo ministro inglese N. Chamberlain, gli equilibri sanciti a Versailles. Quando ci si rese conto, nel 1939, che, anziché blandire, tale strategia fomentava gli appetiti tedeschi ed italiani, si era oramai permesso alla Germania di riarmarsi e di annettersi quasi del tutto uno stato indipendente come la Cecoslovacchia: Versailles era soltanto un ricordo.
1939-1941: La Germania sembra invincibile
L’invasione della Polonia

Soldati tedeschi nell'atto di rimuovere la sbarra di confine, alla frontiera tra la Germania e la Polonia, il 1º settembre 1939
Nell’estate del 1939 fallivano definitivamente gli incontri della diplomazia polacca e di quelle francese e inglese con i rappresentanti tedeschi: era oramai palese che questi volevano procedere all’invasione del territorio polacco. Il piano Weiss (bianco) era operativo già dall’inizio d’aprile e la Wermacht era già pronta allo sfondamento dei confini polacchi.
La strategia usata da Hitler nell’attacco alla Polonia è quella della tipica blitzkrieg (guerra lampo): senza alcuna dichiarazione di guerra le truppe tedesche varcarono il confine all’alba del 1° settembre, utilizzando simultaneamente varie divisioni corazzate che, irrompendo da più parti, convergevano verso il centro della Polonia. La resistenza polacca fu quasi inesistente perché le divisioni tedesche corazzate di terra, composte essenzialmente da carri armati (cinque armate), travolsero senza sforzo la vetusta cavalleria polacca, mentre dal cielo l’aviazione tedesca si abbatteva su colonne di truppe polacche, depositi di munizioni, ponti, ferrovie e città prive di protezione antiaerea. Questi furono i primi bombardamenti aerei improvvisi e massicci del secondo conflitto mondiale.
La Polonia si trovava stretta tra due fuochi: infatti, anche l’URSS il 17 settembre occupava i territori orientali attribuitele dai protocolli segreti del trattato Molotov-Ribbentrop. In 17 giorni la campagna di Polonia poteva dirsi conclusa: Varsavia capitolava il 27 settembre; nella prima settimana di ottobre cessava anche la resistenza degli ultimi capisaldi polacchi; il 30 settembre 1939 esponenti politici democratici davano vita, in Francia, al governo polacco dell’esilio sotto la guida del generale Sikorsky, riconosciuto dalle potenze occidentali come l’unico rappresentante della Polonia.
Verso la Francia

Novembre 1939, soldati britannici e francesi giocano a carte in un campo d'atterraggio durante la strana guerra
Hitler aveva previsto l’attacco alla Francia subito dopo l’invasione della Polonia, ma venne spostato al maggio del 1940 a causa della probabilità di condizioni atmosferiche sfavorevoli e delle difficoltà dei trasporti durante l’inverno, accettando così l’opposizione dei capi militari tedeschi, memori dell’enorme sacrificio fatto nelle battaglie sul fronte occidentale del 1916-18.
Se il fronte occidentale rimase statico, in altre direzioni il conflitto si estendeva rapidamente: nel novembre l’Unione Sovietica attaccò la Finlandia e, anche se la guerra russo-finlandese non coinvolgeva direttamente né la Germania né le potenze occidentali, essa era di vitale importanza per per assicurare al Reich le vie del rifornimento del ferro svedese e norvegese e garantire le basi sul Mare del Nord.
Di conseguenza, nell’aprile del 1940 i tedeschi occupavano la Danimarca (che si arrese senza combattere) e la Norvegia (che oppose resistenza all’invasione solo per alcuni giorni). In quest’ultimo Paese venne insediato un “Commissario civile del Reich”, poi sostituito dal governo fantoccio di Vidkung Quisling.
Era giunto il momento di sferrare l’attacco contro la Francia. Il 10 maggio del 1940 le truppe della Wermacht aggiravano la poderosa linea fortificata Maginot e invadevano Olanda, Belgio e Lussemburgo, paesi neutrali. Il Belgio, con l’aiuto di truppe anglo-francesi, poté resistere per alcuni giorni all’invasione, mentre le truppe inglesi in Europa, intuendo che la partita sul continente era ormai perduta, riuscirono a stento a reimbarcarsi a Dunkerque (4 giugno 1940).
Le truppe tedesche avanzavano attraverso le Ardenne e, superata la Mosa, puntavano verso sud, sfondando la linea arretrata francese tra la Somme e l’Aisne e attaccarono alle spalle la linea Maginot.
L’Europa era invasa da un’azione militare incredibile: l’utilizzo massiccio delle incursioni aeree e dei carri armati procurava alla Germania una potenza di incursione senza precedenti. La nuova strategia non si curava delle possibili sacche di resistenza che potevano rimanere alle spalle del fronte in rapido avanzamento, cogliendo di sorpresa i vecchi strateghi francesi.
La disfatta francese: Hitler entra a Parigi

Adolf Hitler a Parigi. Il dittatore visitò più di una volta la capitale francese, a partire dal 30 giugno
L’avanzata delle divisioni tedesche fu rapidissima e accolta dalla popolazione con spirito quasi rassegnato, e tenne in scacco l’esercito transalpino, ancora diretto con strategie da I guerra mondiale. Le armate britanniche in territorio francese si trovarono imbottigliate il 24 maggio sulle spiagge normanne di Dunkerque, riuscendo miracolosamente ad attraversare quasi indenni la Manica. Il 14 giugno Hitler, alla testa dei propri panzer, sfilava raggiante sotto l’Arco di Trionfo a Parigi: il maresciallo Pétain assunse la guida dell’esercito e firmò la resa il 22 giugno, sancendo il passaggio sotto la dominazione nazista di circa tre quinti della Francia e ponendosi alla guida del governo preposto all’area meridionale del paese, con capitale Vichy. Ebbe inizio la breve ed infausta storia del regime collaborazionista, fondato su una costituzione corporativa e reazionaria, ispirata ai principi “del lavoro, della famiglia e della patria”. La più grande potenza militare del continente aveva resistito quanto la Polonia.
Agosto 1940: la battaglia d’Inghilterra e la resistenza inglese

Danni a Londra a seguito dei bombardamenti.
Dopo il trionfale ingresso a Parigi di Hitler e la ritirata di Dunquerque, l’Inghilterra rimaneva l’unico paese a resistere ancora alla potenza nazista. Nel luglio 1940 ebbero inizio violentissimi bombardamenti aerei sulle principali città britanniche: Hitler avanzò una proposta di resa che venne immediatamente respinta da Churchill, divenuto nel maggio precedente primo ministro. Iniziava così l’operazione “Leone Marino” che prevedeva, dopo una fitta sequela di bombardamenti aerei tali da fiaccare psicologicamente la resistenza inglese, l’invasione dal mare dell’isola. Tuttavia le cose non andarono come previsto per la Germania: l’uso del radar da parte della contraerea britannica rendeva impossibile l’approssimarsi all’isola degli aerei della Lutwaffe. Goring decise dunque di cambiare tattica dando inizio a massicci bombardamenti notturni su Londra: il 7 settembre 1940 Londra venne bombardata per la prima volta in modo massiccio con 625 bombardieri protetti da 648 caccia: tutta la zona portuale era in fiamme e le linee ferroviarie verso il sud distrutte.
Per una settimana intera circa Londra subì la terribile pioggia di ordigni, ma finalmente il 15 settembre la RAF riuscì a intercettare gli aerei tedeschi prima che essi arrivassero a Londra e, dopo uno scontro spettacolare, i piloti inglesi riuscirono a ricacciare indietro quelli tedeschi. Il tentativo si ripeté e ancora una volta la Luftwaffe venne messa in fuga. A questo punto Hitler, di fronte al fallimento della guerra-lampo, decise di rimandare sine die lo sbarco in Inghilterra, continuando ed intensificando tuttavia i bombardamenti. Si trattava del primo fallimento tedesco, che ruppe l’impasse psicologica per l’invincibilità della Germania. Al tempo stesso ebbe inizio una durissima guerra navale, finalizzata a bloccare i rifornimenti che giungevano in Gran Bretagna dai dominions e dagli Stati Uniti.
Londra capitale antinazista

Churchill con il generale Władysław Sikorski (alla sua destra), capo del governo polacco in esilio e Charles de Gaulle nel 1941
All’indomani della pesante disfatta francese, parallelamente al regime collaborazionista di Vichy, era nato il primo nucleo della futura resistenza francese: il generale Charles De Gaulle si era infatti rifugiato a Londra ed aveva rivolto un appello ai francesi, il 18 giugno, affinché non si piegassero alla dominazione nazista e continuassero la loro lotta in Francia e nelle colonie. La capitale inglese, nell’oramai solo paese europeo scampato all’occupazione tedesca, divenne da allora in avanti una delle mete principali, insieme agli Stati Uniti, di perseguitati e di antifascisti provenienti da ogni parte d’Europa. Durante il corso della guerra le trasmissioni di Radio Londra divennero non soltanto l’unica fonte di informazione non asservita alla Germania, ma anche un punto di riferimento psicologico ed emotivo per le popolazioni sotto il giogo dell’occupazione nazista.
Una nazione dietro il suo capo

Adolf Hitler parla alla Kroll Opera House (Berlin, 1939)
All’indomani della folgorante conquista della Francia, l’odiato nemico responsabile della “umiliazione” di Versailles, il consenso nei confronti del Führer divenne pressoché unanime: il popolo germanico, attraversati gli anni bui seguiti prima alla Grande guerra e poi alla crisi del 1929, sentiva di aver riconquistato una posizione temuta e prestigiosa e di avviarsi a conquistare lo “spazio” che riteneva gli spettasse di diritto. I rancori ed i risentimenti accumulati nel corso di un quindicennio erano sfociati in un aperto consenso nei confronti del nazionalsocialismo e del suo “capo”, che aveva saputo toccare le corde più sensibili degli animi di molti tedeschi: il richiamo al Sangue, alla Terra, alla Razza, con l’individuazione di nemici e capri espiatori sui quali concentrare semplicisticamente le frustrazioni collettive, la capacità di creare nuove forme di identità e di appartenenza.
Tutto ciò fu possibile grazie anche all’abilità propagandistica del nazismo nei confronti delle masse, applicata con scientifica sistematicità, e che venne ulteriormente potenziata e capillarizzata con l’inizio della guerra in tutti i paesi belligeranti, riuscendo a tenere compatto ed unito il fronte interno fino all’invasione del territorio germanico da parte degli alleati all’inizio del 1945. Solo allora apparve chiaro che per la Germania si prospettava un’immane disfatta.
La disastrosa guerra italiana
Una tragica alleanza

Visita ufficiale di Hitler a Roma nel 1938; sul palco in prima fila da sinistra: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Vittorio Emanuele III, Elena del Montenegro; in seconda fila, da sinistra: Joachim von Ribbentrop, Joseph Goebbels, Rudolf Hess, Heinrich Himmler
Dopo la conquista dell’Etiopia, l’Italia fascista conobbe il periodo di maggior prestigio internazionale, soprattutto presso i partiti conservatori europei: ad esempio, in Inghilterra l’apprezzamento di uomini politici come Winston Churchill nei confronti di Mussolini condusse prima alla revoca delle sanzioni internazionali che avevano fatto seguito all’invasione dello stato etiope, e in seguito a stipulare un gentlemen’s agreement (gennaio 1937), un accordo di pacifica convivenza nel Mediterraneo.
Tuttavia, il comune sentimento antisovietico, nonché le aspirazioni imperialistiche ed espansionistiche comuni ai regimi fascisti, portarono inevitabilmente al reciproco avvicinamento tra l’Italia, la Germania e il Giappone, che stipularono nel novembre 1936 un patto anti-Comintern, al quale seguì la definizione dell’accordo di massima tra Italia e Germania.
Il patto, che prese il nome di “Asse Roma-Berlino” prevedeva un’alleanza militare in caso di guerra sia difensiva che offensiva. In occasione della firma del trattato, Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri fascista, espresse ufficiosamente le proprie perplessità a causa del ritardo nella preparazione bellica dell’esercito italiano, ma venne rassicurato dal proprio omologo tedesco von Ribbentrop che la Germania non intendeva entrare in guerra ancora per tre anni. Un’alleanza che si rivelò fatale per l’Italia: la tragica accelerazione impressa da Hitler agli eventi a partire dal 1939 incoraggiò le aspirazioni espansionistiche del duce, che trascinò il paese in una guerra alla quale non era minimamente preparato.
La frenesia bellica di Mussolini e l’attacco alla Francia

10 giugno del 1940, ore 18. Benito Mussolini annuncia a Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali in Roma, l'entra in guerra dell'Italia confro Francia e Gran Bretagna
Subito dopo l’invasione tedesca della Polonia, che dette il via alla II guerra mondiale, l’Italia dichiarò il proprio stato di “non belligeranza”: non si trattava di neutralità, bensì di un periodo di attesa volto alla preparazione dell’esercito e del paese alla guerra. L’alleanza con la Germania non era in discussione, tuttavia sia nell’esercito che nel partito fascista vi erano diverse perplessità e titubanze nei confronti dell’entrata nel conflitto. L’impresa in Etiopia, prima, e lo sforzo in favore dello schieramento franchista in Spagna, poi, avevano logorato le migliori risorse militari: nel 1939 l’Italia possedeva pochissimi carri armati, un’aviazione neppure paragonabile a quella tedesca ed inglese, e truppe di terra numerose ma con un equipaggiamento insufficiente ed obsoleto.
Nonostante Mussolini fosse a conoscenza delle condizioni dell’esercito, di fronte alle folgoranti vittorie della Wermacht, riteneva che la guerra si sarebbe conclusa entro breve tempo e che quindi fosse necessario muoversi al più presto per non rimanere escluso dal tavolo dei vincitori. Come nella I guerra mondiale, il favore del re e della corte nei confronti dell’intervento giocò un ruolo fondamentale: la corona non si oppose alla frenesia mussoliniana quando il duce decise di dichiarare guerra alla Francia. Il 10 giugno 1940 iniziava l’attacco alle frontiere alpine: l’esito della campagna fu disastroso. Nonostante l’avversario fosse praticamente stremato dall’invasione nazista, le truppe italiane, mal dirette ed equipaggiate, vennero respinte dai francesi che addirittura penetrarono in territorio italiano. Il 24 venne firmato l’armistizio, ma l’Italia non ne trasse alcun vantaggio: il sud della Francia passò sotto il governo di Pétain, contrariamente agli obiettivi di Mussolini.
La campagna d’Africa

Prigionieri italiani catturati dai britannici durante la prima offensiva in Nordafrica del 1940-41
In Libia e in Egitto gli italiani avanzarono fino a Sidi el-Barrani (settembre 1940), ma, in dicembre, la controffensiva inglese guidata dal generale Archibald Wavell respinse le forze tre volte superiori guidate dal maresciallo Graziani. In febbraio, dopo un’avanzata di oltre 500 miglia, gli inglesi giunsero fino alla Cirenaica, e Mussolini fu costretto a chiedere aiuto a Hitler, il quale inviò rinforzi aerei e truppe corazzate, gli “AfrikaKorps”, al comando di Erwin Rommel, il quale il 31 marzo attaccò improvvisamente la Cirenaica, investì Tobruk e raggiunse Bardia, a poche miglia dalla frontiera egiziana, minacciando quindi le posizioni britanniche in Egitto.
Il bilancio del primo anno di guerra italiana presentava un bilancio fallimentare e prospettava una progressiva subordinazione all’alleato tedesco.
Lo sterile attacco alla Grecia

Truppe italiane in Albania durante l'occupazione del paese nell'aprile 1939
Il tardivo ed irrilevante intervento italiano contro la Francia convinse Mussolini a indirizzare le proprie mire espansionistiche e i propri desideri di rivalsa verso la zona dei Balcani, uno dei tradizionali teatri del colonialismo italiano, inaugurando una “guerra parallela” a quella germanica.
Il 28 ottobre 1940, anniversario della marcia su Roma, Mussolini da piazza Venezia annunciò alla folla entusiasta che “spezzeremo le reni alla Grecia”. Dall’Albania, che era stata annessa all’impero nel 1938 con la destituzione del dittatore Achmed Zogu, l’esercito italiano cercò di penetrare in Grecia, fiducioso in una campagna agevole e di breve durata. Tuttavia anche stavolta la realtà fu molto più amara delle previsioni: l’esercito greco seppe opporre una valorosa ed efficace resistenza sulle impervie montagne dell’Ellade, respingendo gli attacchi italiani ed arrivando addirittura ad insidiare il territorio albanese. Fu necessario l’intervento delle truppe tedesche, che in due settimane schiacciarono quell’esercito che sei mesi di offensive italiane non avevano piegato. Nella loro avanzata le divisioni corazzate di Hitler conquistarono l’intera Yugoslavia.
1942-1944: le sorti del conflitto si invertono
L’intervento tedesco in Africa e nei Balcani

Il feldmaresciallo Erwin Rommel, "la volpe del deserto"
La sconfitta subita ad opera degli inglesi dalle truppe italiane del maresciallo Graziani costrinse Mussolini a chiedere aiuto alla Germania. Hitler inviò una divisione corazzata al comando di Erwin Rommel, che alla fine di marzo del 1941 attaccò improvvisamente la Cirenaica, investendo Tobruk e raggiungendo Bardia, a poche miglia dalla frontiera egiziana, minacciando quindi le posizioni inglesi in quella regione. Le Afrikakorps (le truppe speciali tedesche) ottennero facili successi e alla fine di giugno raggiunsero El-Alamein, a circa 65 miglia da Alessandria e dal delta del Nilo. Il 31 agosto 1942 ebbe inizio l’offensiva che mirava a travolgere le ultime resistenze inglesi (l’VIII Armata del generale Montgomery) e a raggiungere la costa. Tuttavia, dopo pochi giorni Rommel fu costretto a sospendere l’operazione: l’esercito era spossato e privo di rinforzi e di rifornimenti.
Gli inglesi, forti di una netta supremazia navale, riuscirono invece a venire in aiuto al proprio contingente africano, permettendo cosi a Montgomery di passare al contrattacco alla fine di ottobre. Nonostante il parere contrario di Hitler, che aveva ordinato la resistenza ad oltranza, Rommel decise di ritirarsi ripiegando in Cirenaica, dopo aver lasciato sul campo 35.000 morti, 10.000 feriti e 35.000 fra prigionieri e dispersi. Intanto, l’8 novembre il generale americano Eisenhower era sbarcato in Marocco e, dopo aver sbaragliato la debole resistenza delle truppe francesi di Pétain e soprattutto i reparti scelti di paracadutisti inviati da Hitler in Tunisia, il 23 gennaio 1943 faceva il suo ingresso a Tripoli.
Anche nei Balcani, cosi come in Africa, i fallimenti italiani in Grecia obbligarono i tedeschi all’intervento: nell’aprile del 1941 la Yugoslavia veniva facilmente assoggettata, consentendo alle truppe corazzate di penetrare in Grecia. In due settimane il brutale intervento nazista piegò l’esercito ellenico ed occupò l’intera penisola, laddove sei mesi di campagna italiana non avevano sortito alcun effetto. Infine, le truppe tedesche presero possesso delle basi aeree in Sicilia per contrastare la presenza britannica nel Mediterraneo. L’Italia era oramai del tutto subalterna alla Germania.
L’attacco all’URSS

L'operazione Barbarossa, nei primi giorni di guerra, fruttò alla Wehrmacht un grandissimo numero di prigionieri; nell'immagine soldati sovietici catturati nella sacca di Minsk
L’annessione alla Germania dei territori russi rientrava nella logica della conquista dello “spazio vitale” ad est, sostenuta da Hitler fin dal 1933, anno della presa del potere. Il patto di non aggressione stipulato con l’URSS nel 1939 aveva un significato tattico, vista la necessità di coprirsi le spalle durante l’attacco ad occidente. Tuttavia, l’Unione Sovietica sembrava consapevole del rischio che stava correndo, e quindi aveva accelerato la preparazione militare e sancito un patto di amicizia con la Yugoslavia (5 aprile 1941) e un patto di neutralità con il Giappone (14 aprile 1941), allo scopo di evitare l’apertura di un secondo fronte in caso di attacco tedesco.
Intanto, fin dal 1940, l’Italia e la Germania avevano legato alle potenze dell’Asse anche l’Ungheria e la Romania, agendo in violazione del patto nazi-sovietico che impegnava le parti alla consultazione nelle questioni di comune interesse. L’attacco italiano alla Grecia e il successivo intervento della Wermacht nei Balcani, zona di diretto interesse sovietico, non lasciarono più molti dubbi sulle intenzioni bellicose di Hitler.
Il 22 giugno 1941 prese il via l’Operazione Barbarossa, che prevedeva l’annientamento delle forze sovietiche con una campagna-lampo: nonostante le numerose avvisaglie, l’Armata Rossa venne colta di sorpresa e fu rapidamente travolta prima di poter organizzare una qualche resistenza. Il bilancio dei primi mesi di guerra fu tremendo: aerei distrutti al suolo negli aereoporti, decine di migliaia di prigionieri, intere divisioni circondate e neutralizzate.
Tuttavia, i dirigenti sovietici riuscirono a riorganizzare e schierare oltre 10 milioni di uomini di riserva, rafforzando l’esercito in una misura che la Germania non aveva previsto. Intanto la Wermacht, nella propria avanzata, era affiancata dai reparti speciali Einsatzgruppen, incaricati di rastrellare e liquidare ogni focolaio di resistenza militare e civile, nonché di annientare sistematicamente la popolazione ebraica in territorio russo: tutto ciò rientrava nel programma di epurazione dei nuovi territori del Reich dai “residui” delle “razze inferiori”.
L’Assedio di Leningrado

Alcune donne alla fine dell'assedio. La scritta che si presume stia per essere cancellata significa: "Cittadini! Questo lato della strada è più pericoloso durante gli attacchi dell'artiglieria"
La strategia della guerra-lampo per la conduzione delle operazioni tedesche era quanto mai essenziale nel territorio russo. Nei primi tre mesi di guerra l’Unione Sovietica perse 3 milioni di uomini, 20.000 carri armati e 15.000 aerei; nell’autunno del 1941 l’avanzata raggiunse le periferie di Mosca e Leningrado, mentre a sud la linea del fronte si stabilizzò sul bacino del fiume Donez fino a Sebastopoli in Crimea. Erano caduti in mano alla Germania i paesi baltici, la Bielorussia, l’Ucraina e parte della Crimea.
Tuttavia, i successi tedeschi non riuscirono a piegare definitivamente l’Unione Sovietica e non destabilizzarono neppure il suo sistema politico, anzi le atrocità nei confronti della popolazione ebbero come risultato l’inasprirsi della resistenza russa, che fece terra bruciata davanti all’avanzata nazista. L’appello all’unità lanciato da Stalin consentì di effettuare un gigantesco spostamento degli impianti industriali nella zona degli Urali e in territorio asiatico, al sicuro dagli attacchi tedeschi. Con l’arrivo del rigido inverno russo, il fango, la neve e il ghiaccio costrinsero all’immobilità l’esercito invasore, che dovette fortificarsi su linee lunghissime, esponendosi alla guerriglia delle bande partigiane. In dicembre l’Armata Rossa era in grado di lanciare una prima controffensiva: la strategia della guerra-lampo poteva considerarsi del tutto fallita.
La prima sconfitta nazista: Stalingrado

Soldati sovietici durante gli scontri nella città
L’inverno aveva concesso ai russi il tempo necessario per riorganizzare le forze e intensificare la preparazione bellica, nonostante l’incursione tedesca avesse raggiunto nell’estate-autunno 1941 circa 1.000 chilometri di profondità.
Inoltre, nel 1942 la Germania si trovava dinanzi alle serie difficoltà economiche perché, fallita la blitzkrieg in URSS, iniziavano a scarseggiare alcune materie prime essenziali e a salire i costi di un enorme esercito schierato lontano dalla Germania.
Tuttavia, nella primavera del 1942 le truppe tedesche ripresero l’avanzata superando il Don, si impadronirono di Rostov per proseguire a Sud in direzione del Caucaso (col proposito di raggiungere i pozzi petroliferi sul Mar Caspio e sul Mar Nero) e a est in direzione di Stalingrado, sul Volga, uno dei più grandi centri industriali russi.
Questa insistenza su due obiettivi fortemente voluti da Hitler nonostante il parere contrario del suo stato maggiore porterà all’indebolimento dell’esercito tedesco, tanto che dal novembre 1942 al febbraio 1943 solo trecentomila uomini della VI armata di Von Paulus saranno impegnati nell’attacco di Stalingrado, difesa però oltre che dall’Armata Rossa anche dagli operai delle fabbriche.
Nonostante quasi tutta la città sia distrutta dagli spietati bombardamenti aerei, i difensori continuano a contendere al nemico casa su casa, finché una poderosa controffensiva russa da nord non rovescia la situazione, chiudendo l’armata tedesca in una morsa mortale ( 23 novembre).
I tedeschi, rimasti in 90.000 uomini, capitolano il 2 febbraio 1943, coinvolgendo nella disfatta anche l’armata italiana (ARMIR), che Mussolini aveva inviato a combattere al fianco dei nazisti.
La disfatta italiana

Il generale Žukov, nominato il 10 ottobre 1941 comandante del fronte occidentale sovietico e della difesa di Mosca
Dopo gli esiti fallimentari delle campagne in Africa e nei Balcani, Mussolini aveva assoluta necessità di riacquistare credibilità e prestigio agli occhi del mondo e soprattutto del suo alleato ormai predominante. Fu infatti una motivazione di natura prettamente politica a determinare la decisione strategicamente più disastrosa dell’esperienza bellica italiana nella guerra contro la Russia. L’esercito era oramai logoro e provato, a corto di armamenti e di equipaggiamento; tuttavia, credendo ancora una volta alla brevità della campagna, il duce inviò sul fronte russo inizialmente il Corpo di Spedizione Italiana in Russia (circa 60.000 uomini, 5.500 automezzi, e 147 pezzi di artiglieria), ma, in seguito, quando la prospettiva della guerra lampo svanì del tutto, vennero spediti a combattere in Russia altri 227.000 uomini costituenti l’ARMIR (equipaggiati con 16.700 automezzi e 588 pezzi di artiglieria).
Trovandosi per la prima volta fianco a fianco con le truppe tedesche, gli italiani presero coscienza della brutalità e della ferocia dei metodi nazisti, che raggiunsero vertici di inaudita barbarie contro gli slavi. La completa insensatezza della spedizione sul fronte russo fu palese durante l’inverno del 1941-1942, quando l’equipaggiamento invernale di cattiva qualità causò un’enorme quantità di decessi per assideramento. L’anno successivo iniziò la ritirata: essa si protrasse fino alla metà del 1943 e causò la morte o la scomparsa di più di due terzi dell’intero contingente.
La guerra in Asia
L’imperialismo giapponese

L'imperatore Hirohito nelle vesti tradizionali
Dopo la prima guerra mondiale, combattuta a fianco dell’Intesa allo scopo di annettersi i possedimenti germanici in Asia, il Giappone aveva conosciuto una crescita industriale e demografica straordinaria e la scena politica era dominata delle zaibatsu, grandi concentrazioni industriali che sostenevano i partiti principali. La crisi economica del 1929 ebbe pesanti ripercussioni nello stato nipponico, tanto da indurlo alla ricerca di una “Grande area di prosperità asiatica” da realizzare attraverso l’occupazione di vasti territori cinesi, sulla scia dell’ascesa al potere delle forze conservatrici ed autoritarie influenzate dai fascismi europei.
I progetti espansionistici misero il Giappone in diretto conflitto con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti: nel 1931 la Manciuria venne invasa e nell’anno successivo fu proclamato lo stato indipendente del Manchukuo. La rapidissima crescita dell’arsenale bellico condusse alla ripresa della guerra nel 1937: Pechino venne occupata, cosi come le province più industrializzate del paese, quali Shanghai, Nanchino e Canton.
La politica imperialistica giapponese aveva numerosi punti in comune con le teorie naziste dello “spazio vitale”, trovando oltretutto un fertile terreno nel diffuso sentimento anticoloniale, fomentato da slogans e parole d’ordine come “l’Asia agli asiatici”: elementi che costituirono i presupposti della futura alleanza del paese nipponico con l’Italia e la Germania.
L’attacco a Pearl Harbour e l’entrata in guerra degli USA

La USS Arizona in fiamme. Fu la nave che riportò il maggior numero di vittime tra l'equipaggio.
In seguito alla sconfitta della Francia e alla difficile situazione in cui si trovava l’Inghilterra, nell’estate del 1941 il Giappone sferrò una pesante offensiva in Estremo Oriente, annettendo al proprio dominio l’Indocina e puntando decisamente verso le Indie orientali olandesi, ricche di giacimenti petroliferi che avrebbero affrancato il paese nipponico dall’embargo commerciale decretato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. In Giappone era oramai prevalsa la linea imperialistica: le relazioni con gli americani erano peggiorate a causa della pericolosa espansione in territorio cinese, mentre l’amministrazione Roosevelt riteneva necessario un intervento militare per arginare l’espansionismo nipponico, anche se l’opinione pubblica americana era assai titubante verso l’ipotesi di un nuovo conflitto, dopo le pesanti perdite durante la I guerra mondiale e le conseguenti tendenze isolazioniste degli anni Venti e Trenta.
Questo era il quadro nell’area estremo-orientale quando, il 7 dicembre 1941, squadriglie di aerosiluranti giapponesi attaccarono improvvisamente la flotta statunitense all’ancora nella base hawaiana di Pearl Harbour, provocando pesanti perdite (otto corazzate, tre incrociatori, circa duecento aerei, oltre 2400 persone morte e 1100 disperse), senza tuttavia colpire le portaerei nemiche, che si trovavano già al largo. Sia l’impreparazione della base di Pearl Harbour (a differenza di altre nell’area del Pacifico) sia il sostanziale fallimento dell’incursione hanno fatto supporre che il presidente americano e gli alti comandi militari fossero già da tempo a conoscenza di un imminente attacco giapponese, e secondo questa interpretazione essi avrebbero deciso di sacrificare poche migliaia di uomini e di mezzi, pur di avere il pretesto per caldeggiare l’ipotesi interventista. Comunque sia, il giorno successivo all’attacco, con 388 voti a favore e 1 contrario (la deputata Jeannette Rankin del Montana, che aveva votato contro l’intervento già durante il I conflitto mondiale) il Congresso degli Stati Uniti decretò la dichiarazione di guerra al Giappone, alla quale seguirono quella contro la Germania e l’Italia, le altre due nazioni dell’Asse.
La massima espansione giapponese

Artiglieri indiana sul Mount Davis proteggono l'isola di Hong Kong
Dopo l’attacco a Pearl Harbour l’avanzata dell’esercito giapponese in Estremo Oriente fu rapidissima: nel maggio del 1942 erano sotto il dominio nipponico la Malesia, le Filippine, la Birmania e le Indie orientali, arrivando a minacciare direttamente l’Australia e l’India. Gli inglesi rimossero una notevole quantità di truppe dal fronte europeo e mediterraneo per concentrarle in questo nuovo, fondamentale scacchiere: ciò contribuì in misura non trascurabile ai successi tedeschi in Africa nello stesso periodo. L’occupazione giapponese di importanti nodi commerciali, quali Singapore e Hong Kong, inferse comunque un colpo brutale al vacillante impero coloniale britannico in Asia, soprattutto dal punto di vista psicologico: la resa della guarnigione inglese di stanza a Singapore fu incondizionata ed umiliante.
L’incursione contro Pearl Harbour ebbe tra le sue conseguenze anche quella di creare un tangibile bersaglio per i latenti sentimenti xenofobi che caratterizzavano già da tempo una parte consistente dell’opinione pubblica americana. Contribuirono inoltre le atrocità compiute dall’esercito giapponese, come quella inferta ai prigionieri statunitensi e filippini i quali, già provati per le insufficienti razioni di cibo, vennero costretti a marciare per un centinaio di chilometri: circa 10.000 di loro morirono di fame, a bastonate oppure furono finiti con un colpo di pistola.
Nel 1942 dunque, parallelamente a quanto avveniva in Europa e nel Mediterraneo, le forze dell’Asse raggiunsero la loro massima espansione.
La reazione americana

L'ammiraglio Chester Nimitz, grande riorganizzatore della Flotta del Pacifico e protagonista delle vittorie navali americane
Le forze armate statunitensi, dopo lo sbandamento dei primi mesi di guerra, passarono al contrattacco a partire dall’aprile del 1942: la capitale giapponese, Tokyo, venne sottoposta ad una serie di pesanti bombardamenti aerei, mentre il mese successivo nell’importante battaglia del Mar dei Coralli venne fermata l’invasione giapponese dell’Australia.
Nel mese di giugno la guerra in Asia conobbe uno dei momenti cruciali e strategicamente più rilevanti, la battaglia di Midway: uno scontro navale dal quale le forze americane uscirono vittoriose, grazie soprattutto alla riuscita del piano Magic. Si trattava di un programma di decodificazione dei messaggi in codice dei comandi militari nipponici: il suo successo permise ai comandanti statunitensi di conoscere con un certo anticipo le mosse dell’avversario, potendole così prevenire e neutralizzare. Durante lo scontro navale ben quattro portaerei giapponesi vennero affondate e con esse una parte notevole del morale e della sicurezza dell’esercito imperiale. Fu infatti un punto di svolta della guerra nel Pacifico: da allora in poi l’esercito americano avrebbe iniziato l’offensiva che gradualmente l’avrebbe condotto alla vittoria.
Uno scontro isola per isola

L'ammiraglio Yamamoto (al centro) attorniato da alcuni dei suoi collaboratori: da sinistra, gli ufficiali Ugaki, S. Fuji e Y. Watanabe
Dopo la battaglia di Midway, il comando americano varò la controffensiva che doveva condurre alla riconquista dei territori occupati dai giapponesi, costituiti dalla miriade di isole degli arcipelaghi malese e indonesiano. La strategia prese il nome di “islands-hop”, “salto dell’isola”: essa prevedeva infatti di evitare le isole meglio difese e fortificate, conquistando invece le più piccole e sguarnite, e di tagliare loro i rifornimenti neutralizzandole senza alcuna perdita. La realtà comunque fu più cruda e difficile delle previsioni: durante l’offensiva di Guadalcanal, nelle isole Salomone, alla metà del 1942, l’esercito americano ebbe il primo, traumatico impatto con la guerra nella jungla. Il caldo afoso tropicale, la fitta vegetazione, i terribili e velenosi insetti rendevano ancora più duri i combattimenti con i soldati giapponesi che sempre opposero una tenacissima e valorosa resistenza. Tuttavia, a prezzo di pesanti perdite, le offensive del 1943 e del 1944 portarono alla riconquista degli arcipelaghi delle Marianne, delle Gilbert e delle Marshall; nell’ottobre del 1944 il comandante a capo delle forze americane nel Pacifico, Douglas MacArthur, atterrava a Leyte per sancire l’occupazione americana delle Filippine.
1944: Il crollo giapponese

Un cannone da 37 mm intento a tirare contro le postazioni in caverna sul Suribachi, nella sanguinosa battaglia di Iwo Jima. Si noti il foglio di metallo irregolare attaccato alla sommità dello scudo del cannone per potenziarne il camuffamento
Nonostante i duri colpi inferti all’esercito nipponico con la riconquista degli arcipelaghi e delle Filippine, gli Stati Uniti dovettero faticare ancora molto per piegare il Giappone. Nel febbraio del 1945 i due eserciti si fronteggiarono a Iwo Jima, una piccola isola situata ad un migliaio di chilometri a sud di Tokyo: 20.000 soldati giapponesi erano asserragliati in chilometri di trincee, caverne e tunnel collegati tra di loro. L’obiettivo americano era il monte Suribachi, la postazione più alta e meglio fortificata dell’isola; la situazione americana era difficile ed il terreno dovette essere conquistato metro per metro. Dopo una ventina di giorni di duri e sanguinosi combattimenti, la cima venne conquistata, al prezzo della vita di quasi 7.000 marines a fronte delle sole 200 vittime giapponesi.
Un mese più tardi, un’altra, cruciale battaglia, stavolta nell’isola di Okinawa, a circa 700 chilometri dalle coste giapponesi. Le perdite nipponiche furono enormi: quasi tutta la guarnigione giapponese, composta da circa 100.000 uomini cadde sul campo di battaglia, mentre le perdite americane furono inferiori ai 10.000 uomini. La battaglia navale ingaggiata dalle due flotte nelle acque dell’isola costò la vita a più di 5.000 marines, tra morti e dispersi: fu in questa occasione che le navi statunitensi si videro attaccate per la prima volta dalla micidiale ed agghiacciante arma dei kamikaze, piloti d’aereo suicidi che si gettavano sull’obiettivo portando con sé quanto più esplosivo possibile.
La vittoria di Okinawa fu decisiva, ma tuttavia insufficiente a piegare definitamente la tenace resistenza giapponese.
La riconquista dell’Europa
La conferenza di Teheran

da sinistra il Capo Supremo (dal 1941) dell'Unione Sovietica Joseph Stalin, il presidente americano Franklin D. Roosevelt e il primo ministro inglese Winston Churchill
Nel novembre-dicembre del 1943 si svolse a Teheran un incontro tra i tre rappresentanti più insigni delle principali nazioni in lotta con la Germania nazista: Stalin per l’Unione Sovietica, Winston Churchill per l’Inghilterra e Franklin D. Roosevelt per gli Stati Uniti. Venne stabilito come obiettivo della guerra alleata la “vittoria totale” sulla Germania e la sua “resa incondizionata”. Era infatti preoccupazione comune che si ripetesse una situazione analoga a quella del primo dopoguerra, quando la Germania ebbe la possibilità, grazie ad una serie di fattori concomitanti, di riarmarsi e minacciare nuovamente l’Europa. Lo sguardo dei tre grandi era tuttavia rivolto già alla fine della guerra ed alla ricomposizione e riassetto degli equilibri internazionali. Già infatti si profilava un possibile antagonismo tra i due paesi economicamente e militarmente più potenti, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. In questa ottica si situò la pressante richiesta di Stalin dell’apertura di un secondo fronte in Europa da parte delle truppe angloamericane, allo scopo di scongiurare la possibilità di una pace separata con la Germania e il conseguente isolamento bellico dell’Unione Sovietica.
Le pressioni staliniane andarono a buon fine: venne infatti decretato l’attacco all’Europa attraverso la Manica, strategia che ebbe come ulteriore conseguenza quella di declassare il Mediterraneo a fronte di secondo rango, e con esso di ridimensionare le mire egemoniche inglesi nei Balcani ed in Africa. Fu un ulteriore presagio dell’imminente bipolarismo e della riduzione del peso specifico internazionale dell’Inghilterra.
Il contrattacco sovietico

Il Maresciallo Georgij Konstantinovič Žukov, incaricato da Stalin della difesa del saliente di Kursk
Nonostante la disfatta di Stalingrado, Hitler sferrò una nuova, potente offensiva sul fronte russo nel luglio del 1943. Kursk fu lo scenario della cosiddetta “battaglia dei carri armati”: un enorme numero di mezzi corazzati si scontrarono per quasi dieci giorni, durante i quali i sovietici riuscirono sia a mantenere le loro posizioni che ad infliggere pesanti perdite alla Wermacht. L’Armata Rossa passò così al contrattacco su larga scala, sconfiggendo i tedeschi ad Orel e, nel mese di agosto, sul fiume Donez, riconquistando Kharkov ed obbligando in settembre il nemico alla ritirata dietro il Dnjepr. Le battaglie dell’estate 1943 eressero l’Unione Sovietica al rango di grande potenza economica, politica e militare. L’enorme sforzo produttivo, seguito al rapido trasferimento all’inizio dell’invasione nazista dei principali impianti al di là degli Urali, era stato possibile grazie alla forte coesione e tenacia del popolo russo, mobilitato da Stalin col richiamo alla difesa e alla salvezza della patria e della nazione.
Hitler, furioso per la sconfitta ad opera di una “razza inferiore”, ordinò alle truppe attestate sul Dnjepr di farsi massacrare piuttosto che cedere le zone minerarie della regione, indispensabili per lo sforzo bellico tedesco. Tuttavia la marcia dell’esercito sovietico era inarrestabile: occupò l’intera zona del Dnjepr e, dopo la vittoria sul fiume Bug, respinse le armate nemiche al di là della vecchia frontiera russo-rumena, dando inizio alla penetrazione e riconquista dell’Europa orientale.
Lo sbarco in Normandia e l’avanzata in Francia

Truppe da sbarco si avvicinano a Omaha Beach, 6 giugno 1944
Il secondo fronte europeo, così caldeggiato da Stalin, venne aperto il 6 giugno 1944: il luogo prescelto per l’attacco (operazione Overlord) furono le coste della Normandia, nelle vicinanze del piccolo centro di Cherbourg. Questa scelta trasse in inganno i vertici militari tedeschi, che invece avevano previsto lo sbarco nella zona di Calais, concentrandovi notevoli contingenti militari. Gli angloamericani investirono le coste francesi con uno spiegamento di forze senza precedenti: 3 milioni di uomini, 1200 navi, 6500 mezzi anfibi, 13000 aerei sotto il comando del generale americano Dwight D. Eisenhower. Le perdite furono pesanti, soprattutto perché il primo contingente sbarcato sulla spiaggia venne letteralmente falciato dal fuoco delle mitragliatrici tedesche, appostate sui rilievi antistanti. Una volta consolidata una testa di ponte sulla costa, ebbe inizio la penetrazione nell’entroterra francese, che dovette essere riconquistato casa per casa. L’esercito tedesco oppose una strenua resistenza in numerose occasioni, come a Falaises, dove aspri combattimenti proseguirono per giorni. Tuttavia il fuoco incrociato dell’artiglieria e dell’aviazione permise agli Alleati di liberare Parigi nel mese di Agosto: il generale De Gaulle poteva rientrare trionfante quattro anni dopo la pesante disfatta del 1940.
Ultime offensive tedesche

Truppe Waffen-SS all'attacco durante i primi giorni dell'offensiva delle Ardenne.
Dopo lo sbarco in Normandia, l’avanzata degli angloamericani in Europa nell’estate e nell’autunno del 1944 aveva condotto, anche grazie ad un’intensa collaborazione dei gruppi armati della Resistenza, alla liberazione della Francia e del Belgio; all’inizio dell’inverno la Germania era a portata di mano. Sull’onda dell’entusiasmo per le folgoranti vittorie, gli Alleati sottovalutarono le risorse e la capacità reattiva, ancora appannaggio dell’esercito tedesco. Nell’ultimo inverno di guerra la Wermacht scatenò una disperata, ma potente offensiva nella foresta belga delle Ardenne. Consapevole di costituire l’ultimo ostacolo per il nemico sulla via di Berlino, il contingente tedesco si batté accanitamente, cercando di spingersi fino ad Anversa ed interrompere così il flusso di rifornimenti e rinforzi che arrivavano agli Alleati attraverso i porti belgi. I combattimenti proseguirono per oltre un mese, ma alla fine di gennaio i tedeschi vennero respinti: nel marzo del 1945 le truppe del generale Eisenhower traversarono il Reno, occupando gli importanti impianti siderurgici della Ruhr e dando così inizio all’invasione della Germania.
Nel frattempo venne lanciata una potente controffensiva contro l’Inghilterra e in particolare contro Londra, sfruttando nei bombardamenti il potenziale dei nuovi missili V1 e V2, in grado di sfuggire ai radar avversari e di trasportare una quantità di esplosivo notevolmente superiore agli ordigni tradizionali. L’uso di tecnologia sempre più sofisticata caratterizzò l’intero corso della seconda guerra mondiale, coinvolgendo entrambi gli schieramenti. Gli Alleati risposero dapprima con i nuovi bombardieri americani B-52, le “fortezze volanti”, capaci di trasportare su lunghe distanze un enorme quantitativo di bombe, in seguito con l’energia nucleare, utilizzata dagli Stati Uniti contro il Giappone.
La liberazione dell’Est europeo

Incontro tra Tito e Winston Churchill nel 1944
Le sconfitte dell’agosto e del settembre del 1943 ad opera dell’Armata Rossa avevano definitivamente convinto Hitler ad abbandonare gli obiettivi di espansione in Unione Sovietica. Iniziava così un lento ripiegamento della Wermacht sulla spinta dell’esercito russo, che liberò gradualmente tutta l’Europa orientale dalla dominazione nazista. In Yugoslavia, a differenza di altri paesi come la Romania o la Bulgaria, il movimento partigiano guidato ed egemonizzato dai comunisti di Josip Brosz, detto Tito, riuscì a liberarsi dall’occupazione tedesca senza l’apporto delle forze militari alleate. Fu instaurato un regime di tipo sovietico con alcune peculiarità quali, ad esempio, la salvaguardia dell’autonomia e dei poteri delle singole etnie e nazionalità slave attraverso una costituzione federale. Negli anni successivi la Yugoslavia di Tito, dopo gli anatemi di Stalin e la rivendicazione della propria autonomia, divenne uno degli stati promotori del “movimento dei paesi non allineati”, composto da quegli stati che si ponevano in posizione equidistante e neutrale rispetto agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica.
In Grecia la prevalenza dei comunisti nel movimento di liberazione nazionale ebbe nel dopoguerra esiti più drammatici. I comunisti vennero infatti contrastati dalle truppe britanniche e sconfitti dopo una lunga guerra civile che riportò con la forza il paese nell’ambito dell’influenza occidentale.

Fotografia tratta dal rapporto stilato da Jürgen Stroop nel maggio 1943 inviato ad Heinrich Himmler. La didascalia originale in tedesco indicava: "Fatti uscire forzatamente dai nascondigli"
In Polonia, durante la ritirata delle truppe tedesche, la situazione era complessa e delicata: il governo di indirizzo moderato, desautorato nel 1939, si era rifugiato a Londra e godeva del pieno appoggio dell’Inghilterra, mentre i sovietici contrapponevano un altro governo, anch’esso in esilio, di orientamento più radicale. Nel settembre del 1944 le organizzazioni patriottiche polacche, che si rifacevano al governo di Londra, promossero l’insurrezione a Varsavia, con l’intento di stabilirvi un governo prima dell’arrivo dei russi. Questi ultimi tuttavia si fermarono alle porte della città, lasciando così gli insorti in balia dei tedeschi, che misero la città a ferro e fuoco. Dopo la sconfitta dei patrioti, l’Armata Rossa entrava a Varsavia, cacciando le truppe germaniche.
L’Italia dal 1943 alla liberazione
Declino e caduta di Mussolini e del regime

Sbarco di truppe statunitensi sulle spiagge di Gela
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia nel luglio del 1943 mise in luce molte debolezze del regime fascista che perse la residua compattezza nell’affrontare le questioni belliche. La disastrosa campagna di Russia aveva convinto molti esponenti del Pnf della necessità di arrivare ad un armistizio. L’arrivo degli angloamericani precipitò la situazione: durante la seduta del Gran Consiglio del Fascismo, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, la proposta del duce di proseguire la guerra a fianco della Germania venne messa seccamente in minoranza. Venne approvato un ordine del giorno, redatto da Dino Grandi, che sanciva la sfiducia a Mussolini quale capo del governo e delle forze armate. Nonostante l’incredulità di Mussolini, il re Vittorio Emanuele lo mise agli arresti il giorno successivo facendolo rinchiudere nel carcere di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Tra i gerarchi che votarono a favore dell’ordine del giorno proposto da Grandi vi fu anche il ministro degli Esteri, e genero del duce, Galeazzo Ciano, che verrà poi catturato dalla polizia della Repubblica di Salò, processato a Verona e condannato a morte nel 1944.
Le gravi incertezze del governo Badoglio

Prima riunione del Governo Badoglio (1943)
Nel determinare la sfiducia a Mussolini, le pressioni da parte del re avevano esercitato un ruolo fondamentale: la monarchia era cosciente che la propria sopravvivenza era legata ad un uscita dignitosa dal conflitto e al tempo stesso temeva che un regime oramai screditato avrebbe radicalizzato le tensioni sociali e politiche che iniziavano a manifestarsi nel paese.
Infatti la scelta del successore del duce non cadde su un esponente del panorama politico, bensì su un militare, Pietro Badoglio, protagonista, assieme a Rodolfo Graziani, dei rovesci militari italiani in Africa. Il suo governo si insediò fin dal luglio 1943, senza tuttavia prendere nettamente posizione contro l’alleato nazista, anzi badando a rassicurare Hitler sulla partecipazione dell’Italia a fianco della Germania fino alla fine della guerra. Fu una mossa che non incontrò il favore popolare: tre anni di roboanti proclami seguiti da continui fallimenti militari, e da ultimo la tragedia dei caduti e dei dispersi sul fronte russo e il manifestarsi di un’incipiente crisi economica avevano logorato il sostegno al fascismo al punto che alla caduta di Mussolini non seguì alcuna protesta e anzi si riteneva imminente la fine della guerra.
L’armistizio e lo sbarco alleato a Salerno

L'abbazia di Montecassino bombardata
L’armistizio con le forze alleate che gli italiani avevano creduto imminente dopo la caduta di Mussolini venne firmato soltanto dopo 45 giorni, ossia l’8 settembre. In questo interludio anche in seguito allo sbarco angloamericano in Sicilia, la Germania aveva occupato la penisola con notevoli contingenti di truppe, vanificando così la possibilità di un attacco a sorpresa e attestandosi al confine tra il Lazio e la Campania. L’Italia tuttavia, soprattutto per l’opposizione inglese, non fu accolta su un piano di parità con gli altri paesi occidentali, ma con l’ambiguo status di “co-belligerante”.
Nello stesso mese di settembre le truppe angloamericane, dopo aver invaso ed occupato la Sicilia nel mese di luglio, sbarcarono a Salerno. In ottobre giungevano a Napoli e, e dopo aver superato il Volturno il giorno 18 si fermarono lungo la “linea Gustav” (il fronte meridionale su cui erano attestati i tedeschi) sino al maggio del 1944.
La fuga del re e del governo e la dissoluzione dell’esercito

Il generale Castellano (in borghese) e il generale Eisenhower si stringono la mano dopo la firma dell'armistizio a Cassibile
Subito dopo la firma dell’armistizio con gli Alleati, che occcupavano il paese nella parte meridionale, il re e il capo del governo Badoglio fuggirono dalla capitale alla volta di Brindisi, dove potevano godere della protezione degli Alleati: Roma venne lasciata in balia dei tedeschi così come la maggior parte del paese. L’esercito rimase senza direttive e una grossa parte delle truppe preferì il campo di prigionia piuttosto che continuare a combattere a fianco dei nazisti.

Vittorio Emanuele III a Brindisi passa in rassegna una formazione del Regio Esercito
L’8 settembre e la fuga del re rimangono uno dei nodi cruciali della storia italiana: alcuni storici l’hanno considerata la “fine della patria”, di un’idea comune e condivisa di appartenenza e di sentire. Per altri prevale invece l’aspetto fondativo di una nuova identità collettiva che faceva tabula rasa dei valori nazionalistici di stampo liberale, ereditati e amplificati dal regime fascista, per edificare una nuova “tavola” etica e morale di stampo pluralistico e democratico.
L’episodio dell’abbandono di Roma da parte del re e di Badoglio fu oggetto anche di un’indagine di una commissione di inchiesta, istituita nel 1944 dopo la liberazione della capitale, per far luce sulle responsabilità sia dei politici sia dei militari. Tale inchiesta, sebbene non abbia sciolto tutti i nodi, indubbiamente ha sottolinea il riprovevole comportamento della maggioranza dei protagonisti.
La liberazione di Mussolini e la repubblica di Salò

Mussolini incontra un milite adolescente della RSI (1944)
Nel mese di settembre del 1943 un commando di paracadutisti tedeschi riusciva con un colpo di mano e senza incontrare resistenza a liberare Mussolini dal carcere di Campo Imperatore, dove era stato rinchiuso il 26 luglio. Trasportato a Berlino, venne ricevuto da Hitler che gli garantì il proprio aiuto per rientrare in Italia. L’ex duce assicurò di voler continuare la guerra a fianco della Germania fondando un nuovo stato in Italia, che proseguisse laddove il fascismo era stato fermato.
Venne scelto il nord della penisola, occupato dai tedeschi, e in particolare una piccola località sul lago di Garda, Salò, dove venne insediato il governo della Repubblica Sociale Italiana: era giocoforza stare lontani dalle grandi città del nord dove il consenso sarebbe stato decisamente più blando. In realtà si trattava di una iniziativa senza prospettive, tenuta in piedi dal nazismo che la utilizzava a proprio piacimento, senza lasciarle alcun potere reale. Mussolini era ormai l’ombra di se stesso: in questo estremo e penoso capitolo della storia del Ventennio aveva scelto di rifarsi alla radice socialista del fascismo (da cui il nome Repubblica Sociale), scontrandosi tuttavia con i diktat di Berlino che ne faceva una testa di ponte per il controllo ed il reclutamento di manodopera italiana per le industrie tedesche. La Rsi, è rimasta tuttavia scolpita nella storia italiana per la collaborazione offerta ai nazisti nei rastrellamenti e nelle repressioni contro le bande partigiane e, più in generale, per il terrore nel quale costrinse le regioni settentrionali del paese.
I partiti del CLN

Fontana del Comitato di Liberazione Nazionale posta in memoria dei Legnanesi che combatterono e morirono per la liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. La dedica recita: "Legnano, ai suoi figli caduti per la libertà".
Gran parte dell’esercito partigiano era strettamente collegato con partiti o formazioni politiche. Il Partito Comunista, che durante gli anni del regime e della clandestinità aveva cercato di tener desta l’opposizione al fascismo, controllava le brigate “Garibaldi”: la scelta dell’eroe risorgimentale significava la volontà del partito di mettere temporaneamente da parte gli obiettivi rivoluzionari per allearsi con gli altri partiti in vista del ristabilimento della democrazia e della libertà. Erano le brigate più numerose e compatte e comprendevano da sole il 45-50% dell’intera forza partigiana.
Gli iscritti e i simpatizzanti del Partito d’Azione facevano parte delle brigate “Rosselli” e “Giustizia e Libertà”, che a livello organizzativo e quantitativo seguivano immediatamente le formazioni comuniste. Anche il partito della Democrazia Cristiana ebbe le proprie untà anche se meno numerose e diffuse (lo furono soprattutto nel Veneto). Una parte delle formazioni cosiddette “indipendenti”, formate da ufficiali dell’esercito ed ex carabinieri, rifletteva la partecipazione al CLN dei partiti di orientamento liberale e di fede monarchica.
Obiettivo di tutte le correnti che confluivano nel movimento era la lotta contro il fascismo ed il nazismo; tuttavia, mentre i gruppi “indipendenti” combattevano, in obbedienza agli ordini del governo e della Corona, una guerra con obiettivi esclusivamente militari, coloro che militavano nei partiti progressisti e di sinistra si batteva per un ideale di giustizia sociale e per un nuovo, anche se vago, assetto della società.
La Resistenza

Partigiani garibaldini in piazza San Marco a Venezia nei giorni della liberazione.
Il movimento di resistenza ebbe un ruolo di prim’ordine nella storia degli ultimi due anni di guerra, dal settembre 1943 all’aprile 1945, e continuò ad esercitare una profonda ifluenza politica sulla politica italiana nel dopoguerra.
Sorse quasi spontaneamente nell’autunno del 1943, sviluppandosi nei mesi successivi e diventando parte integrante della lotta delle truppe alleate contro i nazifascisti. Le forme in cui prese corpo furono disparate, dal semplice rifiuto di collaborazione con le forze occupanti al boicottaggio dello sforzo bellico nazifascista, dall’aiuto ai prigionieri di guerra angloamericani a quello agli ebrei perseguitati dalle leggi razziali. Ma il suo aspetto più caratterizzante furono le azioni di guerriglia, che talvolta assunsero dimensioni notevoli, contro le truppe tedesche e le Brigate Nere della Rsi. Un movimento multiforme quindi, che in alcune aree del paese arrivò a mobilitare vasti strati della popolazione.
Furono le formazioni partigiane a fornire il più consistente contributo alla Resistenza: esso passò dalle circa 10.000 unità dell’autunno 1943 fino alle oltre 230.000 della fine della guerra. La composizione delle “brigate” (contingenti che annoveravano circa 8-9.000 partigiani) era molto eterogenea: le componevano soldati e ufficiali che dopo l’armistizio non avevano potuto far ritorno a casa, giovani in età di leva che si erano dati alla macchia per sfuggire all’arruolamento nelle truppe repubblichine, altri infine che si erano aggregati liberamente rispondendo agli appelli dei partiti e del Comitato di Liberazione Nazionale.
Gli ultimi giorni del Duce

25 aprile 1945: Mussolini abbandona la prefettura di Milano A sinistra il tenente Fritz Birzer, capo scorta delle SS. Questa è l'ultima foto che ritrae Mussolini vivo.
Dopo la sua liberazione dalla prigione sul Gran Sasso, Mussolini era oramai un uomo stanco e demotivato. I colloqui che ebbe con Hitler nel settembre del 1943 in Germania lo convinsero tuttavia a mettersi alla testa della Repubblica Sociale Italiana, lo stato-fantoccio in mano ai nazisti che venne insediato nell’Italia nord-orientale fino alla fine della guerra. Tuttavia, rispetto ad altri esponenti del neonato Partito repubblicano fascista e della parte di esercito rimastagli fedele, come Pavolini e Graziani, la sua autorità non fu più quella di un tempo. Durante il 1944 le blande lamentele che spesso rivolgeva ad Hitler per la condotta delle truppe tedesche in Italia, per gli eccidi indiscriminati (fascisti compresi) di civili inerti, caddero nel vuoto: oramai la Germania trattava l’Italia come un paese occupato.
Il 14 novembre 1944 Mussolini tenne al Teatro Lirico di Milano il suo ultimo discorso pubblico: i toni, come di consueto retorici e altisonanti, non riuscivano più a nascondere l’incosistenza politica che si celava dietro di loro. Mussolini pareva esserne consapevole e iniziava a pensare di rifugiarsi in Svizzera, dopo aver ricavato trenta milioni dalla vendita del quotidiano “Il Popolo d’Italia”.

25 aprile 1945: Mussolini abbandona la prefettura di Milano A sinistra il tenente Fritz Birzer, capo scorta delle SS. Questa è l'ultima foto che ritrae Mussolini vivo.
Nell’aprile del 1945 ormai gli eventi precipitarono: il 15, senza comunicarlo ai tedeschi, Mussolini decise di trattare con gli Alleati. Il 18 si recò a Milano insieme a Clara Petacci, la sua amante, e attraverso la mediazione del cardinale Schuster, incontrò dei rappresentanti del CLNAI il 25 aprile. Di fronte alla proposta di resa incondizionata, decise di fuggire verso la Svizzera e da lì, con un passaporto spagnolo, riparare presso il paese franchista. Giunto vicino alla frontiera svizzera, vista la difficoltà a superare il confine, puntò su Merano, unendosi a un distaccamento tedesco in ritirata. Giunto a Dongo, nonostante indossasse un cappotto e un elmetto tedeschi, venne riconosciuto da un gruppo di partigiani e catturato. Condotto insieme alla Petacci a Giulino di Mezzegro, su ordine del CLNAI venne immediatamente fucilato.
Il 29 aprile i corpi del duce, della Petacci e di alcuni gerarchi vennero appesi a testa in giù a Piazzale Loreto, a Milano, alla tettoia di un distributore di benzina. Era lo stesso luogo dove il 17 agosto 1944 erano stati ammucchiati dai tedeschi i cadaveri di quindici prigionieri italiani che credevano di essere condotti in Germania per lavorare nelle industrie del Reich e che invece erano stati barbaramente fucilati.
La Liberazione e la resa dei conti

Italia, maggio 1945: un soldato sikh, della ottava armata britannica, osserva una bandiera tedesca catturata davanti ad un muro con una scritta inneggiante a Mussolini.
Nella primavera del 1945, dopo un inverno terribile, che aveva visto gli Alleati bloccati sulla linea Gotica (che tagliava da est a ovest l’Italia all’altezza della Toscana) e i partigiani in difficoltà per i pesanti e frequenti rastrellamenti tedeschi e fascisti, il generale Alexander del comando angloamericano lanciava la sua offensiva finale. Il 21 aprile la conquista di Bologna, che apriva la valle del Po alle truppe alleate, dava ai partigiani il segnale dell’insurrezione. Tutte le principali città del Nord venivano attaccate dalle bande discese dalle montagne e ingrossate dalle formazioni cittadine: entro il 25 aprile, alcuni giorni prima dell’arrivo degli angloamericani, il CLN teneva sotto controllo i centri maggiori. Spesso intere guarnigioni tedesche si erano arrese, ufficiali compresi, ai comandanti partigiani. Con l’esercito tedesco si disgregavano anche le Brigate Nere, le formazioni della Repubblica Sociale, già decimate dalle diserzioni e dalle perdite subite durante gli scontri con le bande partigiane.
Con la tentata fuga e l’esecuzione di Mussolini terminava la lotta armata contro il fascismo. Ciononostante venti anni di regime e soprattutto gli ultimi cinque anni di conflitto avevano reso i rancori e la sete di vendetta davvero feroci: alla pubblica esecrazione cui erano condannati gli ex aderenti e sostenitori della Repubblica di Salò e i collaboratori a vario titolo dell’occupazione nazista, si sommarono numerosi casi di esecuzioni sommarie, come quella verificatasi a Schio, in provincia di Vicenza, contro repubblichini e collaborazionisti. Era un’ulteriore, tragica conseguenza della più generale tragedia cui Mussolini, il fascismo e, in parte, la monarchia dei Savoia avevano condotto l’Italia.
1945: l’anno della vittoria
Jalta: la divisione del mondo

La Conferenza di Jalta, Crimea, February 1945: da sinistra il primo ministro inglese Winston Churchill, il presidente americano Franklin D. Roosevelt e il Capo Supremo (dal 1941) dell'Unione Sovietica Joseph Stalin; sullo sfonda (da sinistra): Anthony Eden, segretario degli esteri britannico, Edward Stettinius, segretario di Stato americano, Alexander Cadogan, sottosegretario permanente agli Affari Esteri britannico, Vyacheslav Molotov, commissario sovietico per gli Affari Esteri e Averell Harriman, ambasciatore americano a Mosca
Nella fase finale della guerra erano già state prese importanti decisioni economiche e geopolitiche. Dopo gli accordi di Bretton Woods del luglio 1944, che avevano sancito una forte prevalenza degli Stati Uniti nella futura riorganizzazione economica e monetaria, nel febbraio del 1945, quando oramai la Germania nazista era in ginocchio, si svolse a Jalta, sul Mar Nero, la più importante conferenza fra i “tre grandi”: Churchill, Roosevelt e Stalin. Vennero in questa occasione definite le rispettive zone di influenza in Europa: in occidente gli angloamericani, in oriente i sovietici. La Germania sarebbe stata divisa in quattro zone di occupazione (russa, britannica, francese e americana), “denazificata”, demilitarizzata e condannata a pagare pesanti somme in riparazione. La Polonia perse territori a est mentre ne acquistò ad ovest a spese della Germania. Venne ribadito in linea generale il diritto all’autodeterminazione dei popoli, sempre tuttavia nell’ambito delle rispettive sfere d’influenza. Uno degli obiettivi di tali limitazioni consisteva nell’impedire una nuova scalata al potere mondiale come quella della Germania nazista. Venne creata inoltre l’Organizzazione delle Nazioni Unite, sulle ceneri della Società delle Nazioni, e dotata di un Consiglio di Sicurezza di cinque membri (USA, URSS, Gran Bretagna, Cina e Francia), che rifletteva lo spostamento del baricentro del potere mondiale al di fuori dei confini europei. Saranno infatti Stati Uniti ed Unione Sovietica a determinare i futuri equilibri internazionali.
L’assalto alla Germania

Avanzata dell'esercito americano a Wernberg, in Germania, nell’aprile 1945
Nel 1945, quando oramai gli alleati, sia ad est che ad ovest, erano entrati in territorio tedesco, le truppe angloamericane e sovietiche si incontrarono sul fiume Elba il 25 aprile, alla vigilia della caduta di Berlino. La Germania era un paese tutt’altro che prostrato: l’industria tedesca era giunta al massimo della propria capacità produttiva a partire dal 1944, grazie ad un utilizzo sistematico del terrore nel reclutamento e nell’utilizzo delle risorse umane. La produzione di aerei, ad esempio, toccò nel penultimo anno di guerra il tetto delle 40.593 unità prodotte su un totale di 113.514 in tutto il conflitto, mentre nel 1945 stava viaggiando ad un ritmo di 5.000 al mese. Fu soltanto la penuria di materie prime e la distruzione delle industrie che producevano il carburante sintetico a rendere inutile tale arsenale. Per stroncare definitivamente il morale della popolazione gli Alleati ricorsero ad un uso massiccio, soprattutto nel 1945, dei bombardamenti a tappeto sulle principali città tedesche: nel mese di febbraio toccò a Dresda la stessa sorte che poco più di quattro anni prima era toccata a Conventry, in Gran Bretagna: la città venne rasa completamente al suolo. Comunque sia gli angloamericani che i sovietici si scontrarono con un nemico che lottò accanitamente, anche sull’orlo della catastrofe.
La disperata resistenza di Berlino

: il 19 aprile 1945 le truppe sovietiche del generale Zukov entravano a Berlino. Già da tempo Hitler aveva predisposto la città alla difesa ad oltranza: erano stati reclutati gli anziani e i ragazzi di sedici anni di età, che vennero chiamati a morire per il Fürher.
Nonostante da parte degli Alleati vi fosse la volontà di arrivare ad una resa incondizionata e ad una vittoria totale sulla Germania, alcuni fra i più stretti collaboratori di Hitler, quali Goering ed Himmler, cercarono, segretamente e senza successo, di intavolare trattative per evitare una disfatta completa. Hitler, asserragliato nel bunker della cancelleria, condannò con disprezzo questo tentativo: egli, dopo aver nominato l’ammiraglio Doenitz proprio successore e accusato il popolo tedesco di non aver saputo essere all’altezza del proprio compito, si suicidò il 30 aprile assieme alla compagna Eva Braun e a Joseph Goebbels, ministro della Propaganda del Reich, che eliminò anche tutta la propria famiglia. Il 2 maggio i soldati sovietici, dopo aver conquistato metro per metro la città, issavano la bandiera rossa sul Reichstag; l’8 maggio la Germania nazista firmava la propria resa incondizionata.
La resa nazista

Detenuti in stato d'inedia, a Buchenwald nel 1945
Alla fine della guerra il mito del nuovo “Reich millenario” aveva ridotto l’Europa ad un cumulo di macerie e prodotto la più gigantesca ecatombe della storia dell’umanità. Per la prima volta una guerra aveva prodotto molte più vittime fra i civili che fra i militari, circa 35 milioni contro 15 milioni. I paesi investiti più a lungo investiti dalla guerra pagarono un prezzo enorme in vite umane: 20 milioni l’Unione Sovietica, 5 milioni la Germania, 6 milioni la Polonia. Di contro, dove non vi fu occupazione nazista le perdite, pur consistenti, furono tuttavia minori: la Gran Bretagna, che subì tra il 1940 e il 1941 pesanti bombardamenti, ebbe 386.000 vittime, mentre gli Stati Uniti 259.000, soltanto militari.
Ma in un altro ambito il nazismo e il popolo tedesco hanno lasciato la loro eredità più pesante: nella loro politica razziale e nello sterminio scientifico e sistematico delle minoranze “inferiori”, in particolare del popolo ebraico. Le leggi antisemite e le conseguenti persecuzioni, discriminazioni e le emigrazioni di massa coatte furono soltanto il logico prologo della “soluzione finale” intrapresa dopo il 1940. Gli “inferiori”, fossero essi ebrei, zingari, slavi, omosessuali, disabili, malati e oppositori politici, erano il cancro da sfruttare come schiavi, oppure da estirpare, in nome del criterio eugenetico del dominio “ariano”. La conquista dell’Est segnò la fase più brutale della repressione, che si scatenò feroce in particolare contro gli ebrei e gli slavi. Quando tuttavia i massacri sul posto si rivelarono poco adatti ad un completo occultamento dei cadaveri e spesso traumatici per gli esecutori (Himmler, il capo delle SS, restò sconcertato dallo “spettacolo” di abitanti di un grosso villaggio in Russia, costretti prima a scavare una grande fossa comune, poi eliminati uno per uno con un colpo di pistola alla nuca), allora si optò per i campi di sterminio. Fu allora che circa 6 milioni di deportati conobbero l’inferno sulla terra. Marchiati e suddivisi in categorie, i prigionieri abili venivano utilizzati come forza lavoro nelle industrie che sorgevano accanto ai campi; gli altri, vecchi, bambini, malati, venivano eliminati immediatamente. Alcuni di questi campi, come Auschwitz, approntato nel 1941, divennnero centri di sperimentazione di nuove tecniche di sterminio di massa, con i forni crematori per l’eliminazione dei corpi.
Le bombe atomiche e la fine della guerra in Asia
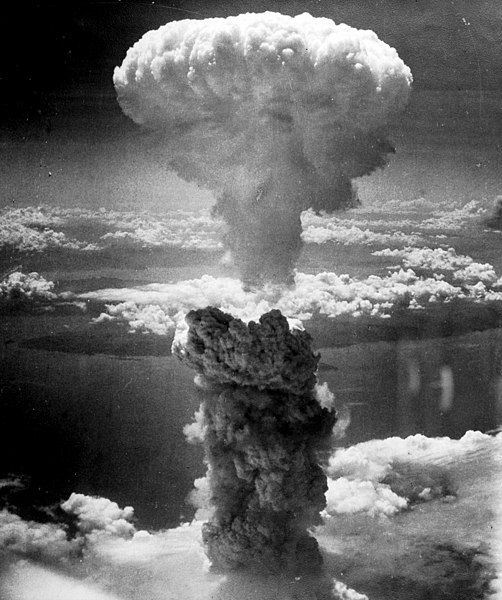
Il fungo atomico, causato dalla bomba atomica "Fat Man" su Nagasaki, raggiunse i 18 km di altezza
Terminato il conflitto in Europa, rimaneva per gli Alleati ancora aperto il fronte in Estremo Oriente dove, nonostante le decisive vittorie americane, il Giappone non si era ancora arreso. I devastanti bombardamenti che avevano colpito il paese e la dichiarazione di guerra da parte dell’Unione Sovietica non furono sufficienti a convincere il governo nipponico ad accettare la resa incondizionata. Un monito gli venne rivolto da Harry Truman, neopresidente americano dopo la morte di Roosevelt, e da Clement Attlee, neo primo ministro inglese, riuniti assieme a Stalin a Potsdam, vicino a Berlino, nella prima conferenza dei “tre grandi”, dopo la sconfitta nazista. Il 28 luglio l’appello venne giudicato dal Giappone, dove forte era l’ascendente dell’ala oltranzista dell’esercito sul governo, “non degno di nota”. Tuttavia, se giudicato alla luce dei nuovi equilibri mondiali e in particolare dell’enorme prestigio acquisito dall’Unione Sovietica, il braccio di ferro tra USA e Giappone assume un’ulteriore e significativa valenza: rappresentava infatti un’occasione per ridimensionare il peso sovietico nel panorama internazionale.

Il ministro degli esteri giapponese Mamoru Shigemitsu firma l'Atto di resa giapponese a bordo della USS Missouri mentre il generale Richard K. Sutherland osserva, 2 settembre 1945
Proprio durante la Conferenza di Potsdam, Truman venne informato del positivo esperimento della prima bomba atomica, avvenuto il 16 luglio ad Alamogordo, in Nuovo Messico, che aveva coronato con successo il “progetto Manhattan”, varato alcuni anni prima. Come ebbe poi a dire Churchill, presente anch’egli alla conferenza, dopo questa notizia Truman assunse un atteggiamento ben più baldanzoso verso i sovietici. La decisione di utilizzare per ben due volte la bomba atomica contro il Giappone nacque non solo dalla volontà di risparmiare altre vite di soldati americani nella continuazione della guerra, così come dall’ostinazione dei vertici militari nipponici, ma anche dal desiderio di ribadire la supremazia tecnologica e militare americana nei confronti dei sovietici: una preoccupazione squisitamente geopolitica costata la vita a 160.000 civili giapponesi.